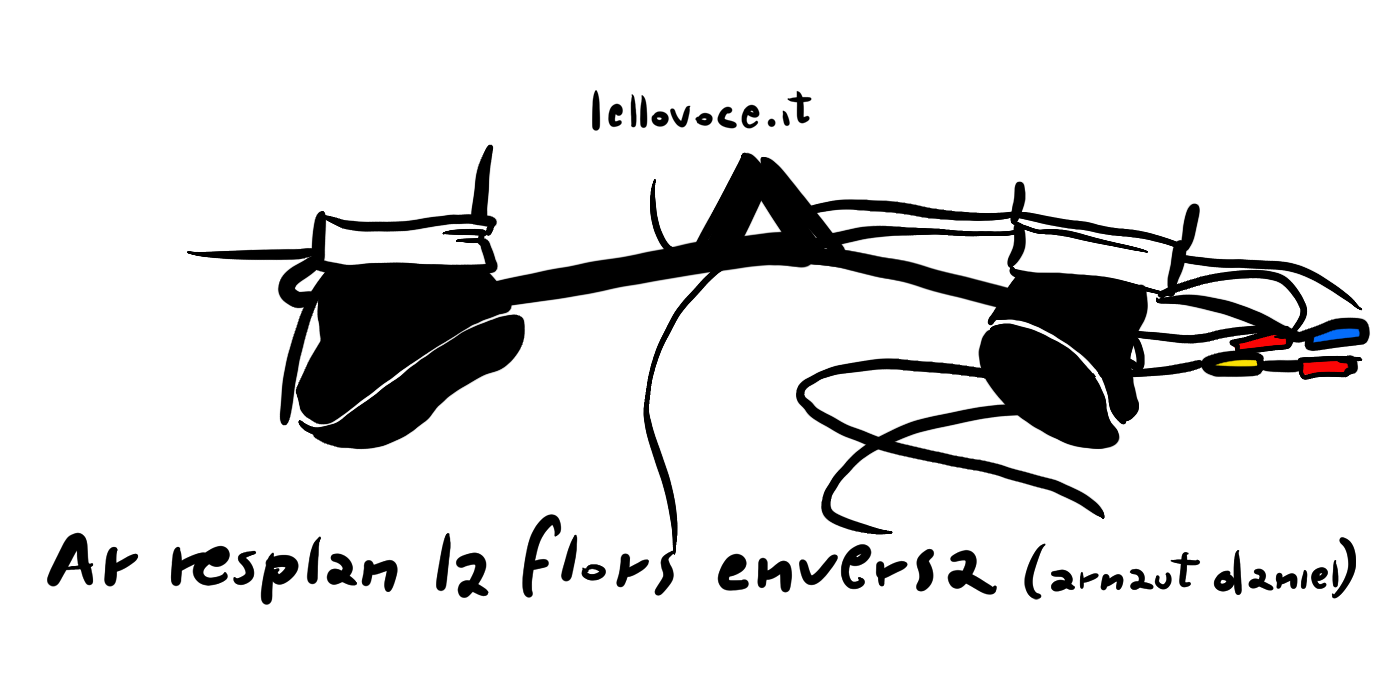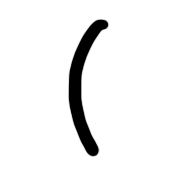Anche questo di Villalta (il primo del poeta liventino) è un romanzo sugli ‘anni di piombo’, e ce ne sono stati altri, alcuni ottimi, altri addirittura inutili, ma lo è in modo del tutto particolare…
Dei Settanta se ne parla, infatti, prima di tutto a partire dal punto di vista sghembo di un ragazzino, il figlio di una terrorista rossa, una scelta che, a volte, ricorda certe atmosfere del Calvino del Sentiero dei nidi di ragno, però incupito, interiorizzato, lasciato senza fiato: «Ma tuo figlio lo dovevi portare in combattimento, se volevi combattere. Ero grande abbastanza, ti ricordi? Uno che è grande abbastanza per stare solo, è grande abbastanza per tutto il resto. (…) No, non ti odio. A quattordici anni avrei fatto la rivoluzione con te. Ero grande abbastanza e tu lo sapevi.» E anche nel prosieguo della vicenda – mentre Riccardo cresce, diventa un uomo – di quegli anni si cerca di cogliere soprattutto un aspetto ‘interiore’ e personale, si guarda a quelle scelte con lo sguardo filtrato dall’essere ormai nell’enorme acquario dell’esordio del nuovo millennio, tanto diverso e pure altrettanto inquieto ed insoddisfacente.
Quando la madre è costretta ad abbandonarlo per seguire il suo destino, Riccardo viene affidato ad Adamo e Maria, una coppia di anziani partigiani, presso cui vivrà, dividendo la sua adolescenza con Ornella, la figlia della coppia. Ma, quando la madre muore in carcere, Riccardo abbandona la casa e va a vivere da solo. L’unico contatto col suo passato è Silvano, amico di sua madre, che dal momento della morte della terrorista, segue il ragazzo per tentare di indurlo a guardare con occhi diversi la scelta fatta dalla mamma. Ma perché qualcosa cambi nella vita di Riccardo, occorrerà che giunga l’affidamento di Sebastiano, il figlio che Ornella ha avuto da suo marito e che è rimasto orfano di entrambi i genitori e anche del nonno. E’ a partire da questo momento che qualcosa cambia in Riccardo, e pian piano, la memoria si avvia a diventare meno dolorosa.
Costruito – come un’antica tragedia greca – sullo scontro di forze e sentimenti essenziali,
in realtà il romanzo non è focalizzato sulle vicende politiche di quegli anni bui, parla di altro, dell’incapacità di conoscersi, del pudore maledetto che condanna alla solitudine senza scampo le parti migliori di noi, dell’incapacità nostra, infine, di guardare a noi stessi senza maschere. E di fare i conti con la tragedia che la Storia scatena quando irrompe nel nostro privato, ieri come oggi.
Formalmente il testo è il risultato raffinato di un lavoro paziente e certosino, sia a livello linguistico che strutturale, alla ricerca di una lingua essenziale, ma precisa, che non lasci spazio alcuno all’improvvisazione, mentre l’andamento cronologico della vicenda, per quasi tre quarti del testo, si comporta apparentemente come la pallina impazzita di un flipper: avanti e indietro nel tempo, attraverso capitoli intitolati soprattutto a Riccardo e Sebastiano, su e giù lungo i sentieri di due storie lontanissime, di due punti di vista apparentemente inconciliabili e lontani, tanto perpendicolari da essere assolutamente paralleli, senza riuscire, per molto tempo, ad incontrarsi per davvero, due storie che così tendono a piegarsi l’una sull’altra, in un vorticoso cambio delle focalizzazioni, un toboga diegetico, da cui si scivola poi verso la conclusione nel succedersi consequenziale dell’ultima parte.
E i panorami della vicenda sono panorami interiori, sfondi d’anima e sentimenti, territori di parole, ma, quando lo sguardo oltrepassa i personaggi, i loro dubbi, la loro fatica a sopravviversi, si scopre un’acuta capacità dell’autore di disegnare squarci sghembi di un Nord Est veloce e distratto, muto e cieco, magari, ma decisivo nell’organizzare i destini dei singoli.
Non fa gran che, poi, che il finale scelto (o la chiusa si è scelta da sé?) forse potrà sembrare ad alcuni troppo ‘lieto’, viste le premesse, ma giunge, infine, come un respiro libero, dopo un’apnea di parole e sentimenti e, certo, non riesce a affrancare il lettore attento da quel senso profondo del testo, che ne è la qualità più evidente, e che a me è sembrato di sentir risuonare, semplice, schietto ed essenziale come una staffilata, a inizio della Terza Parte, in una frase di un capitolo (l’unico) intitolato a Silvano: «Ci vuole tempo per voler bene, e nessuno ne ha più.»
Gian Mario Villalta
Tuo figlio
Mondadori