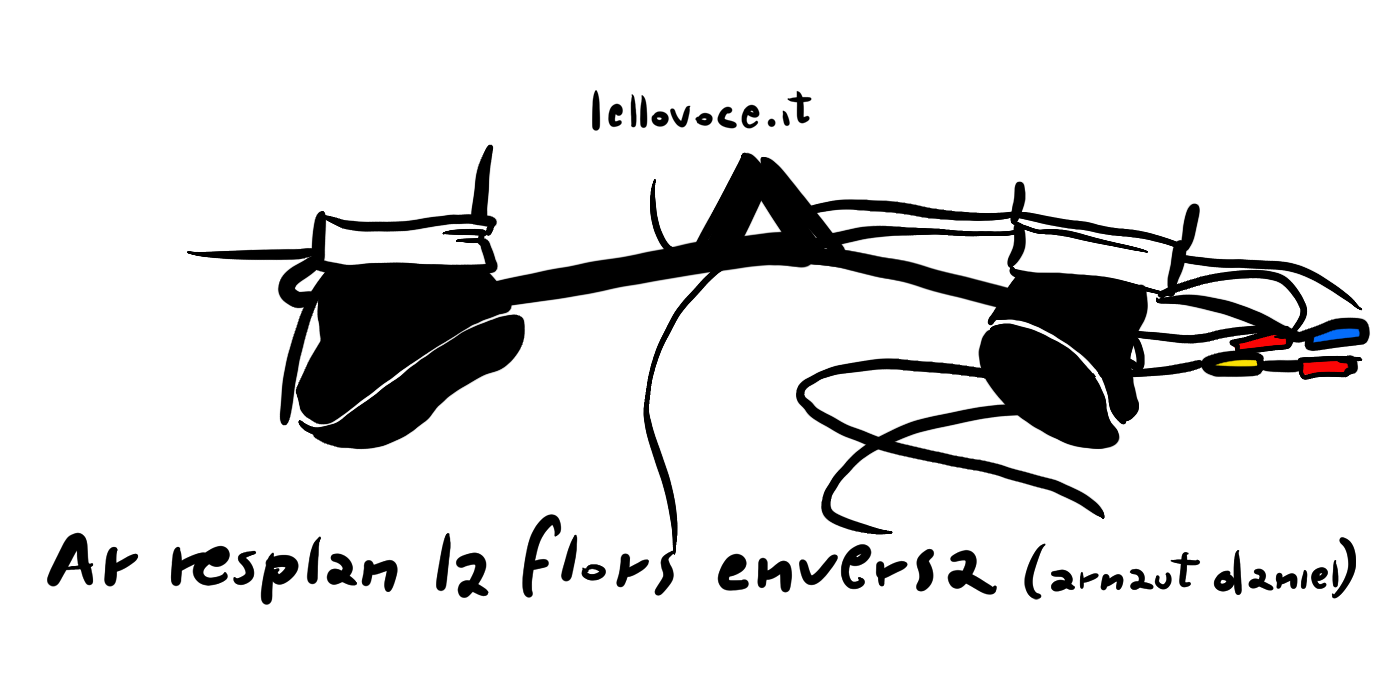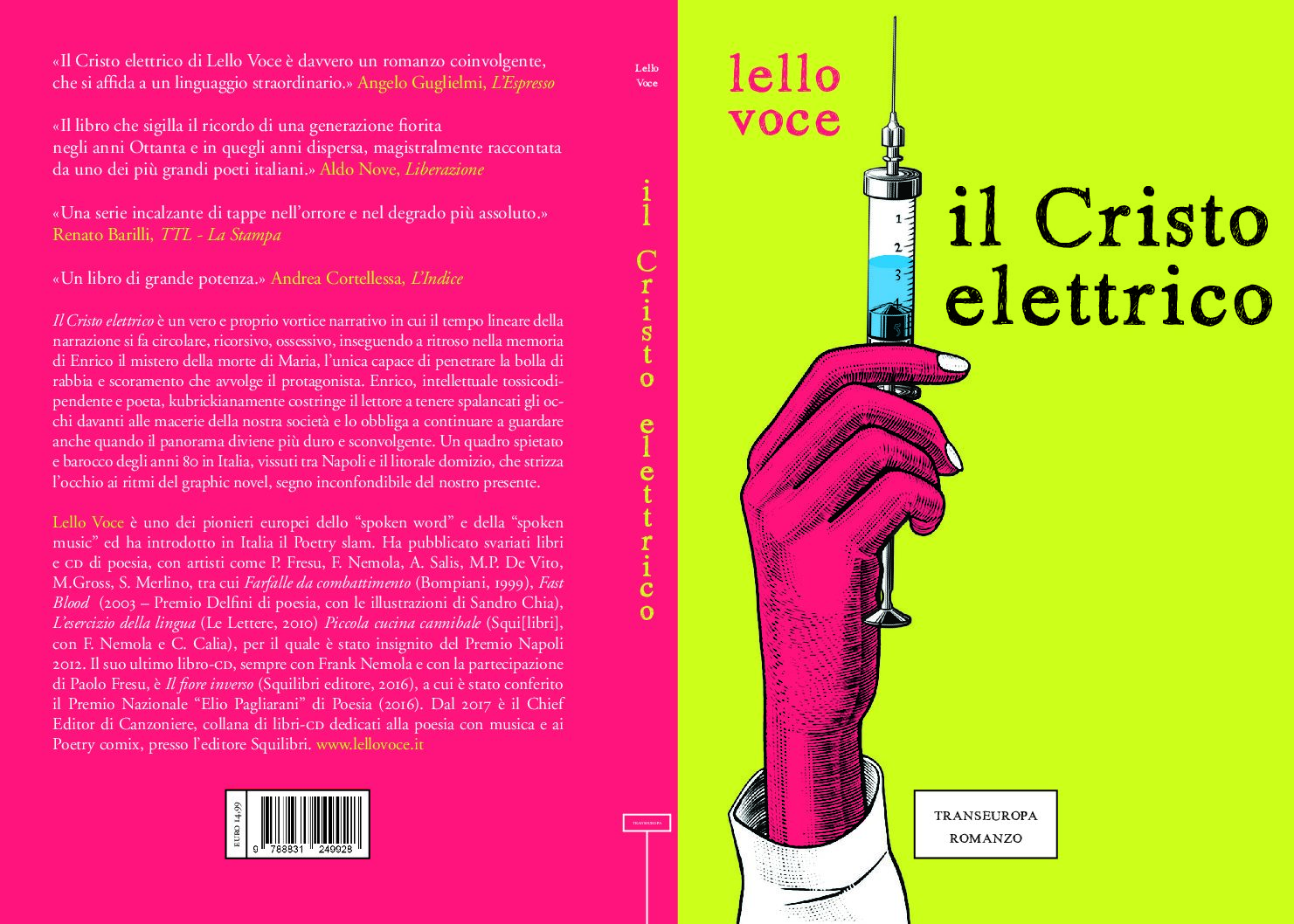Tempi di fuga nell’abisso, questi della narrativa italiana: Come se voragini di paura si aprissero sempre più fitte e lo scrittore di cose della vita non potesse esimersi dal raccontarle e insieme precipitarci dentro.
Lello Voce c’era già dentro coi suoi primi due romanzi(Eroina e Cucarachas), ci resta con questo terzo ancora di più, se possibile, si cala nella fogna che è il vivere comune: visto dall’angolo del tossico, e quindi dal cupo più cupo della disperazione. Perché c’è l’essere tossico nell’acquiescenza del pensiero vegetale, che in quanto si vegetalizza in toto e rende solo oggetto il suo sé, e c’è l’esserlo nella morsa lucida e tuttavia impotente dell’autocoscienza che riconosce mentre le pratica, le vie della catabasi, facendole insieme linguaggio e condanna di sé. Raccontandole in disperata simbiosi tra volontà di fuga e resa da rifiuto escrementizio.
E’ questo il personaggio dell’Enrico de Il Cristo elettrico, io narrante e proiezione letteraria dell’autore: rifiuto escrementizio di quello che fu un uomo che racconta la storia del suo sé, K. Kafkiano qualsiasi ridotto all’unica possibile interlocuzione con Teo, uno scarafaggio depositario, solo lui, della saggezza della vita dentro lo sterminato verminaio che è la realtà: attraversata e vissuta nella scombinata vicenda di un gruppo di reietti solo intenti a procurarsi la dose minima quotidiana di «buona bella», come la chiamano loro, in un delirio di violenza inflitta e subita, tra la scimmia che li divora e il mondo che li respinge. Mondo senza innocenti né possibili né reali. Che se a volte li accoglie lo fa a modo suo, restringendoli nell’inferno carcerario che fotocopia la realtà sottolineandone in rosso l’aspetto fetido e accettato del gratuito esercizio della prevaricazione del forte sul debole. Sempre e ovunque.
Il romanzo ha due storie. Una, di un po’ di giorni di un gruppo di tossici in giro per le strade su un’Alfa rossa alla ricerca della dose – sopravvivenza, tra periferie sbrilluccicanti – in cui anche il Cristo inalberato sul pinnacolo di una chiesa si psichedelizza di luci elettriche – e inferni sotterranei di una Napoli capitale del regno penetrata dentro viscere che inghiottono e vomitano violenza e perdizione senza fine, conclusa con l’estasi finale di uno sballo in cui si incontrano Eros e Thanatos, con la prostituta Maria trovata morta all’alba dopo l’amore furioso con Enrico ancora imbambolato e incapace di ricordare; e un’altra susseguente e parallela alla prima, che comincia dove la prima finisce e viene raccontata in un incontrario temporale, dalla fine all’inizio, dove protagonista è ancora Enrico che scrive alla madre dal carcere, scoglio – galera, in cui lo ha precipitato l’accusa di stupro e omicidio e spaccio di droga e chissà che altro. Per un insieme di venti stazioni, dieci di storia-uno, vista da fuori, e dieci di lettere-storia-due, viste dall’interno, graficamente differenziate e procedenti intrecciate in sincrono compositivo, nella circolarità temporale dell’eterna condanna: a sottolineare l’insussistenza di tutte le categorie spazio-temporali su cui l’umanità ha costruito storia e cultura del suo essere. Dove il prima e il poi si confondono e andare avanti è andare indietro, à rebours. Come nei tempi e nelle culture di ogni fin de siécle. Qui ridotte, storia e cultura, a peso e dileggio, a cosa, più che inutile, controproducente nel bagaglio di Enrico, professore di liceo e poeta di qualche speranza prima di diventare tossico a tempo pieno, solo ammesse nella mente del Teo scarafaggio (già stato in una vita precedente dotto cattedratico di Salamanca) e nei muti colloqui fra i due. Presenti però nell’articolato del discorso, costantemente richiamate nel riflesso del linguaggio cui l’io narrante di Enrico non può sottrarsi. Ma in maniera tale che il grottesco dei fatti trae parte del suo effetto urticante proprio dall’impreziosirsi di questo retroterra. Che è poi il lievito di cui si nutre il vero straordinario elemento costitutivo che fa di questo libro qualcosa di più di un libro sull’essere tossici pensato dalla condizione dell’essere tossici. Ed è lo stile, la lingua, la performante tensione espressiva che alimenta il racconto.
Non è questione di scintillante gergalità, che se fosse tale diventerebbe nient’altro che mimesi magari di superiore effetto. Qui la lingua è è rimodulazione complessiva dell’essere dentro, che comprende anche l’essere complesso del mondo circostante, raccontato e ritratto nell’ironico scintillìo di un’invenzione continua capace di sconfinare nel barocco di effetti costruiti con gli artifici della retorica e gettati in faccia al conformismo dell’espressività corrente. Alla ricerca non più di una poesia-sogno-alla-presenza-della-ragione, quanto di un esprimersi violento alla presenza di un incubo, che fa incubo la lingua e insieme la rende corposamente letteratissima, infrangiandola di letteratissime presenze. Come fossero, queste presenze, fedriane margherite nello sterco, di nessuna utilità e di discutibile bellezza dove tutto è sterco e dove anche lo scarafaggio Teo vive di sterco. E tuttavia segno di un Eden che è andato perduto, di un «mondo che fu» irrimediabilmente sepolto dal tanfo del «mondo che è».