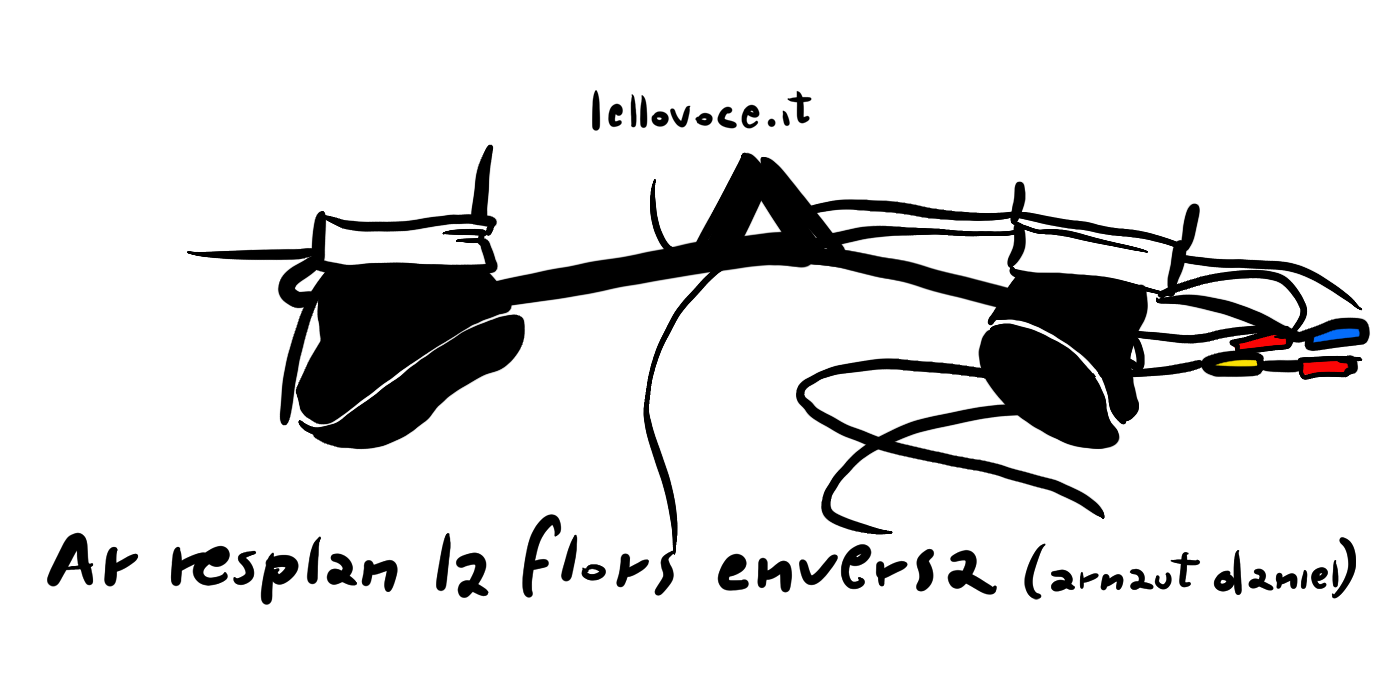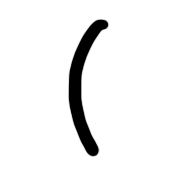Vorrei iniziare questo mio intervento con alcune premesse che mi paiono di qualche rilevanza la prima delle quali è che a questo dibattito che pur è certamente ancora al suo inizio hanno sinora partecipato o critici e storici della letteratura (Luperini, Dombroski), o critici-poeti (Fortini, Leonetti) che, però, in questo caso, mi pare abbiano privilegiato in maniera più o meno evidente il capo strettamente teorico-analitico dell’endiadi professionale che li riguarda. Così, le righe che seguiranno hanno la sorte di essere le prime che si proporranno strettamente come contributo di un “facitore di versi”. Ciò comporta evidentemente una serie di conseguenze che vanno dalla curvatura particolare del discorso teorico che pur tenterò di fare (e che si vorrà sempre strettamente contaminato dalla prassi, letteralmente grounded in the praxis, evitando, per quanto possibile, gli scogli di analisi troppo ardite o generali), fino all’allargamento dei confini del dibattito a sedi ed interventi paralleli derivante, credo abbastanza immediatamente, dalla messa in gioco delle “poetiche”. Penso di poter affermare che, da un certo punto di vista, questa nostra discussione possa essere intesa come tessera di un più vasto mosaico che, pur incardinato sulle medesime problematiche (Moderno/Postmoderno, Avanguardia/Tradizione, Autonomia/Eteronomia), si è sviluppato su coordinate più ampie, coinvolgendo direttamente (e, spesso, polemicamente), come ulteriore tessera, le vicende collegate alla nascita e allo sviluppo del Giuppo 93 e del neo-allegorismo ad esso geminato. Terrò dunque conto dei succitati interventi, ma anche di ulteriori contributi di Fortini, Luperini, Ceserani, Bettini, oltre che di alcune relazioni presentate nel corso del Convegno senese del ’90 (ad es. quella di Capozzi). A questo proposito vorrei sottolineare come, a mio parere, e almeno per quanto riguarda direttamente la discussione sulle “poetiche”, i termini della discussione siano stati assati a volte in maniera assolutamente bipolare e non possano non ricordare, nella loro articolazione rigida, quei «giochi a somma zero» d’ambito teorico-matematico citati in un pamphlet di P. Watzlawick, secondo i quali tertium non datur (della serie: una norma o si trasgredisce o si applica, in una discussione o si ha torto o si ha ragione, ecc…). Credo sia in base a logiche di questo tipo che per Fortini la discussione teorico-letteraria all’interno di un gruppo, o il tentativo di dai vita ad una tendenza sono, tout court, assimilabili a una riproposizione dell’aborrita avanguardia, e per Bettini il dissenso profondo dei componenti del Gruppo 93 nei confronti delle manifestazioni più viete della vague post è segnale di fede integerrima nel Moderno. Ciò che si rischia, in questo modo, è di perdere in partenza – depistati dalla ricerca di “ipersoluzioni” – quella scommessa con la “complessità” che recentemente E. Morin ha indicato come compito fondamentale della nostra contemporaneità.
Coerentemente con la prima delle premesse vorrei subito precisare che non entrerò nel merito dell’esistenza o meno di “invarianti” politico-storico-economiche che costituirebbero un trait d’union tra Moderno e Postmoderno. Non mi domanderò, dunque, se la “rivoluzione informatica” detenga o meno, a questi livelli, la medesima importanza delle rivoluzioni industriali. Che siano o meno evaporate le “invarianti” di cui sopra credo, però, non si possa fare a meno di ammettere che ci troviamo di fronte a una mutazione di ragguardevole portata, provocata dalla telematizzazione e dalla informatizzazione della vita contemporanea. Una sorta s di natura “seconda” (terza, quarta, ecc…), tutta telematica e tecnologica, tende a sovrapporsi alla prima, causando, in prima istanza, una variazione, credo evidente, nella nostra percezione e nella nostra stessa esperienza del reale per la quale l’immagine si sostituisce sempre più alla cosa, innalzandone il tasso di virtualità, sino al punto di rischiare di trasformare la percezione di questa virtualità (ormai dilagante) in una vera e propria percezione virtuale. Ciò comporterebbe, ovviamente, una serie di conseguenze a molteplici livelli tra cui: a) la necessità di uno sforzo per raggiungere una calibrazione nuova del concetto stesso di reale che, per molti versi, mi pare già in atto e che ha raggiunto esiti assai interessanti soprattutto a livello epistemologico (A. Elkana, E. Morin) e semio-culturologico (Lotman), esiti che, a mio parere, coinvolgono direttamente il campo letterario stesso, se non altro nel suo confrontarsi (assolutamente necessario) con l’extra-testo; e b) un aumento massiccio dell’estetico nei confronti del politico, una sorta di estetizzazione selvaggia delle comunicazioni sociali che ha provocato una loro sempre maggiore superficializzazione (e di ciò non sono andate esenti molte mode e prassi artistiche):
ci si trova di fronte ad una tendenza alla riduzione dei linguaggi a patine, all’elisione di ogni forma di vero dialogo e comunicazione, ottenuta attraverso la pletorizzazione dei segnali. Non credo potremo esinierci dal confronto con la realtà di questa locupletante virtualità; essa sembra insegnarci, insieme, che le parole (i segni), certo, non sono le cose ma che esse, pure, sono per proprio conto (in un certo modo) cose, dotate di una propria realtà, di una loro propria dinamica, di loro propri effetti reali. Ma su ciò tornerò più avanti.
D’altra parte, per passare all’oggetto sin ora non esplicitato di queste mie righe, il rapporto Moderno/Postmoderno, come recentemente notato da H. Belting (La fine della storia dell’arte o la libertà dell’arte, 1990) una delle principali conseguenze della querelle è stata proprio una rivalutazione retrospettiva del “moderno classico”, costituendo, probabilmente, l’atto finale della sua canonizzazione, del suo ingresso nel museo. Credo di poter concordare con lo storico dell’arte tedesco quando egli sottolinea che «se tale sguardo retrospettivo è possibile, vuoi dire che noi occupiamo una posizione diversa, fin troppo spesso definita con il problematico termine alla moda di postmodernismo». E non è detto che, più o meno a breve, lo stesso non sia possibile affermano anche per il Post (e le vicende relative alla mutazione di eponimo sussidiario da parte di una rivista storica dei Post come Boundary 2 sembrerebbero confermarlo). Tutto quanto sinora esposto (per quanto frammentaria e lacunosa ne sia stata la maniera) mi pare indichi l’esistenza di una condizione di postmodernità all’interno della quale noi oggi ci muoviamo, delle cui peculiarità e caratteristiche sarebbe qui inutile ricompilare un sin troppo conosciuto elenco. Da questo punto di vista mi sarebbe difficile non concordare con Fortini quando, con la usuale acribia, denuncia il pericolo di un nostalgico «regresso al Moderno» ma, d’altro canto, non mi pare che ciò comporti come immediata conseguenza che «la città di oggi» non «abbia [..] a che fare con la Parigi di Benjamin», né mi sembra che tali caratteristiche di “regressiva” modernità possano essere attribuite all’ipotesi luperiniana dell’allegorismo. Per dirla con le parole di Luperini stesso, la «proposta di una direzione di senso [..], la consapevolezza della sua relatività ma anche di una necessaria assunzione di responsabilità e parzialità […], il carattere dialogico, pragmatico, dunque intrinsecamente sociale» dell’atteggiamento “neo-allegorico” non mi pare abbiano rapporti esclusivi col Moderno (o, eventualmente, col Post) bensi, più in generale, col fondamentale problema del che fare?, col problema della contemporaneità. Né mi pare condivisibile l’equazione fortiniana Moderno = Avanguardia, ché credo Avanguardia ed allegorismo siano stati solo alcuni aspetti di un fenomeno vasto e complesso che ne ha avuti molti altri, talora opposti (simbolismo, ermetismo, ecc…, ecc…). A voler esulare, per un momento, dal campo strettamente letterario, si potrebbero utilizzare alcune osservazioni di Belting che indica una possibile bipartizione delle concezioni del Moderno: a) il moderno come finale adempimento del canone, segnale di esaurimento dell’espressione artistica occidentale; e b) il Moderno come taglio, perdita, delegittimazione della tradizione. Ora, se fosse vera l’ipotesi (a) ciò che spesso da Fortini (tra l’altro cfr. il manifesto, 11 gennaio 1991) è stato bollato come «manierismo» inutilmente ridondante, prodotto riciclato del «mercato di Harrar», potrebbe costituire proprio la coscienza dell’esaurimento del canone occidentale e, dunque, la trasformazione della «produzione artistica» in «storia dell’arte applicata […] e, in opposizione a tale destino, uno sforzo radicale di sottrarsi all’eredità storica» (Belting). Concordo con lo studioso tedesco sul fatto che «liquidare tutto ciò come nostalgia e come mancanza di coraggio significherebbe sottovalutarne il significato». Mi lascia, comunque, perplesso che Fortini neghi a quei «volenterosi ed anche intelligenti giovani», frequentatori, a suo dire, di Harrar (e in cui, forse con qualche ragione, mi pare di poter identificare me sodalesque), quella «paradossale legittimità dei manierismi» contemporanei pure affermata nell’Opus servile ospitato nel primo numero di questa rivista. Se, invece, fosse vera l’ipotesi (b) quel taglio non potrebbe, oggi, non riguardare il Moderno stesso, in quanto tradizione del moderno e ciò, probabilmente, rischierebbe di rendere pleonastico l’accanimento fortiniano nei confronti dell’Avanguardia e del Moderno.
Ma, ora, per tentare di comprendere le ragioni di questa (almeno apparente) contraddizione fortiniana vorrei tentare di ribaltare il problema per sottolineare come, paradossalmente, questi termini (Moderno e Post) mostrino una loro reciproca permeabilità, se non altro a livello stilistico-letterario. Come notato da Capozzi, molti dei parametri strettamente formali del Post «possono essere usati per la letteratura del Moderno e […] per molti versi essi richiamano pure la letteratura della neoavanguardia». Esisterebbero, dunque, come delle invananti stilistiche che unirebbero il Post al Moderno e viceversa ed i casi della citazione e del montaggio mi paiono tra i primi esempi che possano venire alla mente.Citano e montano il Moderno e le sue avanguardie (storiche e neo) e cita e monta il Postmoderno, il cui pastiche è posto sotto accusa da Jameson. Ma citano e montano anche alcuni degli autori del Gruppo 93 che, per parte loro, sembrano assai restii ad essere, tout court, inglobati nell’uno o nell’altro campo. Tentare, come farò di seguito, di individuare di nuovo diversità là dove ho appena adesso tentato di porre una continuità potrà, forse, suggerire la complessità della rete problematica cui, a mio parere, ci troviamo di fronte. A guardar meglio si potrebbe allora precisare (per tentare una prima, rozza tassonomia) che, laddove l’uso che di citazione e montaggio fanno le neo-avanguardie (e le storiche) è un utilizzo combinatorio e insieme un sabotaggio (come direbbe Fortini) uno “smontaggio” (un decollage?) che tende all’interruzione sperimentale e “critica” della comunicazione, caricandosi di negatività, l’uso postmoderno del pastiche, almeno nell’accezione jamesoniana, è, au contraire, strumento d’occultamento dell’autre, creazione di una patina anodina fondata sull’interscambiabiità assoluta delle tessere del mosaico, in cui ognuna perde la propria contraddittoria individualità a favore dell’uniformità grigia che nasconde il souffle della macro-ideologia più o meno occulta del consenso, valorizzando il polo altro, apparentemente pregno di positività, del consenso celebrativo quotidiano-monumentale. Ancora diversa, almeno per quanto riguarda gli intenti (e, va da sè, tra il dire e il fare sta il mare di una difficile ricerca di una problematicissima “contemporaneità” dello stile), è la proposta che giunge da alcuni dei componenti del Gruppo 93, fondata sull’assunto della ripresa di una comunicazione ormai data come virtuale ed interrotta, in cui il montaggio è un ri-montaggio, un riuso teso a ricostituire la possibilità di un dialogo e di una reale comunicazione, senza per questo nasconderne le aporie, le interruzioni, le ferite, le contraddittorietà, spostando la carica tutta sul terzo polo, quello della ricostruzione propositiva, della fertile creolizzazione dialogica da cui, a loro parere, sembra nascere il senso. Alla combinatorietà, alla sua scomponibilità viene opposto un testo praticato e progettato come segno, insieme, integrale e labirintico, olistico, che tende nuovamente alla produzione di senso, che si confronta di nuovo, anche se in maniere necessariamente mutate e complessificate, con quello che vorrei defmire lo zoccolo duro del significare. Mi sembra, a questo proposito, che per Fortini, invece, davvero tertium non datur: o si cita e si monta «per smascherare e sabotare», e si è paleo-moderni frequentatori del mercato d’Harrar (col risultato di produrre un manierismo decorativo, interessante solo per «i vicini di collegio o di gruppo»), o lo si fa attraverso la «radicale rinuncia a negare alcunché» e da ciò ne deriverebbe la «paradossale legittimità». La possibile esistenza di un terzo polo, contemporaneamente postmoderno e non conciliato non sembra a Fortini nemmeno ipotizzabile. Devo dire che ho letto con estremo interesse il contributo di Capozzi al dibattito senese proprio perché esso parte dall’assunto della possibile esistenza di un’analisi critica del reale e di una pratica non conciliata della letteratura che si alloghino all’interno del Postmoderno stesso, di un testo poetico che sia, in uno, postmoderno ma non pacificato e consensuale, irenico, anche se non posso associarmi all’autore (che mi pare in questo caso assai vicino a certe tesi di Fortini) nella fiducia (mutuata dalla Hutcheon) che egli nutre nei confronti della “giocosa discontinuità”, dell’ironia e della parodia che corroderebbero dall’interno ciò che non può più esserlo dall’esterno. Non credo che i romanzi di Eco possano essere esemplati come segnali di un atteggiamento postmoderno non conciliato, mentre concordo con lui sul fatto che autori come Phyncon, Barth, Barthelme meriterebbero maggiore attenzione di quella di cui godono, anche presso alcuni sostenitori di ipotesi ‘neo-materialistiche” e/o “allegoriche”. Da questo punto di vista vorrei ribadire che la nozione di postmodernismo critico, così come essa è stata proposta da parte dei componenti di Baldus all’interno del Gruppo 93, tendeva proprio a sottolineare un’ipotesi del genere, e Luperini lo ha lucidamente sottolineato (il manifesto, 3 maggio 1991; Baldus, n. 1, 1991); mi paiono, dunque, immotivati i rilievi avanzati da Ceserani al Gruppo (il manifesto, 26 aprile 1991), sostenendo che veniva sottovalutata una possibile distinzione tra una condizione di postmodernità e il postmodernismo come ideologia. Postmodernismo critico è certo etichetta per molti versi infelice e non esaustiva (come tutte, d’altronde), ma che pure, nella sua evidente “ossimoricità”, vuole indicare una possibile fase successiva del dibattito e della prassi letteraria, tendendo a favorirne un’ulteriore articolazione che vorrebbe porsi oltre il Postmoderno stesso.
Comunque sia, penso che al di là di tutto ciò, abbia poi ragione Luperini quando precisa che il vero punto di questa nostra discussione «è se si ritiene dawero inutile ed anzi controproducente un’azione che si svolga oggi sul terreno della cultura e della letteratura». A questo proposito, non mi pare possa essere messa in dubbio la necessità di una rivalutazione del ruolo e delle funzioni dell’immaginario ai fmi di un mutamento del reale, e si pensi alle ricerche di B. Baczko, di C. Castoriadis, o, per rimanere in un ambito più propriamente marxista, di P. Ansart. Qui non si tratta, credo, di sottrarre alle poetiche i coefficienti minimi indispensabili d’autonomia, nè di rinominarle mosche cocchiere di una qualche improbabile rivoluzione, ma non credo che un testo possa essere più autonomo od eteronomo dell’uomo che lo produce ed è questa sua antropologicità che inevitabilinente ci riconduce all’extra-testo: è un problema etico, prima ancora che politico o letterario, che mi induce ad allontanarmi sospettoso da quella che, con parole di Gadda, potrei definire la «bugiona nera» dell’irenicità e della trasparenza. La politica culturale della sinistra (storica e non) in Italia spesso ha rischiato di essere un vero e proprio buco nero nella strategia complessiva: agli “altri” è stata lasciata, spesso con superficiale nonchalance, la possibilità di colonizzazione dell’immaginario sociale, ignorando ostentatamente quegli effetti “reali” delle parole, delle immagini, delle culture su cui mi sono soffermato all’inizio di questi appunti; e vedere che sulle pagine di un qualche quotidiano della sinistra (sulla stessa pagina, a volte) possano felicemente coesistere analisi neo-lukacsiane ed altre schiettamente neo-heideggeriane e che esse possano addirittura trovare accordo sostanziale nella proposta di un certo numero di autori comuni, individuando pattuglie che fanno pensare più a cinquine elettorali che a crestomazie critiche, non può che confermarmi nei miei timori. Da questo punto di vista, nelle tesi fortiniane non mi pare alberghi alcuna musiliana “nostalgia del futuro”; tese come sono a restringere il campo d’intervento del culturale ad una «razionale collaborazione alle forze sociali» del mutamento (quali? ed in che modo? e ciò comporta necessariamente l’adozione della «sublime lingua borghese»?) esse mi pare ripropongano gerarchie sin troppo conosciute e certo, ad oggi, non fertili. Davvero, allora, non ci rimarrebbe che affidarci al “vecchio Iddio”; e comunque questa “negatività” fortiniana non può non ricordarmi, paradossalmente, quella «incapacità di mettere nella propria protesta la speranza di un nuovo assenso al mondo» di cui R. Barthes nel ’56 faceva carico proprio alle avanguardie. Ma la ventura, e credo inevitabile, società interetnica non si porrà solo come problema economico-sociale, ma anche, e con altrettanta pregnanza ed importanza, come puzzle antropologico-culturale ed è in base a queste prospettive che, credo, andranno ridefmite nuove ipotesi di ruolo. Davvero non mi pare, oggi, riproponibile l’ipotesi d’avanguardia, se non altro per conclamata latitanza di storicismi e teleologismi ad essa indispensabili, ma mi pare che ciò non comporti, tout d’abord, l’assenza di conflittualità e rotture, né di una possibile dinamizzazione della semiosfera letteraria che tenda alla problematizzazione e alla complessificazione della comunicazione poetica per renderla di nuovo atta alla produzione di senso. Le ricerche di Lotman e Morin sui rapporti tra centro e periferia nella semiosfera culturale e su quelli tra ordine e disordine a livello più ampiamente epistemologico, mi pare suggeriscano la fine dell’epoca delle «contrapposizioni radicali come praticate dalle avanguardie» (Luperini) a favore di un’altra che qui vorrei definire, con logotipo moriniano, delle “relazioni complesse”, nella quale non vada persa la caratteristica di dinamicità dell’Avanguardia e in cui, sottratto alla distorsione storicista, l’operatore rassomigli più a Marco Polo, esploratore del Catai, che a Ivan Ilic rossodirigente la presa del Palais d’hiver,o al Cortigiano di castiglionesca memoria. C’è, forse, bisogno di uno sforzo che ci porti oltre il manicheo bipolarismo Avanguardia/Tradizione, che trasformi i due poli dell’insoluto dilemma in tessere di un mosaico multipolare di relazioni complesse, gestito attraverso un pensiero che sappia essere, per dirla con Elkana, un two-tier thinking. In ciò, e proprio grazie alla multiversa contraddittorietà del suo pensiero, credo che la lezione di Benjamin possa essere utilissima, a meno che, con un guizzo di persistente “cattolaicismo”, non lo si voglia rubricare per flagranza di misticismo, senza mediazione alcuna, all’anagrafe decostruzionista.
Previous Reading
Continue reading
Il Poetry Slam: diritto alla poesia
21 Dicembre 2003
Tutto è cominciato nel 1987, in un club nemmeno troppo noto dell’Uptown di Chicago il Green Mill, di Dave Jemilo,...
Next Reading
Continue reading
Cipolle e Libertà
27 Dicembre 2003
Erano, mesi, forse anni ( e comunque a me, ormai, sembrano secoli) che accendere la TV era come aprire un...