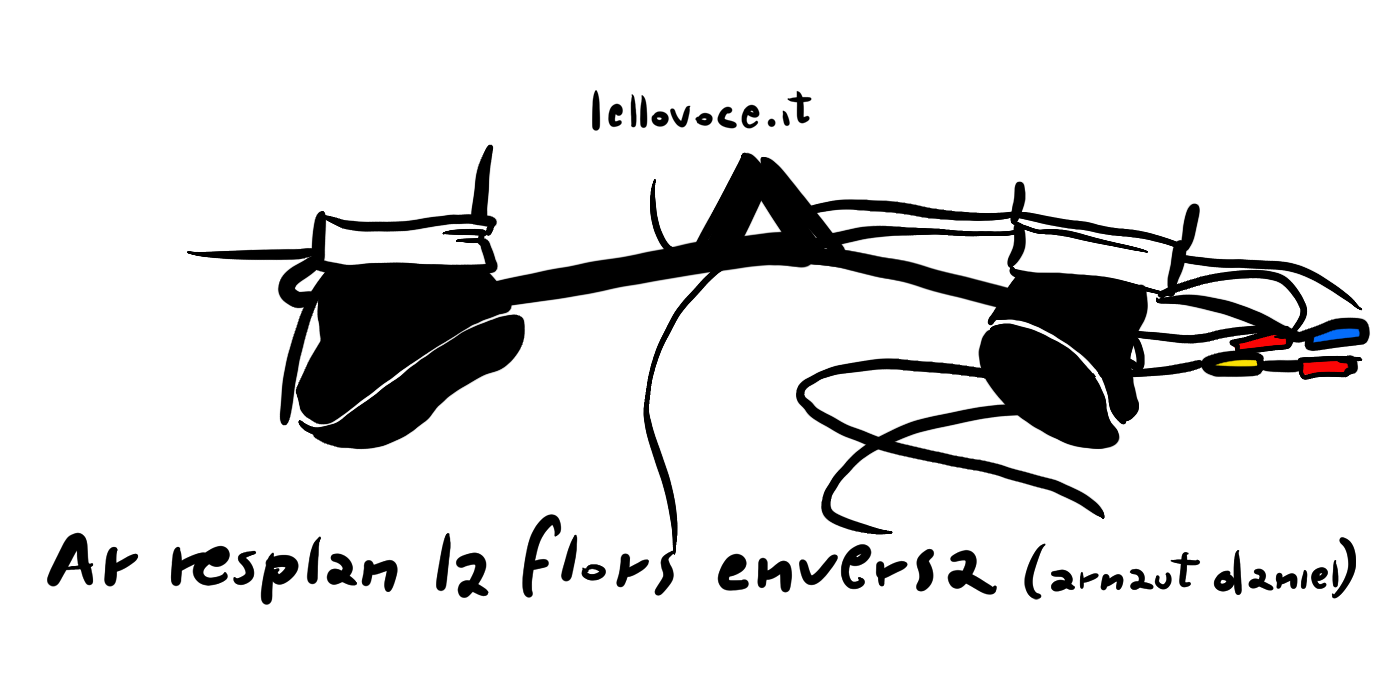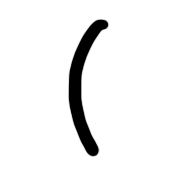Sandokan – si sa – è un eroe buono, Sandokan è la Tigre della Malesia: quale sottile gusto antifrastico (quasi verghiano, in odore di Malavoglia!) avrà mai spinto un cammorrista come Francesco Schiavone – uno dei leader più crudeli e spietati della criminalità campana – a scegliersi un soprannome così?
Gli bastava avere capelli e barba alla Kabir Bedi, probabilmente, anche perché le famiglie dei Casalesi non avevano certo le velleità ideologiche dei loro avversari ‘cutoliani’, non si sono mai considerate un antistato, piuttosto una banda capace di controllare territori con violenza e ferocia inusitate e avere, parallelamente, iniziative imprenditoriali d’alto bordo, globalizzate: a San Cipriano si parlava (in molte lingue) essenzialmente di profitti, tanto quanto ad Ottaviano, nel castello di Don Raffaele, i medesimi discorsi (in vernacolo stretto), venivano mascherati e gabellati da ‘giustizia popolare’.
Ma quest’ultimo romanzo di Balestrini, Sandokan, per l’appunto, più che delle vicende connesse alla guerra di camorra nell’agro casertano, o delle ‘gesta’ di Schiavone, parla poi soprattutto di un intero paese e della sua deriva, dell’incapacità di vedere il confine tra bene e male, tra giusto e ingiusto, tra legalità e cammurrìa, in una campagna infeudata in cui la postmodernità è giunta solo sotto forma di armi tecnologicamente avanzate e di status symbol (auto di lusso, telefonini, barche) che l’uso di quelle armi consente di acquistare. Sandokan è la storia di un paese, narrata attraverso la voce di uno dei suoi cittadini, con le parole e i sentimenti di uno della tribù, che però non ne condivide le scelte e che anzi ne sottolinea le enormi contraddizioni.
Sono anni terribili, gli anni in cui più a Sud, a Torre Annunziata, il clan dei Nuvoletta decideva l’assassinio di Giancarlo Siani, coraggioso cronista napoletano che da tempo denunciava i crimini della camorra, e tra San Cipriano di Aversa, Cancello Arnone, Mondragone in quegli stessi anni (ed oggi non è poi cambiato gran che) i paesi erano ridotti dai Casalesi di Bardellino e Schiavone a territori di guerra, con ronde e regolamenti di conti quotidiani, luoghi in cui lo Stato, a volte, non aveva vergogna di presentarsi con il volto della collusione, che si trattasse di politici, o di appartenenti alle forze dell’ordine.
E a capirlo bastava (e basta) poco: era sufficiente limitarsi ad osservare i cartelli posti ai limiti del territorio comunale: «(…) nei paesi come il mio il cartello con la classica scritta Benvenuti è sempre pieno di buchi di pistole e fucili perché indica che si tratta di un territorio sotto controllo insomma chi ci entra deve sapere a quali rischi va incontro (…) è stato così per molto tempo adesso si può dire che sta cambiando un po’ ma non è cambiato molto».
Di questo narra Sandokan e Sandokan è (più che qualsiasi altro di Balestrini) un romanzo-documento, anzi un vero e proprio splendido, travolgente document humaine, senza più – beninteso – la pretesa e la zavorra dell’obbiettività naturalistico-verista, un romanzo su certi nostri attuali Vinti, che, credendo di cavalcare l’onda, la marea, ne vengono infine travolti, la storia di tanti neo-‘Ntoni – di calibro enormemente maggiore – narrata attraverso gli occhi di chi, come la giovane voce narrante del romanzo, pur essendo nato a San Cipriano, non ha scelto di restare contadino, né – tantomeno – di diventare camorrista. A dipanare questa storia è una prosa compatta, scandita in blocchi (come nelle altre prove narrative di Balestrini), in cui la regia dell’autore mescola con sapienza estrema e raffinata trascrizione di testimonianze orali e materiale giornalistico, intrecciando strettamente tutti i livelli in un impasto originalissimo, tanto denso e serrato, da non lasciare tra le singole parole nemmeno lo spazio minimo necessario alla punteggiatura e in cui l’estrema chiarezza del dettato non è certo sinonimo di assenza di ricerca formale.
Quanto sia ‘formalizzata’ la prosa di Balestrini lo si vede con evidenza nei momenti più intensamente allegorici del testo, come in quello della civetta crocifissa, che l’io narrante ci porge attraverso la maschera autistica e straniante di un racconto in terza persona singolare («improvvisamente vede si rende conto che cos’erano quelle orribili grida che aveva sentito nel dormiveglia vede davanti a sé sul portone ci sono crocefissi due grandi uccelli li avevano inchiodati vivi sul legno del portone con dei rametti appuntiti nelle ali per farle stare aperte e nelle gambe avevano appeso lì una civetta viva e un colombo vivo e li avevano lasciati lì a gridare per tutta la notte»), o in quello in cui tutto il paese spara contro l’aquila che sovrasta il monumento ai Caduti, due momenti topici, in cui sembra quasi che la violenza si scagli contro entità fortemente simbolizzate di una comunità in cui è – letteralmente – vietato volare. E la cosa mi stimola un’altra associazione isolana, nel riportarmi alla mente una delle Novelle per un anno di Pirandello, scelta dai fratelli Taviani a far da cornice al loro Kaos, quella nella quale i campieri torturano il merlo maschio che cova, tirandogli addosso le medesime uova che l’uccello con cura proteggeva. Ancora una volta: vietato volare…
E se nel narrare l’ascesa dei Bardellino, Sandokan sembra quasi un romanzo di formazione capovolto carnevalescamente, sino a che la farsa non esploda in tragedia (non a caso la narrazione inizia dalla fine della storia, dal momento della cattura del boss), per altro verso esso è anche il racconto della risoluta autonomia di un ragazzo, del suo rifiuto della camorra e della violenza, del suo coraggio nel difendere gli immigrati dalle prepotenze e dal razzismo dei clan, della sua caparbietà nel cercare per se stesso una strada diversa, del suo disagio a vivere in un paese in cui ormai l’abitudine al delitto è divenuta scorza dura, la sua banalità rimedio ad ogni ingiustizia, atomo opaco di male che sembra, oggi, in questa nostra cupa postmodernità, rappresentarci tutti, senza eccezione alcuna.
A questo si ribella il giovane: prima di tutto parlando, decidendo di raccontare, di non tacere (e così Balestrini ci ricorda quanto sia – prima di tutto – etico e civile il nostro impulso a narrare storie) e poi abbandonando il paese. Ma la sua è un’emigrazione ”morale’, più che economico-sociale, un’emigrazione che sceglie di partire perché rifiuta di accettare -considerandola mostruosa – l’abitudine alla morte e alla violenza che fa da sfondo alla vita del suo paese, dei suoi amici, dei suoi parenti.
La scelta avviene quando il protagonista si trova a dover accompagnare all’obitorio il cognato, Antonio, per riconoscere e ricomporre la salma di un parente assassinato nella guerra tra clan rivali: «io non ce la faccio a tenere gli occhi sul cadavere perché mi fa stare male devo girare la faccia dall’altra parte (…) appena usciti dall’obitorio la prima cosa che fa [Antonio] è infilarsi in un bar a prendere un caffè con due cornetti come se nulla fosse stato con una tranquillità con una abitudine alla morte che mi chiedo da dove cazzo gli veniva (..) sono ripartito subito la sera stessa per il Nord ho buttato via i vestiti che ancora puzzavano di quella puzza orribile di sangue congelato mi sono fatto portare alla stazione e mi sono detto con rabbia che non tornerò mai più al mio paese».
Ma non è il racconto di una fuga, questo, piuttosto quello del taglio simbolico, etico, politico, di ogni cordone ombelicale con un inferno quotidiano, quello dell’Aversano, ma più in generale di questa nostra Italia, in cui ad un Francesco Schiavone qualsiasi – grazie ai capelli lunghi, a un po’ di barba alla Kabir Bedi e a tanta violenza – è stato possibile autonominarsi Sandokan e – quasi quasi – riuscire ad esserlo per davvero.
Nanni Balestrini
Sandokan – Storia di camorra
Einaudi, pg.135, €13,00