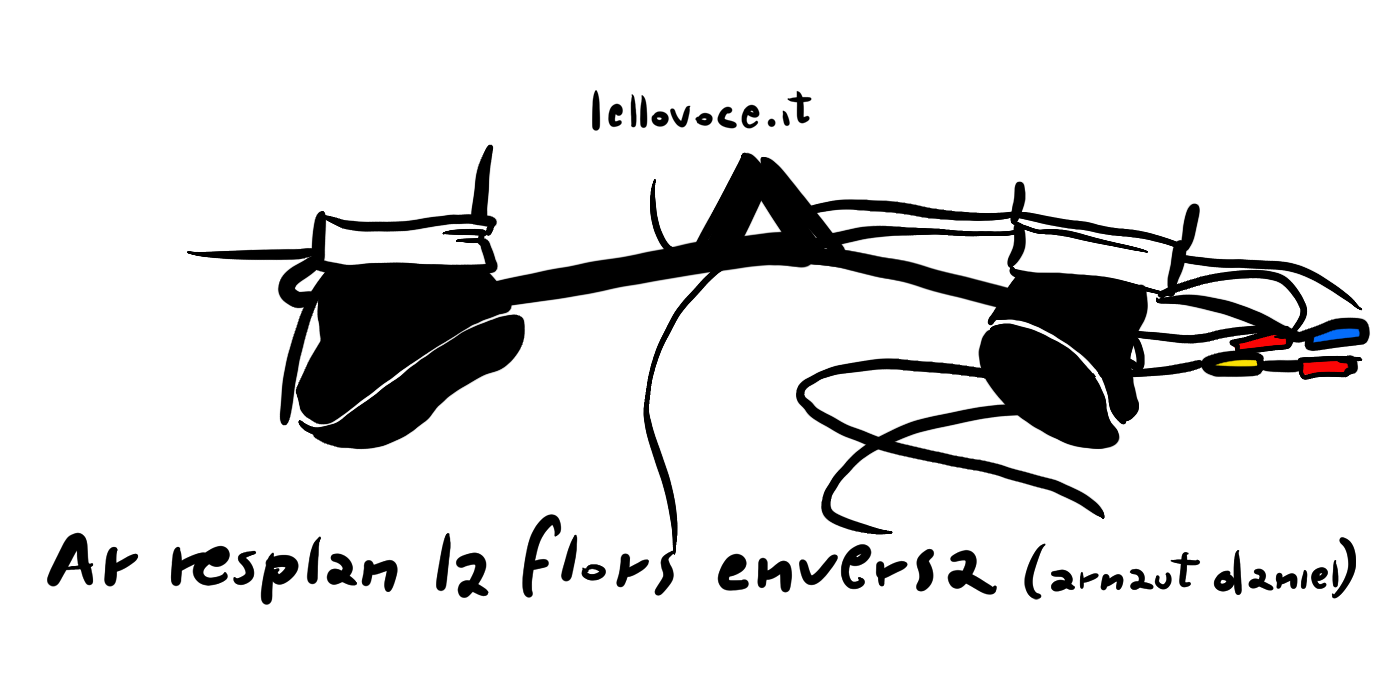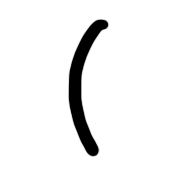§1. La tradizione è soltanto la sineddoche del passato.
Si è abituati a pensare alla Tradizione ponendo mente essenzialmente al suo aspetto di conservazione. La Tradizione sarebbe così condizione indispensabile per l’esistenza della cultura stessa, in quanto prodotto ‘storico’.
Non intendo qui soffermarmi sulla liceità di quest’identificazione – problema a cui, oltretutto, sono state dedicate, su questa stessa rivista, le acute osservazioni di P. Bürger, le stesse che hanno dato il via a questa nostra discussione. Piuttosto mi preme porre mente ad un’altra delle caratteristiche della Tradizione, forse meno evidente, ma certo non meno essenziale: quella di essere – in primis – il risultato di un processo di selezione. A monte del ‘ricordo’ storico letterario sta la scelta di ciò che è (sarà) degno di essere ricordato. Ciò non riguarda solo il passato (il futuro). E’ problema anche di quel presente in cui si decide quali sono (saranno, sono stati) i testi che costituiranno quella determinata, ‘presente’, storia della letteratura, e quali altri invece non lo sono (non lo saranno, o non dovrebbero esserlo mai). Dipende dalle particolari modalità in cui in quel presente si articola il giudizio estetico, dai rapporti di forza tra i singoli autori, tra i gruppi, tra le varie poetiche che concorrono alle dinamiche di produzione simbolica, dai rapporti, ogni volta peculiari, tra testo e contesto ( storico-sociale e letterario): è, insomma, problema tanto estetico quanto ‘politico’ e politico-culturale, che riguarda direttamente le lotte per la conquista del ‘capita-le simbolico’; è problema che non ammette soluzioni definitive alle sue fluttuanti equazioni, ma solo incognite variabili, ogni volta riscoperte e perdute. Occorre, dunque, partire dalla consapevolezza che il meccanismo strabico che identifica tout court la Tradizione con la globalità del nostro passa-to culturale è destituito d’ogni fondatezza e semplifica la complessità storica nell’uno o nell’altro storicismo. La Tradizione, cioè, per il suo stesso, costitutivo, operare attraverso selezione (ideologica almeno quanto tecnico-estetica) è soltanto la sineddoche – non innocente, né aleatoria – del nostro passato culturale e letterario. Essa, inevitabilmente, rimanda – proprio attraverso le sue cronache e repertori e interpretazioni di opere memorabili – al silenzio, benjaminianamente invendicato, di coloro che, a torto o a ragione, sono stati ‘sconfitti’ e dimenticati. Eppure, proprio in questo meccanismo di pendolare specularità sembra trovarsi la ricchezza stessa della Tradizione, il suo essere, in sé, più tradizioni e dunque la sua possibilità di essere continuamente riscritta, riformata, che le permette, sorta di instancabile Fregoli, di sopravvivere ad ogni successivo ‘presente’.
Ciò che, insieme agli amici di «Baldus», mi è accaduto di sottolineare negli anni passati è stato proprio l’esaurimento della funzione normativa della Tradizione, la possibilità di una sua revisione critica che sostituisse alla Tradizione le tradizioni, che sfuggisse definitivamente alle forche caudine dell’ormai usurato bipolarismo Tradizione vs Avanguardia. Quello che ci si poneva come problema principale non era di tentare di rifondare o riproporre questa o quella neo o ultraneo-Avanguardia, bensì di ristabilire le condizioni minime, basilari per qualsiasi operazione di rinnovata ricerca letteraria: la possibilità di recupero e di riuso critico di una serie di materiali laterali, di tradizioni oscurate, ricacciate ai margini della semiosfera letteraria. Se ci si è rivolti verso macaronici, minori e dimenticati di ieri e di oggi non è stato per gusto del ‘curioso’, dell’inusuale, alla ricerca di materiali à la vogue per sempre nuovi manierismi. Al contrario, si è trattato di un tentativo, sentito come necessario e improrogabile , di prospezione delle rovine, di un’archeologia critica che all’indistinto catalogo postmodernista dei ruderi ha tentato di sostituire una cartografia funzionale tesa la recupero di ogni materiale di costruzione utile alla realizzazione di un progetto comunicativo complesso ed assolutamente ‘contemporaneo’. Rimane vittima di un evidente trompe l’oëil chi – come G. Guglielmi sulle pagine di questa stessa rivista – ritiene di poter identificare tout court la critica esplicitata dalle varie componenti del Gruppo 93 nei confronti dei modelli della comunicazione odierna e dei suoi echi poetico-‘trasparenti’ con un atteggiamento di netto «rifiuto del polo della ricezione», caratteristico di Avanguardia e Neo-Avanguardia. O, almeno, ciò non vale per quanto mi riguarda. Né credo che la riproblematizzazione della funzione e del concetto stesso di Tradizione possa passare attraverso la riproposizione di tipo alcuno di manierismo o neo-manierismo, e meno ancora che la soluzione espressiva possa essere individuata lungo la strada indicata dai tentativi di coloro che ritengono di poter tagliare questo no-do gordiano semplicemente inzeppando di contenuti attuali (dallo stupro, alla mafia, a quant’altro) forme tradizionali quali il sonetto petrarchesco. L’operazione puzza di neo-metellismo poetico e stupisce che proprio Guglielmi lodi oggi ciò che ieri ferocemente criticava.
L’operazione manierista, nel suo obbligato riferirsi alla norma che la precede non vede, non può vedere la necessità di un’operazione tanto più radicale e fondativa quale quella della riforma della Tradizione, della sua sostituzione con la pluralità contraddittoria e ricchissima delle tradizioni; essa manca, nel suo essere assolutamente ed esclusivamente ‘letteraria’, l’appuntamento con un contesto insieme sempre più complesso, sfuggente, cupamente minaccioso.
Ciò di cui si ha bisogno non è tanto di sempre rinnovate querelle antichi / moderni, quanto di una approfondita rilettura del significato di questi attributivi, del loro senso attuale.
§2. Avanguardia e Rivoluzione: una gita a Bombay (o a Manaus, o a Sarajevo, o a Napo-li…)
Si è affermato appena prima che la Tradizione opera anche attraverso una selezione, la quale a sua volta mira ad una conservazione e ad una successiva trasmissione, che si suppone infinita: il grande poeta, colui che fonda una Tradizione, si ‘eterna’. Ora – a ben guardare – per certi versi almeno, l’Avanguardia sembra operare secondo modalità analoghe: essa tende ad occupare il centro dello scacchiere simbolico e, destituendo, se non altro in via di principio, di valore estetico-culturale (di valore di scambio, infine) ciò che Avanguardia non è, seleziona e non fa che ricostituire una norma che tende all’auto-assolutizzazione, non fa che fondare, a sua volta, una Tradizione. Ciò è forse più della riconosciuta aporia che conduce l’Avanguardia tra le braccia del museo: altri inquietanti rispecchiamenti possono essere individuati. Se la Tradizione esorcizza il futuro, la dinamicità insita in ogni sistema di rappresentazione ed espressione, nell’immobilità atemporale, armonica e stagnante di ciò che è una volta e per tutte, virus che locupleta anxiety of influence, l’Avanguardia, per parte sua, non tratta meglio il domani, ma esclude ogni musiliana ‘no-stalgia del futuro’: convinta com’è di essere già il futuro, essa convive con un’angoscia da superamento, sorta di anxiety of tomorrow e non concepisce un’altra Avanguardia dopo di sé, ma preconizza – a intervalli più o meno regolari – la morte dell’arte, risoluzione definitiva di ogni contraddizione tra testo e contesto, tra arte e vita. In entrambi i casi si sostituisce il dialogo con la Storia, nella sua complessa e multiversa globalità, col rapporto esclusivo, e in qualche misura miope, con una certa serie storica che si suppone unica, prevedibile, ‘diretta a’, poiché Avanguardia e Tradizione sono figlie del medesimo ventre molle storicista. Arcadia neo-mitologica, o neo-orfica, o neo-romantica e Arcadia dell’Avanguardia e della Neo-Avanguardia sono, da questo punto di vista, equivalenti, due facce della stessa medaglia e perdono – proprio in quanto ‘manieriste’ – la loro scommessa con la contemporaneità e col futuro.
Ne nasce, inoltre, un paradosso e cioè che se l’Avanguardia è strategia tesa a conquistare tutta la posta simbolica in gioco, ad occupare il centro della semiosfera artistica e se si accetta l’anacronismo grazie al quale sarebbe possibile definire ‘avanguardia’ tutte quelle poetiche e quelle strategie culturali che in questo compito sono riuscite, allora la Tradizione rischierebbe di non essere altro che genealogia delle avanguardie
.
C’è, comunque, un problema ulteriore… l’Avanguardia non è solo questione di stile, è sempre questo e qualcosa di più, una posta scommessa nell’extratesto; ha bisogno di quella che qui potrebbe definirsi una stampella contestuale. Essa, cioè, non riguarda solo il testo ma – tutt’intero – il contesto. Come giustamente sottolinea Guglielmi sulle pagine di questa rivista, sono la volontà e «l’intenzione politica della parola» che, uniche, permettono di distinguere «lo sperimentalismo di un linguaggio da quello non meno audace ma tecno-arcadico del postmoderno». Insomma, non si dà Avanguardia senza Rivoluzione. Ora, a partire direi dall’89, è, però, andato in crisi precisamente questo: ci manca un’idea di Rivoluzione. La ‘fine del comunismo’ (vera o presunta che sia), lungi dall’essere la fine di ogni possibilità di creazione di un ‘mondo nuovo’, segna comunque certamente la fine di un modello rivoluzionario – sostanzialmente quello sovietico del ’17 – e pone sul tappeto la necessità di riprogettarne uno nuovo, compito titanico questo e che certo non spetta ai letterati, o almeno non solo a loro. Fatto sta che fino ad allora ogni parlare d’Avanguardia non sarà che ‘poetese’, un ridurre il problema a puro fatto di stile, precisamente a ciò che esso non è. Inoltre, quando alcuni dei critici che hanno guardato con disponibilità e attenzione alle testualità prodotte in ambito ’93 (e penso segnatamente a Barilli e Guglielmi) si ostinano ad individuarvi caratteristiche d’avanguardia sottovalutano, a mio parere, un dato inoppugnabile e cioè che, quand’anche ci trovassimo di fronte a caratteristiche stilistiche simili (e ciò credo che sia vero solo in parte), la mutazione del contesto e delle sue modalità percettive ed esperienziali è stata, poi, tanto drastica e radicale che comunque il senso e il valore di questa o quella scelta stilistica ne risultano profondamente influenzati, dipendendo essi non solo dal testo, ma da quest’ultimo e dal suo rapporto con un contesto totalmente differente.
Per altro verso, l’Avanguardia ha bisogno che l’extratesto che funge per lei da stampella contestuale possa essere concepito in avanzamento lineare e progressivo, è indispensabile che ciò avvenga perché essa possa concepirsi come avanzata rispetto a quest’ultimo. Non c’è avanguardia che tenga di fronte a dinamiche, come dire? circolari o aleatorie… E non c’è dubbio, credo, che le vicende storico-sociali del globo, sussultorie, aleatorie, ambiguamente circolari, o ‘catastrofiche’ che esse siano state, si sono almeno da un trentennio impegnate con pignoleria a smentire ogni storicismo. Tutto ciò, sia detto per inciso, in assoluta latitanza di rivoluzioni e con corrispettivo fiorire di mutazioni antropologiche, più o meno radio o tele attivizzate. Con la sola eccezione dello specifico scientifico-tecnologico, nel quale, invece, la marcia è proseguita diritta, una ‘rivoluzione’ via l’altra, col pericolo opposto, che definirei inflattivo, di una ridondanza, che si trasforma in rumore di fondo, o brusio… L’adesione di alcuni settori della Neo-Avanguardia e delle ricerche sonore, visive e concrete nei confronti delle coeve ed attuali e venture mode tecnologiche è spiegabile, credo, in questo ambito, ma credo, altresì, che essa possa essersi basata, a volte, su un’idea di ‘progresso’ acritica e scevra da riflessione antropologica e politico-filosofica, che ha ignorato gli avvertimenti benjaminiani e blochiani a proposito dei dislivelli spaziali e temporali, occultando la poro-sità del paesaggio reale. Per parte mia, credo che ogni eventuale nuova avanguardia non potrà evita-re di fare i conti col problema della non contemporaneità dello sviluppo storico, e dunque con la cattiva coscienza del suo essere spiccatamente ‘eurocentrica’. Per dirla con Bodei, che chiosa Bloch: «tutti viviamo nello stesso tempo cronologico e sulla superficie del medesimo pianeta. Ma il tempo e lo spazio non sono omogenei, uguali per tutti. Diversi tempi storici si condensano e si intrecciano nell’anno vigente e noi siamo dispersi, distribuiti lungo assi spaziali e temporali, differenti o, meglio, lungo dislivelli che sono storici e geografici insieme». L’Avanguardia, nel suo credere ad un processo lineare ed unico di sviluppo alla cui testa essa si pone, tradisce il multiversum costituito dalla compresenza sincronica di diversi Jet-Zeit; il suo essere ‘puntuale’, anzi addirittura in anticipo, rispetto alla propria serie temporale è, insieme, la sua – assolutamente europea ed occidentale – intempestività, la sua discronia rispetto – letteralmente – a tutto il resto del mondo.
C’è stato un tempo (utile e fertile per la nostra cultura e la nostra letteratura) in cui si invitavano gli intellettuali italiani ad una gita a Chiasso: a voler, da bravi epigoni, o supposti tali, reiterare l’invito, esso oggi non potrebbe essere che per una gita a Bombay (o a Manaus, o a Sarajevo, o a Napoli)…
§3. Il suono dell’inchiostro.
Si è molto discusso ultimamente, ed anche in questa stessa rivista, del rapporto stretto che si è stabilito nel lavoro di alcuni poeti tra testo e sua oratura, e mi riferisco, per esempio al già citato intervento di Guglielmi e a quello, precedente, di Pianigiani. Alcuni punti mi sono parsi particolarmente controversi e vorrei qui esprimermi in merito, se non altro quale parte in causa. A partire da qualche precisazione filologica.
Non è possibile, a mio parere, assimilare – come mi pare faccia Guglielmi – tout court l’interesse verso l’esecuzione del testo poetico ad un milieu postmoderno, poiché, com’è noto, è proprio in ambito moderno (dall’Avanguardia futurista, su su, fino a Spatola e a Lora Toti-no e a Toti) che affondano le radici della ‘poesia sonora’, essa è, in primis, patrimonio dell’Avanguardia e della Modernità. Andrebbe piuttosto rilevato come, in maniera abbastanza sin-golare, il lavoro sulla vocalità sia stato piuttosto negletto nell’ambito della Neo-Avanguardia, fatta eccezione per autori quali Spatola, o, in qualche misura Pagliarani e Costa, o per critici fiancheggiatori quale, e tra i primi, Barilli. Comunque sia, spesso anche il richiamo ai nuovi orizzonti sonoro-tecnologici è stato più teorico che pratico, oppure, come nel caso di Sanguineti, l’attenzione acuta verso le strutture comunicative ‘orali’ è stato poi schiettamente chirografico, escludendo dal proprio orizzonte l’esecuzione pubblica del testo, sospettata magari di ammiccamenti ‘ricettivi’. Al punto che, paradossalmente, è possibile ritrovare interessi verso l’oralità, l’esecuzione del testo a volte maggiormente spiccati proprio in autori lontanissimi dagli ambiti neo-avanguardisti: si pensi al Senhal di Zanzotto, o, per versi e con aspetti diametralmente differenti, alle letture pubbliche della Valduga, e recentemente è un transfuga dal ’63 come Celati che si interessa all’esecuzione orale dei racconti. Di fatto la storia delle neo-avanguardie italiane è, per la sua maggior parte, chirografica mentre la storia delle sperimentazioni sonore in Italia percorre strade sostanzialmente separate da quelle battute dai Novissimi e dai loro sodali, e ciò vale, in buona misura, anche per gli ambiti visivo e concreto della ricerca letteraria. Non solo: va poi detto che le esperienze chirografiche d’avanguardia e di ricerca hanno dimostrato di avere una capacità assai maggiore di essere legittimate e cooptate all’interno dell’ufficialità: chi voglia convincersene non avrà che da consultare qualche storia della letteratura… seppure a fatica la Neo-Avanguardia mostra di aver legittimamente conquistato un suo spazio, mentre un’omertà pressoché totale copre il fenomeno sonoro, che pure ha avuto esponenti di rilievo europeo. Unica eccezione le esperienze futuriste d’inizio secolo, spesso liquidate come una stravaganza tra le altre di un movimento noto soprattutto per le sue ‘bizzarrie’. Per parte sua il versante sonoro, posto brutalmente ai margini della scena letteraria, ha mostrato tendenze sempre più accentuate verso una sorta di accademia o arcadia neo-tecnologica, che frequentemente ha trovato la soluzione ai suoi problemi di poetica rifugiandosi nell’accogliente e neo-romantico seno di una sinestesia via l’altra, inseguendo progetti d’arte totale che gli hanno fatto perdere di vista lo scopo principale e la potenzialità maggiore della sua ricerca: quella di arricchire e rendere sempre più complesso il proprio specifico esteti-co.
Per chi, come lo scrivente, si è trovato ad operare dopo che tutto ciò era avvenuto e nello stesso tempo ha ritenuto di non poter ignorare l’oratura del testo, la questione del – che fa-re? si è posta come necessità di operare in termini che definirei ‘post-sonori’. Non si è trattato, cioè, di porsi di fronte alla dicotomia chirografia vs testualità, ma di partire proprio dalla coscienza che tale contraddizione (vera o apparente che sia) dovesse costituire parte integrante e fertile del lavoro di ricerca e produzione letteraria che si intendeva sviluppare. Nessuna fiducia, dunque, è stata concessa ai millenarismi sinestetici che preconizzano la morte del libro e, parallelamente, nessuno steccato preconcetto è stato elevato contro il suono e la sua produzione e riproduzione elettronica. Si è tentato piuttosto – a partire dalla convinzione che la ‘vocalità’ contemporanea non potesse non fare i conti con la sua dimensione chirografica – di costruire degli oggetti artistici che tenessero conto di entrambe le dimensioni della poesia, che trasformassero in energia espressiva e in concen-trazione di senso l’agonicità tra voce e parola, tra suono e segno. L’oratura contemporanea non può fare a meno di un confronto serrato con il suo essere anche segno e segno scritto. Non credo, perciò, che, a proposito del fenomeno dello sviluppo spesso rilevante delle letture pubbliche di poesia, sia possibile parlare di un ritorno di caratteristiche premoderne in ambito postmoderno: la ‘messa in situazione’, l’esecuzione, o l’interpretazione di un testo sono oggi frutto di un’oralità ‘secondaria’, che viene dopo l’invenzione della stampa e che ne è profondamente influenzata, ciò che avviene oggi non ha nulla a che spartire con ciò che è stato se non come avvertimento ‘filologico’, testimoniale dell’esistenza storica di una dimensione pre-gutemberghiana.
Quando poi, qualche tempo fa sulle pagine di questa rivista, mi è accaduto di parlare di un’autonomia tra gli aspetti chirografici e quelli sonori del mio lavoro intendevo sottolineare che il tentativo che mi impegnava era quello di costruire un oggetto artistico complesso, costitui-to sia dal testo chirografico che dalla sua oratura, senza che fra di essi si stabilisse alcun rapporto di tipo gerarchico, quanto una dialogicità reciprocamente autonoma. Non volevo dunque negare – come crede Pianigiani che mi ricorda un po’ di letteratura in materia, dalla teoria degli atti di lettura a quella degli atti linguistici – che un testo destinato all’esecuzione ad alta voce introietti al suo interno una serie di caratteristiche che gli derivano dalla sua destinazione performativa, volevo solo sostenere che i miei testi, buoni o cattivi che siano, non erano solo testi destinati all’esecuzione ‘voca-le’, ma che credevo possibile che essi mantenessero una propria ed autonoma capacità di funzionare come testi scritti, anche in assenza della loro esecuzione, o, ancora, che essi dovessero assumerne una di ancor più efficace nel caso in cui si riuscisse a fruirne contemporaneamente ad entrambi i livelli. Ne sottolineavo, più semplicemente, la dimensione, per così dire, ‘ipertestuale’, al di là di qualsiasi opposizione rigida tra vocalità e testo scritto, anzi in vista di una loro possibile dialogici-tà.
Non mi sento partigiano né del suono, né dell’inchiostro: ciò che mi interessa è precisamente il suono dell’inchiostro.
§4. Una crisi critica.
Della discussione a proposito della crisi della critica sono piene le pagine della stampa specializzata e quotidiana e non è possibile in questa stringata sede riprendere temi e stimoli del dibattito. Mi preme, piuttosto, qualche osservazione riguardo a ciò che più da vicino si riferisce al discorso sin qui sviluppato: l’avanguardia e le ultime esperienze testuali. Il fatto, poi, che recentemente sia stato un addetto ai lavori dell’autorevolezza di Segre a richiedere più «umiltà» ai propri colleghi mi permetterà maggiore tranquillità nello sviluppare alcune osservazioni al proposito.
Non si può negare, credo, una certa pervasività ermeneutica sviluppatasi in ambito letterario e non solo. Ne è segnale (causa?, effetto?) l’abbandono da parte di molti autori (soprattutto per quanto riguarda la prosa) di una propria dimensione critico-teorica, o, che poi è lo stesso, la loro iscrizione a questa o quella ‘scuola’. Ciò vale in primis per l’ondata di lettura decostruzioniste e neo-heideggeriane che, nel momento stesso in cui sembrano diluire totalmente la funzione analitica e interpretativa in quella ‘artistica’, in realtà si locupletano ed espandono al punto da occultare del tutto l’oggetto del proprio riflettere. Non c’è modo migliore per disattivare un testo che renderlo un pretesto…
Dall’altra parte anche la critica che ha militato accanto alle esperienze di ricerca ha spesso, e certo con tutte le dovute eccezioni e i sacrosanti distinguo, fatto in modo di indulgere a, se non medesima, comunque equipollente passioncella: quella di sovrapporre griglie rigide e preconfezio-nate ai nuovi fenomeni letterari. Piuttosto che l’analisi e la lettura approfondita dei testi si è tentato, non di rado, di trattarli ‘preventivamente’ come prove provate di questa, o quella ipotesi critica, formulata in precedenza e magari giudicata come quella più efficace ‘politicamente’ nei confronti dell’avversario, giungendo, come dire? alla definizione di un’area di poetiche semplicemente sulla base dell’individuazione di un avversario comune, limitandosi, insomma a gridare: oi barbaroi! Quando penso a certe tesi che facevano del Gruppo ’93 la ‘naturale’ continuazione del Gruppo ’63 non posso fare a meno di ricordare il passo platonico in cui si sostiene che, se i cavalli avessero potuto, avrebbero immaginato i propri dei con fattezze equine… e l’episodio ha valore di parabola, credo. Checché ne pensi Guglielmi – che parla di un incontro tout court fruttifero – i rapporti tra autori ed alcuni critici all’interno del Gruppo ’93 sono stati assai poco irenici e precisamente perché spesso gli autori si sono lamentati del fatto che teorie precotte venissero sovrapposte a complessità testuali che, a parere degli ‘scriventi’, avrebbero meritato un parallelo tentativo di aggiornamento e ‘rischio’ metodologico, che non sempre è venuto.
Non a caso, se è caratteristica dell’Avanguardia quella di essere costituita da personalità artistiche che insieme siano autori e critici, o comunque quella di segnare un parallelo fiorire di nuove individualità ad entrambi i livelli, il ’93, per converso, ha visto una netta separazione tra il ver-sante della produzione testuale e quello della sua interpretazione e valutazione e ciò non perché gli autori non avessero, o non rivendicassero una loro autonoma dimensione teorico-critica, quanto perché alcuni dei critici hanno preteso di avocare a sé ogni funzione interpretativa e valutativa dei fenomeni in atto. E – ancora non a caso, ed è differenza di non poco conto col ’63 – nel Gruppo ’93 non hanno avuto spazio alcuno giovani voci critiche, ma esclusivamente autori e quando è stato richiesto, a ’93 ormai morto e sepolto, nel corso degli annuali incontri di Reggio Emilia posti sotto il titolo di Ricercare, che il dibattito riguardasse anche le metodologie critiche, alcuni imbarazzi e qualche diniego sono stati evidenti. D’altra parte, più in generale, nella discussione in corso a proposito di sorti e metodologie della critica letteraria, le voci d’autore sono rarissime se non del tutto assenti, forse a testimonianza di un fastidio diffuso – e certo con presupposti ed esiti diversissimi, più o meno legittimi – nei confronti di una categoria d’operatori che, spesse volte, al dialogo e all’ascolto ha preferito la conferma tautologica d’ipotesi formulate prima, in assenza del testo.
Per chi, come me, crede nell’insostituibile funzione della critica e dell’analisi letteraria per il dibattito sulle e delle poetiche, una situazione del genere non è segnale soltanto del deterioramento degli ambiti disciplinari legati alla critica, ma più ampiamente di tutto il panorama letterario nazionale: essa è, se mi si passa il greve pleonasmo, una crisi ‘critica’ e non solo una crisi della critica, nel senso che essa si pone minacciosa alle fondamenta di tutto il dibattito letterario, vero punto ‘critico’ nell’equilibrio e nelle dinamiche del sistema letteratura.
E’ indispensabile, allora, che la critica letteraria accetti di fare un passo indietro e due in avanti: che ridia centralità alla prassi e alle poetiche, ‘retrocedendo’ all’ascolto dei testi e che sappia, successivamente, ritrovare proprio in essi l’input, lo stimolo che le permetta di effettuare i due passi in avanti (metodologici e interpretativi) che non sono indispensabili solo alla fruttuosità delle sue analisi, ma alla vita della letteratura nazionale stessa, nel suo complesso. Credo, insomma, che sia irrinunciabile un aggiornamento delle metodologie e degli strumenti, un allargamento drastico degli orizzonti, una disponibilità tollerante alle creolizzazioni, all’approccio plurale e credo, altresì, che la critica non possa fare ciò a prescindere dagli autori e dalla loro reale produzione. Chi, come me, pretende di sviluppare una ricerca nella quale testo ed oratura svolgano una funzione dialogica e complementare si trova oggi orfano di una critica ‘complessiva’, poiché tutte le analisi, in mancanza di adeguate categorie interpretative che potrebbero sortire soltanto dal dialogo della critica con discipline affini ma sinora neglette – e penso alla fonologia, per esempio – si riferiscono inevitabilmente al solo testo scritto, ignorando, gioco forza, il suo aspetto fonico e performativo, che pure è parte determinante, sia nei meccanismi di produzione semantica ed espressiva, che in quelli più ampiamente estetici. Operare così è per un autore come camminare su una gamba sola e senza stampelle.
Il dialogo viene prima del linguaggio, sostiene Lotman, e senza dialogo tra critica e prassi letteraria credo che nessun nuovo linguaggio poetico potrà vedere la luce.