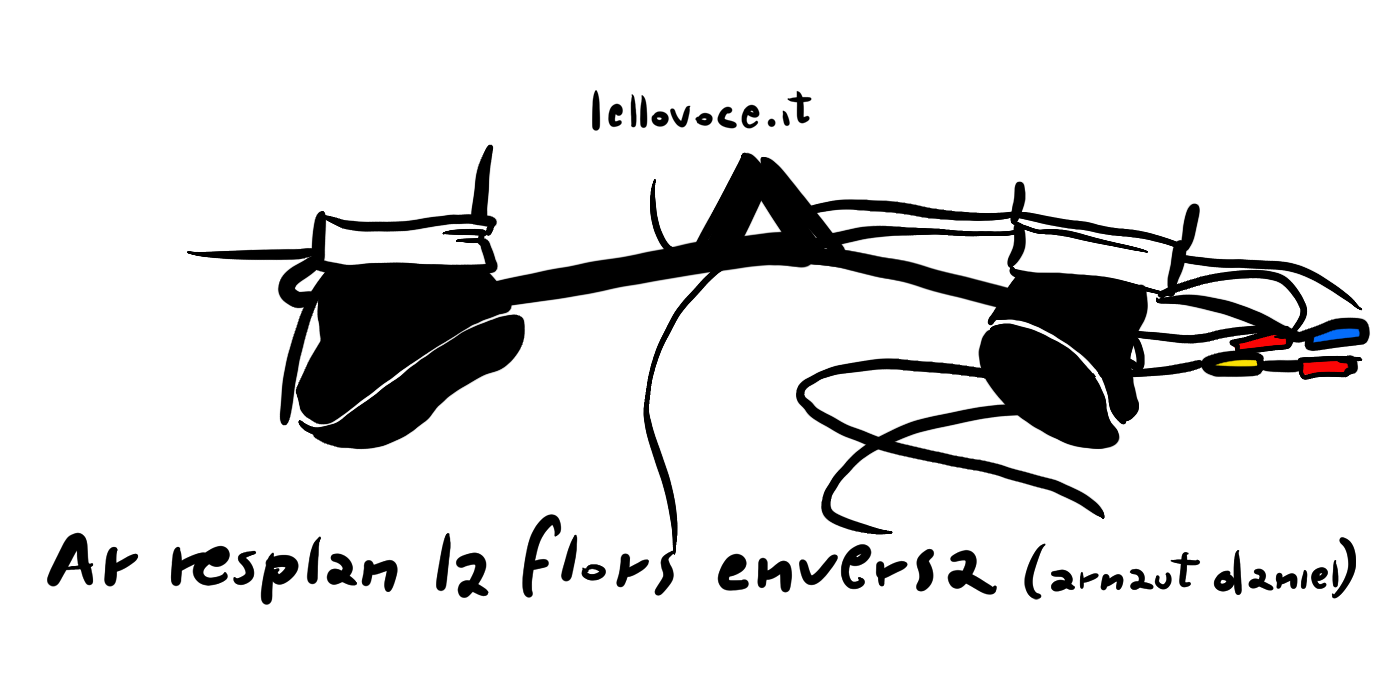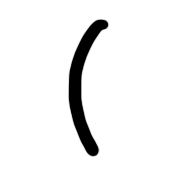C’è titolo per un libro di poesia che abbia in sé più ybris, maggior rischio, di quello scelto da Anna Maria Bedini per il suo La lingua di Dio? Non so: quello che è certo è che questo è infine un titolo azzeccato, una scommessa vinta, e proprio grazie alle armi affilatissime di un linguaggio integralmente umano, denso, torbido, eppure a volte quasi accecante.
Perché la lingua della Bedini è una lingua pericolosa, pronunciando la quale si mettono in moto dinamiche oscure, ma concretamente materiali, dinamiche di senso come di respiro, di forma come di ritmo, furiose e travolgenti, vorticose, che risucchiano il lettore in un gorgo, sino al buco nero dove il linguaggio, giunto al suo massimo grado di condensazione, esplode, o si trasforma nel suo opposto, in pura voce, in fiato tragico, in vocalità insensata del dolore.
L’invenzione lessematica si mescola a quella sintattica, in un alternarsi serrato di anaculoti e neologismi, di periodi a ‘cavaturacciolo’ e storpiature, in un avvicendarsi di registri che vanno dal quotidiano al raffinatissimo, dal colloquiale all’oscuro espressionista. Come nell’intermezzo, intriso di presente e realtà, di clandestini: «in tanti sono morti / in seme di niente / in giorno scemo / in allegria del futuro / in tuttimorti // voi qui mi siete vivi / per guado di braccia che non attraversa / per notte perforata / da troppi bidoni / del tuo non capire // per la sevizia delle chiese / per il levante che si spostava in scene / (…) // con fede aerea i tramonti scendono / con ingiustizia il giorno si inscrive».
Il barocco della Bedini è propriamente un barrocco, uno stile sontuoso che si trascina dietro morte a fascine, annichilamento, stupore, come perla nera e irregolare, e fa della scrittura (e della sua materiale pronuncia) un atto definitivo, irreversibile: «”tu sei un nome che respira e muove” / o sbriciolato da un inchiostro / che picchia sulle dita spalmato / in forza di fango o stroncato / dai miei quattro righi che a conoscerti / le labbra vengo con la cena delle mie / parole (…) / ma il buio ti ha preso il volto / e leggermente uscivi in nome / di neve per la vasca di me / che non s’alzava in lingua di licheni / in uniforme di morti».
Le genealogie, i nomi che vengono in mente immediatamente sono prima di tutto quello di Gerald Manley Hopkins – a cui la unisce una lingua sperimentale e irta, oscura, così come il tema del colloquio, annichilente e linguisticamente enorme, del dialogo con la Divinità, col Cristo – e poi quello del Buonarroti dei sonetti più clus, oscuri, notturni, dove il senso si nasconde tra le pieghe del dolore, affonda nelle parole, che come piaghe fioriscono sulla lingua del poeta.
Un libro difficile e bellissimo, dunque, in cui viene chiesto al lettore ben più che una fruizione passiva, ma l’abbandono di una partecipazione e di una responsabilità comune, il coraggio del rischio dello smarrirsi in un labirinto di segni che ancona risuonano d’echi, l’atto estremo del trasformarsi, nonostante il silenzio del testo scritto, da lettore in ascoltatore, da semplice spettatore del linguaggio a suo mallevadore, complice, sino al culmine in cui la voce (la voce comune, dell’autrice e del lettore) non smaschera definitivamente l’inganno celato nel nome del Dio, pronunciandolo: «io non sprigiono che questa via nelle mia labbra».
Maria Angela Bedini
La lingua di Dio
Einaudi