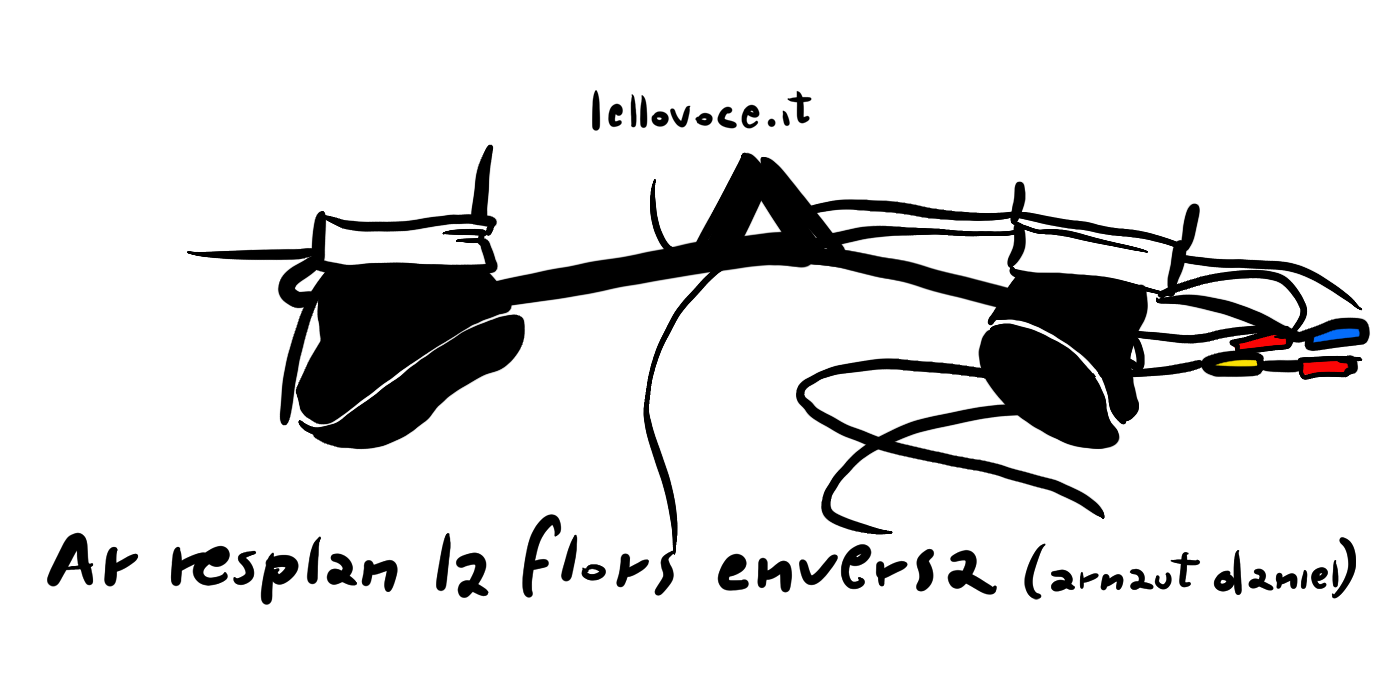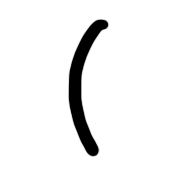a Haroldo De Campos
a Augusto De Campos
a Horacio Ferrer
#1
Occorre innanzitutto precisare quella che è una mia convinzione profonda e cioè che la poesia sia un’arte implicitamente politica, indipendentemente dai temi che essa decide di trattare, ma precisamente per la sua forma, e, ancor più precisamente per le forme della sua ricezione.
Il rapporto tra artista e fruitore caratterizza in modo radicale le arti e le loro forme e ciò vale, a maggior ragione, per un’arte che, come ha giustamente sottolineato Frasca, è, prima ancor che un’arte, un medium, il primo medium che l’uomo conosca per la trasmissione dell’informazione ‘non genetica’.
La poesia nasce prima dei poeti. La poesia nasce insieme alla comunità. La stessa tradizione lirica, quella di più stretta osservanza petrarchista, checché ne pensi Nortrop Frye, non potrà fare a meno di concordare sul fatto che sin la grande confessione (e l’esercizio di pentimento ed auto-contrizione) del Canzoniere ha senso soltanto a partire dalla sua dimensione ‘pubblica’, poiché nessuna confessione ha effetto senza un orecchio che ne sia in ascolto, ogni confessione è la messa in scena (o meglio, come vedremo più avanti, la ‘messa in voce’) del peccato, e pretende il suo pubblico.
Se la poesia è nel mondo, insomma, essa non può esserci che a partire dalla sua voce e dalla capacità che la sua voce ha di catturare l’ascolto della comunità e di fondare un dialogo.
La comunità è fatta di corpi, di presenze, non c’è comunità nella solitudine pur attenta, critica, intelligente del lettore, e questo, ahimè, scava un fossato incolmabile tra narrazione epica (poetica) e narrazione romanzesca: un fossato politico, che riguarda le prassi (di trasmissione e di ricezione), ma in cui la forma scelta è già, in sé, scelta di campo ideologica, prima che formale; una pratica in cui l’io non può avere spazio, se non a partire dalla sua riduzione all’essere relazione.
Il dialogo «nasce prima della lingua», sottolinea Lotman, o, a dirla con Zumthor: “in poesia non c’è parola senza voce”.
Lo stesso Zumthor precisa poi che «il testo poetico orale, per il fatto stesso che impegna un corpo mediante la voce che lo veicola, si sottrae più del testo scritto a ogni analisi che volesse dissociarlo dalla sua funzione sociale e dal posto che tale funzione sociale conferisce ad esso nella comunità reale», visto che «un messaggio non si riduce al suo contenuto manifesto, ma ne comporta uno latente, costituito dal medium che lo trasmette. L’introduzione della scrittura in una società corrisponde dunque a una trasformazione profonda, di ordine mentale, economico ed istituzionale».
Così, il suo scegliere di diventare muta, il suo farsene sin un vanto per qualche secolo, è stato per la poesia una sorta di suicidio, la scelta di un eremitaggio radicale dalla Polis, che l’Estetica hegeliana, nominando il romanzo nuova epica borghese, di fatto sancisce, condannandola al silenzio e rinchiudendo il suo testo scritto nel pollaio di una minoranza sempre più malinconica ed esclusa dalla partita fondamentale per la conquista del centro della semiosfera culturale ed artistica, dell’influenza sull’immaginario collettivo. Scrivevo anni fa che « la comunicazione e il linguaggio sono la basi delle società e che la loro vocalizzazione, il loro insediarsi materiale in un corpo, in uno spazio e in un tempo presenti e comuni ha grande valore, se non altro come testimonianza dell’esistenza, magari residuale, di una comunità, di una comunità interpretante, attenta, sospettosa, attiva, conscia dell’effimero dell’arte nei confronti delle macrostruttura, ma anche del suo valore nella strutturazione degli immaginari, che per molti versi, nelle società dello spettacolo, a loro volta, soli, possono influenzare e modificare le macrostrutture, nel loro trasformarsi in scelte, stili di vita, comunicazione, consumo, ecc., poiché, oggi più che mai, la prassi inizia e si fonda nell’immaginario». Rimango sostanzialmente della medesima opinione.
#2
È questo della poesia l’unico caso che io conosca in cui un’arte rinuncia, più o meno spontaneamente, al suo canale di trasmissione originario, adottandone uno diverso e per molti versi opposto, riuscendo, però, a sopravvivere a questa mutazione.
Non si è, a mio parere, riflettuto abbastanza sul fatto che, nel consesso delle arti, la poesia ha questa sua assoluta singolarità: precisamente la mutazione radicale dei suoi modi di espressione e fruizione, cosa che non ha eguali per le altre discipline artistiche.
Le sue forme originarie non si sono solo sviluppate, esse sono state sottoposte a una violenta torsione, che ha come strozzato una serie di potenzialità, permettendo ad altre, che di partenza non le appartenevano, di potersi sviluppare.
La poesia ha cambiato il suo medium di trasmissione, dal suono al segno, la poesia ha mutato il senso coinvolto nella sua fruizione, dall’udito alla vista. E questo non è accaduto per nessun’altra delle arti.
In musica, ad esempio, lo sviluppo della scrittura, della notazione, non ha affatto comportato conseguenze del genere: la sua natura sostanzialmente desemantizzata non lo avrebbe permesso.
In poesia, invece, la sua sostanza linguistica, e dunque intensamente semantica, ha fatto sì che la parola strozzasse la voce, che il segno uccidesse il suono.
Esiste oggi, dunque, mi si passi la metafora velatamente ironica, una natura intrinsecamente ‘transgender’ della poesia, o, se questa disturba, certamente trans-mediale.
Ciò comporta evidentemente una serie di conseguenze su di essa e sulla sua particolarissima condizione odierna.
La poesia è stata mandata in esilio, in esilio dalla voce, come sosteneva Paul Zumthor. Anzi ha scelto di andare in esilio.
Ma poi, come tutti gli esiliati, pur nel suo confino, qualcosa dentro la sua natura più intima ha sempre mantenuto memoria della sua terra d’origine.
Si può decidere di leggere una poesia in silenzio, ma anche in questo caso, sia pur virtualmente, essa va eseguita, perché viva. O altrimenti quella poesia semplicemente non esisterà.
Laddove essa ha resistito per secoli in quanto oralità, ciò è dovuto ad aspetti prima sociali, strutturali, antropologici, che estetici, e così avviene ancora un’illegittima identificazione tra poesia orale e folklore: la sua folklorizzazione pesa come una minaccia, una minaccia che ha dissuaso per secoli chiunque dall’idea di riallocarla nella voce, pena l’immediata ghettizzazione di questi tentativi nell’ambito del folklore, o della più vieta ‘cultura popolare’, o di massa. «All’interno dello spazio europeo, sono bastati […] due o tre secoli per corrodere, folklorizzare e in parte annientare le vecchie culture locali, grazie agli irresistibili strumenti di colonizzazione interiore che hanno rappresentato l’alfabetizzazione di massa e la diffusione della stampa» [Zumthor].
Il Leopardi che ammirato trascrive nel suo Zibaldone come a Napoli sin i popolani sappiano recitare a memoria brani dell’Ariosto e del Tasso è una luminosa eccezione, tra miriadi di autori ormai tanto muti, quanto, ahimè, totalmente sordi.
Ora, la scelta che un’arte fa dei canali della sua fruizione (cioè, infine, di quelli della sua espressione) è insieme intensamente politica ed estetica. Ciò vale anche per quella adottata dalla poesia nel farsi collega del romanzo, arruolandosi nel medesimo esercito letterario della prosa.
A voler procedere per paradossi si potrebbe fin sostenere che nulla è più simile ad un telespettatore di un lettore di romanzo.
Entrambi dedicano al medium di cui stanno fruendo la loro totale, solitaria attenzione, entrambi stanno utilizzando un medium ‘caldo’, che li assorbe totalmente e crea ipertrofia di un senso sull’altro, più caldo, anzi, il romanzo della TV, la quale, grazie a una fruizione tendenzialmente polisensoriale (occhio/orecchio), sbilancia meno i sensi, pur aumentando a dismisura la passività del fruitore, ipnotizzandolo.
La poesia, invece, è originariamente un medium ‘freddo’, un medium ‘freddo’ che è stato, però, portato, a un certo momento del suo sviluppo, a temperature da altoforno, durante secoli di fruizione muta, mentalistica, e che dunque, nel suo odierno tornare a raffreddarsi, immergendosi nell’acqua dei suoni, si tempera, come l’acciaio.
Quel che voglio dire è che quest’operazione di riscaldamento non ha avuto solo effetti negativi, anzi essa ha permesso alle sue forme linguistiche di raffinarsi enormemente, di fondersi e modellarsi in forme sempre nuove, di farsi sottili, durevoli, e insieme estremamente complesse, così che oggi la lingua che si fa voce e che si accorda con la musica è, o meglio DEVE essere ‘lingua temperata’, tagliente e insieme estremamente resistente agli shock (qui antropologici e formali): non a caso, al momento di immaginare quale potesse essere la «poesia orale» del futuro, un maestro come Zumthor annotava: «le voci più presenti che risuoneranno domani avranno attraversato tutto lo spessore della scrittura». Ma su questo tornerò più avanti.
#3
Resta intanto il fatto che, nello scegliere di essere fruita ‘letterariamente’ e solo ‘letterariamente’ la poesia fa una scelta ideologica, delimita precisamente il suo ‘pubblico ideale’, sceglie sin le classi sociali a cui rivolgersi, né si fa solo borghese, ma sceglie, formalmente, di puntare tutto sul verso, piuttosto che sul ritmo, sulla prosodia esclusivamente visiva degli ‘a capo’, piuttosto che sul battere ritmato del cuore e sul soffio cadenzato del parlare; rinuncia alla sua concretezza materica, per consegnarsi mani e piedi alla fruizione silenziosa. Decide d’essere patria del ‘simbolico’, scaccia dalle sue mura ogni funzione fàtica, storce la bocca ad ogni andamento anaforico, libera il verso dal ‘tempo’ e dalla quantità, lo sottrae alla durata, sfugge alle costrizioni delle forme chiuse (che sono peraltro forme della ‘durata’, aspetti della concretezza della poesia, tanto quanto della semplice quantità ‘linguistica’, non solo modelli letterari ormai vuoti, canoni invecchiati), per affidarsi al flusso teoricamente infinito dello scritto, che schiaccia e blocca lo scorrere del tempo, siderandolo nella geometria retta e bustrofedica del rigo che si fa verso; essa costruisce ghetti per i suoi aspetti allegorici, sostituisce la dinamica della metonimia con l’immobilità della metafora, con il suo gioco di specchi approntati a mise en abyme… pronta (e prona), d’ora in avanti, ad affascinare l’occhio, sia pur a costo di condannarsi al silenzio.
Sia il Futurismo, che Dada, pur nella loro radicale diversità, non a caso fanno dell’aspetto sonoro della poesia uno dei loro cavalli di battaglia, ed è uno dei modi del loro tentativo di sfuggire ai lacciuoli ‘letterari’ anche tutto quanto mettono in atto per far esplodere il testo grammaticalizzato e per rilevare le sue caratteriste ‘concretamente’ visive.
Il fenomeno è, invece, ormai assai meno evidente nelle Neo-Avanguardie e laddove esso è più esplicito coincide, di fatto, con una marginalizzazione degli autori che ne sono protagonisti, nonostante ad esso si accompagni una qualità letteraria evidente, penso a Costa, Spatola e Vicinelli, o, come nel caso di Pagliarani, esso si risolve in una derubricazione del tutto a tic stilistico personale, assolutamente assente poi nella successiva ermeneutica dell’opera del poeta romagnolo.
Un discorso a parte meriterebbe l’opera di Antonio Porta, nel suo lucido preconizzare l’avvento di un’epoca della voce, rimasto però sostanzialmente ignorato dalla critica, almeno nei suoi aspetti più radicali.
La scelta formale, dunque, è sempre una scelta politica in poesia, a maggior ragione nella misura in cui tale scelta oggi decida di farsi di nuovo carico esplicitamente della natura fondamentalmente non letteraria della poesia.
È proprio a partire da questa scelta che essa torna ad essere esplicitamente politica. È proprio a partire dal ritornare della parola nella voce che la poesia si ripresenta nella Polis, mette fine al suo esilio.
#4
Da ciò deriva, a mio modo di vedere, una caratteristica della discussione a proposito della poesia, così come essa si sta sviluppando da circa un decennio, anche in Italia, sia pure con minore approfondimento e vivacità a causa di una sostanziale stagnazione del nostro contesto, infeudato com’è da stenti potentati che lavorano solo per perpetuare se stessi e il loro stanco verseggiare.
Più che a dibattiti tra questa e quella tendenza, tra questo e quell’ismo, ciò a cui si assiste è un radicalizzarsi delle posizioni proprio a proposito della natura ‘orale’, o piuttosto ormai definitivamente scritta, letteraria, della poesia.
Da questo punto di vista il fenomeno è già evidente da anni in Germania, Francia, USA, spesso a traino dell’evidente successo del Poetry slam, dello spoken word e della spoken music, o poesia per musica che dir si voglia, che spiazzano gli autori tradizionali e che fanno da apripista per un dibattito che poi si amplia alla poesia in generale.
Ciò che ne deriva è che oggi, com’è a mio parere ovvio che sia, non è tanto preminente la discussione a proposito delle poetiche in sé, quanto, a monte di tutto ciò, quella che cerca di fare chiaro a proposito delle scelte ‘mediali’ dei singoli autori e che anche la concentrazione dei singoli autori sia maggiormente dedicata proprio all’approfondimento di tutto quanto, implicitamente, comporta a livello formale, estetico, lo spostamento di ‘canale’, dalla carta alla voce, o più ampiamente al suono.
Ciò permette, in questo momento, ma non ancora per molto, a mio giudizio, a poetiche linguisticamente lontane di ritrovarsi affini a livelli altri: per esempio operazioni come quelle di Fiori, o di Gualtieri possono essere avvicinate, per molti aspetti, a quelle di Lo Russo, Frasca, Nacci, o Bulfaro, proprio a partire dalla scelta di un ‘canale’ comune per la trasmissione del messaggio, quello orale. Anzi a questo livello può addirittura registrarsi l’interesse di autori come Rondoni, tra i protagonisti del possente movimento di restaurazione della tradizione simbolista ed orfica da anni ed anni attivo nel nostro paese, ma pur lesto a cogliere intuitivamente la direzione delle dinamiche nuove.
Se da una parte questa situazione, inevitabilmente, genera confusione, per altro verso tutto ciò riflette uno stato delle cose certamente reale.
Prima che tra sperimentalisti e orfici, oggi la partita è effettivamente tra oralità e scrittura, anche se certamente c’è oralità e oralità (e scrittura e scrittura) e se i testi oralizzati non perdono evidentemente nell’esecuzione le loro caratteristiche linguistiche e ‘letterarie’ di partenza ed esse vengono, anzi, rilevate in modo ancor più netto, nel loro riverberarsi sulle scelte ‘interpretative’, tanto a livello sonoro, quanto, eventualmente, musicale.
La discussione si sposta, cioè, dalla forma del significante al canale che il codice sceglie per la sua trasmissione e dunque alle modalità di ricezione che esso implica. Che è, anch’esso, problema integralmente estetico.
Il ritardo con il quale, un po’ in tutto il mondo, si sta prendendo atto del fatto che ormai la poesia sta tornando ad allontanarsi dalla letteratura è di grave ostacolo all’inizio di una riflessione seria sulle forme dei linguaggi impiegati e dei rapporti che essi stabiliscono con la voce e, eventualmente, con la musica, nel senso che questo ritardo sfavorisce ogni chiarimento a proposito del fatto che, una volta stabilito che la poesia è un’arte della voce, o per dirla con Zumthor, che in poesia «non c’è parola senza voce», occorrerà poi tornare ad interessarsi delle forme (linguistiche, sonore, eventualmente melodiche e musicali) che essa assume, una volta allocata la sua trasmissione nuovamente in questo canale.
#5
Ma, al di là di queste questioni, ciò che appare evidente è il bisogno per la poesia, in questo presente, di ricalibrare le distanze con il romanzo, sfuggendo al suo abbraccio mortale e riaffermando la sua sostanziale estraneità agli steccati letterari in cui essa è rinchiusa in così incomoda compagnia.
La scrittura viene decodificata in silenzio piuttosto tardi nella storia dell’uomo, ma la poesia si ostina poi ancora piuttosto a lungo a richiedere per sè una fruizione mediata da un’esecuzione, poiché tutto ciò è connaturato al suo stesso essere ritmo e prosodia, la poesia è – da questo punto di vista – l’ultimo ostinato difensore dell’oralità nei lunghi secoli del silenzio che legge e non pronuncia più.
Oggi che l’orecchio torna a far valere i propri diritti nei confronti dell’occhio, la poesia – almeno quella più avvertita del presente – non vuole perdere l’occasione di uscire dal suo fortino, di smettere di resistere, per cominciare di nuovo a camminare verso il centro dell’immaginario e del pensiero umano.
Chi volesse confrontare il progressivo restringersi dell’interesse nei confronti della poesia, -tanto a livello di massa, quanto a quello delle élite – con il suo progressivo farsi segno, con-segnarsi (letteralmente) alla carta, si troverebbe di fronte all’evidenza di un’incontrovertibile relazione.
Ritirandosi dall’ambito ‘politico’, rinunciando al pubblico, in favore di una dispersa moltitudine di lettori silenziosi, la poesia si fa evanescente, costretta com’è ad entrare in concorrenza con gli altri generi ‘letterari’, dal racconto, al romanzo, al saggio, nelle loro infinite variazioni; generi nati scritti, generi per i quali la lingua scritta è lingua madre, non lingua seconda, come nel caso della poesia.
Il processo è lungo e non è questo il luogo per illustrarlo con la minuzia che richiederebbe. Certo è che a inizio Novecento, quando essa non si mascheri dell’oratoria trombona di D’Annunzio, la poesia è ormai silente e ghettizzata, né le rappresaglie avanguardiste, da Farfa, a Majoakvskyi, a Dylan Thomas, passando da Schwitters, riusciranno a liberarla delle sue catene di carta, laddove invece ciò riuscirà benissimo per le altre arti, che muteranno sensibilmente le loro forme. Tutte.
Ma per la poesia, come sottolineato prima, non era solo questione di forme, era faccenda di medium…
In poesia il Novecento resterà globalmente Novecentista (e decadente e simbolista), troppo dura era la battaglia da combattere, troppo alta la posta in gioco, troppo violata e incistata di inchiostro era, ed è, la carcassa della poesia.
Sanguineti, che è stato certo tanto grande innovatore e sperimentatore, quanto poeta integralmente letterato, tanto da esser felicemente librettista, diceva spesso che sbagliava chi sosteneva che oggi si legge poca poesia: non se ne è mai letta tanta quanta se ne legge oggi, chiosava, grazie alla scolarizzazione di massa.
Aveva ragione. Indiscutibilmente. Peraltro, poiché nelle scuole ciò che si insegna è poesia ‘muta’, totalmente letterarizzata, ciò significa che quest’arte, da luogo del desiderio, del divertimento, dell’emozione, della vita, s’è fatta luogo del dovere, della costrizione, archeologia che non sa più trasformarsi in immaginazione.
Un’ottima autrice di poesia per bambini, che da anni è attiva nelle scuole, Chiara Carminati, nota al proposito: «avete mai provato a entrare in una classe di bambini piccoli, poniamo della scuola dell’infanzia, e a dire: “Oggi facciamo poesia”? Otterrete una reazione uniforme: sorridono, si agitano sul tappeto, mettono già in movimento mani e piedi nell’idea di un ritmo che verrà. Provate a fare la stessa cosa qualche anno dopo, in una quinta elementare: al suono della parola “poesia” le spalle si afflosciano, le guance sbuffano, gli occhi guardano di lato prendendo un’espressione vagamente delusa», per concludere, poco più avanti « Cos’è successo in mezzo? Come mai l’entusiasmo dei piccoli si è convertito nel disinteresse, quando non nel disprezzo, di bambini annoiati e rassegnati al peggio? Qualcosa si è interrotto. Si è perso il gioco, si è persa la condivisione: la festa della voce, che dà vita alle filastrocche e alle rime per il corpo, prime forme di poesia con cui il bambino viene a contatto, si è spenta. È diventata parola scritta, parola faticosa da decifrare in lettura silenziosa. La poesia, nata per sola voce, lungo la strada della scuola ha perso la voce».
La perdita di importanza della poesia nella cultura occidentale è, peraltro, evidentemente sempre più marcata man mano che anche l’arte delle parole tende a trasformarsi in merce e cioè dal momento in cui essa si identifica sempre più totalmente ed intimamente con il libro (e dunque con il romanzo).
Pur essendo la performatività ovviamente altrettanto mercificabile e riducibile a puro valore di scambio, per altro verso il libro, la sua produzione seriale, il suo essere un ‘oggetto’ e non un evento, hanno indubbiamente facilitato un processo in cui, all’indomani del suo farsi completamente letteratura, la poesia si è ritirata in un ambito ancora più elitario di quello già di per sé piuttosto angusto della fruizione borghese del romanzo, silenziosa e fortemente grammaticalizzata, una fruizione in cui non basta ascoltare, ma bisogna saper leggere (e dunque scrivere, anche se le due abilità storicamente hanno tempi di sviluppo piuttosto differenziati).
Il suo essere radicalmente inadatta a sopportare una grande intensità di valore di scambio, ha poi fatto sì, in ragione delle sue vendite pressoché inesistenti, ieri come oggi e probabilmente domani, che essa accettasse di buon grado la sua marginalizzazione, risarcita in qualche modo dal suo sdegnoso auto-identificarsi come luogo del valore d’uso (inteso, a priori, quale bene spirituale, o etico/politico) per eccellenza.
La quota d’ipocrisia, di falsa coscienza, presente in tutto ciò è, credo, piuttosto evidente.
D’altra parte, l’avanzare delle tecnologie e dei processi di sviluppo capitalistico, nel loro rendere sempre più immateriale il valore e, in buona misura anche le merci cui questo valore si riferisce, hanno fatto sì che, per tentare di uscire dal ghetto in cui si era auto-rinchiusa, la poesia non ha potuto affidarsi ad altro che non fosse la ‘vendibilità’ dell’immagine virtuale di questo, o quel poeta, al trasformarsi del poeta in ‘personaggio’, in un’inebriata rincorsa al biografismo, dove non è un caso se a trionfare sono state poi le scritture più esplicitamente lirico-simboliste e/o orfiche (penso, uno per tutti, al caso di una poetessa che a me pare globalmente piuttosto mediocre, come Alda Merini).
Per gli altri è rimasto il ghetto, per i più furbi tra loro il feudo, spesso anche abbastanza ampio, dove regnare, appollaiati dietro la scrivania della direzione di questa, o quella collana di poesia, tra cataste di libri impilati, garantendo alla ‘letteratura’ che mai e poi mai la poesia avrebbe osato fuggire dagli steccati che la ‘società di carta’ le aveva costruito intorno.
#6
Tutto ciò accade ormai in un quadro di generalizzata ‘migrazione’ delle arti.
Nell’epoca del ritorno (ahimè infausto) delle migrazioni di massa, anche le arti migrano. Migrano in ogni senso.
Intanto migrano materialmente, nel senso che la loro circolazione, grazie alla possibilità ora estesissima della loro ‘virtualizzazione’ e digitalizzazione, è divenuta fulminea, perpetua, irrefrenabile, pletorica.
Migrano, poi, abbandonando vecchie forme, mutandole, come fossero pelle di serpente, iniziando a percorrere sentieri mediali sempre diversi.
Migrano anche fisicamente, con il migrare degli artisti, anche degli artisti che non si limitano a spostarsi, ma che letteralmente migrano, fuggono dalla loro terra e innestano le loro culture e le loro Weltanschauung, le loro lingue, in ambiti e contesti completamente differenti.
Migrano e migrando le arti s’incontrano, si mescolano, s’influenzano, si accoppiano, o definitivamente si dividono.
Dalle espressioni multimediali, allo slittare delle forme su nuovi supporti (spesso digitali), dagli incontri tra discipline fino a ieri lontane (i Poetry- Comix, ad esempio, o la video-poesia, per restare nell’ambito che qui interessa), a veri e propri sandwich multimediali, o allo sviluppo delle arti performative, costitutivamente polidisciplinari.
La poesia, per quanto la riguarda, è arte migrante per eccellenza, da sempre il poeta si sposta da un luogo all’altro per leggere i propri versi, immobilizzato solo per alcuni secoli, legato, alla sedia dello scrittoio, come il prigioniero alla sua catena, dal peso del libro che poi si muove in sua vece, relegandolo nel cul de sac letterario che ha fatto di lui un autore incapace di eseguire la sua stessa arte, o, peggio, addirittura inutile, o pleonastico per la sua realizzazione pratica, per la sua trasformazione in atto.
Da questo punto vista i Festival di poesia costituiscono una vera e propria svolta nella storia delle forme di ricezione della poesia (ma, evidentemente, per conseguenza delle forme della sua espressione), tornando a far migrare il poeta.
Anche in questo caso, però, la poesia ha una sua singolarità: mentre le altre arti, nell’incontrare le tecnologie contemporanee hanno fortemente mutato le loro forme, accedendo a territori estetici mai prima battuti, la poesia invece è migrata tornando verso la sua vera casa, l’oralità.
Come ho già avuto modo di sostenere, la nascita e lo sviluppo di una serie di tecnologie e media (dal primo registratore, o fonografo, su fino agli amplificatori contemporanei, ai sintetizzatori, campionatori, vocoder, e persino ai sistemi MIDI di registrazione e riproduzione informatica dei suoni) hanno avuto sulla poesia e sui poeti una conseguenza strana, paradossale, riportando, per alcuni versi, quest’arte ai suoi primordi di pura oralità, col risultato di provocare uno strano mix di arcaico e ultra-tecnologico, di sciamanico e insieme cibernetico, di pre-chirografico e post-linguistico.
La poesia ritorna oggi nei territori in cui si parla la sua lingua madre: quella del suono (e del corpo).
Poesia scritta (lineare), spoken word, spoken music, o poesia per musica, sono, da questo punto di vista, non differenti ‘stili’ poetici, quanto luoghi (sin anche nel significato di tropi) diversi nel millenario percorso di migrazione di quest’arte.
#7
A questo punto, però, occorre esplicitare meglio ciò che si intende quando si parla di poesia orale, o, meglio, nel nostro presente, di spoken word e/o spoken music.
Affinché il lettore possa dunque intendere con chiarezza ciò che intendo, propongo due veloci definizioni, schematiche come sono tutte le definizioni, ma spero in qualche modo utili allo sviluppo di questo nostro discorso.
Se non altro si comprenderà ciò a cui mi riferisco io, quando parlo di spoken word, o spoken music, se invece esse saranno addirittura apprezzate da taluno, chissà che non si faccia un po’ di chiaro nelle nebbie.
Potremmo, ad esempio, metterci d’accordo su una definizione dello spoken word che reciti: è quel particolare tipo di poesia contemporanea nella quale le caratteristiche dell’esecuzione vocale che ne dà il suo autore sono parte integrante delle qualità formali di tale poesia e, per molti versi, anche del testo stesso di quella poesia.
Detto questo, la spoken music (la ‘poesia per musica’, se preferite) sarebbe quel particolare tipo di poesia contemporanea nel quale un testo è accordato (temperato) ad una musica originale e in cui le caratteristiche formali dei suoni, della melodia e dei ritmi musicali e il rapporto da essi stabilito con la vocalità del poeta (a livello sia melodico, che ritmico-prosodico) e con gli aspetti ritmici, prosodici e melodici del testo in sè, sono parte integrante della qualità formali di detta poesia e, per molti versi, anche del testo stesso di quella poesia.
O, se preferite, di tale mèlos: «unione, in un sol corpo, di parola (lógos) musica (armonía) e ritmo (rhythmós)» [La Via].
In tutti e due i casi di queste «orature» [Hagege] il poeta contrappone alla «chiusura» del testo scritto [Zumthor] l’apertura sonora della parola che si fa voce, l’eventualità dell’atto performativo.
Va detto, però, che, a mio modo di vedere, questo tipo di espressioni poetiche hanno in realtà ormai poco a che fare con la ‘tradizione dell’Avanguardia’, con quella ‘poesia sonora’, che per anni ha valorosamente difeso la bandiera dell’oralità in poesia, pur condividendo con essa la scelta di tornare a ‘dire’ la poesia, di ricollocare il corpo del poeta, la materialità della voce, lo scorrere del tempo al centro dell’atto poetico.
La poesia non ha a che fare solo con le parole, ma più precisamente con la sintassi, cioè con i significati e dunque, in ultima istanza, con le parole: se, come prima ricordato, in «poesia non c’è parola senza voce», per altro verso, a mio parere, in poesia non c’è voce senza parola.
La poesia è là dov’è, non soltanto un suono, ma anche un senso e tutti i suoi significati, cioè una transazione linguistica nella sua pienezza e ciò proprio perché per questo essa è nata, per trasportare, ‘tradurre’, informazioni e significati, essa è sempre stata insieme memoria e comunicazione, significato e suono, senso ed espressione.
D’altra parte lo stesso Zumthor, nell’analisi di ciò che egli chiama ‘opera vocale’ sottolinea come «parola poetica, voce, melodia (testo, energia, forma sonora) uniti attivamente nell’esecuzione, contribuiscono all’unicità di un senso […]. È al livello del senso che viene suggellata l’unione: il senso ne costituisce la garanzia. Il resto ne deriva di conseguenza».
Evidentemente, ciò escluderebbe dall’ambito poetico una serie di sperimentazioni strettamente vocali, magari di livello eccelso, che partono dalla voce per tornare alla voce, splendidi esempi di arte performativa, ma che in realtà restano estranei a ciò che qui io sto chiamando ‘poesia’.
Della stessa opera di Henry Chopin, solo una parte potrebbe rientrare negli steccati appena eretti, e più in generale il problema si pone con evidenza anche per una serie di opere di ‘poesia concreta’, laddove l’attenzione al supporto è tanto approfondita da escludere, o limitare fortemente l’aspetto comunicativo/espressivo.
Continuo a credere, ad esempio, che le Diplofonie di Demetrio Stratos siano esempi mirabili di arte musicale, vocale e performativa, ma continuo, nondimeno, ad avere seri dubbi sulla possibilità di considerarle, tout court, poesia, anche se evidentemente Stratos è uno dei maestri della ‘poesia sonora’ e del suo aspetto più radicalmente ‘concreto’.
Ad altri aspetti del ‘concretismo’ conviene piuttosto rivolgere oggi la nostra attenzione, a quello brasiliano di Haroldo ed Augusto De Campos, capaci, pur restando integralmente ‘poeti’ di influenzare attivamente lo sviluppo non solo della poesia, ma sin di tutta la NMPB e dunque dell’espressione artistica più popolare e diffusa del Brasile; o anche al magistrale lavoro di Horacio Ferrer, che, cavalcando il Tango con la complicità di Astor Piazzola, ha saputo creare indimenticabili poesie che oggi fanno parte della tradizione ‘tanguera’ più alta, o a John Giorno, che letteralmente compone le sue poesie con il suo respiro e l’energia del suo corpo e della sua voce, modellando con essa le sue parole.
In ultimo, credo sia importante riflettere anche su un altro aspetto della questione, che riguarda direttamente le differenze e relazioni tra oralità e scrittura nelle società medializzate.
Com’è ampiamente noto, le differenze tra testo scritto ed oratura sono molteplici, prima di tutto la «non reversibilità» di quanto è oralizzato, la sua impermanenza, il suo caratterizzare una transazione comunicativa effettuata in praesentia.
Tutto ciò, e a questo ha dedicato una serie di importanti riflessioni lo stesso Zumthor, è profondamente mutato con la nascita degli strumenti di registrazione e riproduzione del suono: quest’evento ha completamente cambiato le carte in tavola.
Essi permettono anche alla voce di impossessarsi di buona parte di quelle qualità prima possedute solo dal supporto scritto.
La voce si ‘stabilizza’, diviene ‘reversibile’, la sua durata si espande enormemente oltre quella sua esecuzione, ogni performance può divenire, ipso facto, testo, sia pure testo magnetico, o digitale, infinitamente riproducibile e fruibile.
Non solo: essa, o parti di essa, possono diventare materiale per costruire nuovi organismi artistici, possono essere campionati, citati, mescolati, esattamente come avveniva ed avviene per i testi scritti.
Un processo simile è accaduto anche in campo musicale: prima dell’invenzione del disco i compositori, come i poeti, pubblicavano libri (di madrigali, mottetti, messe, sinfonie, sonate, ecc.) che erano l’unico modo per supplire a quelle ‘mancanze’ che l’oralità scontava nei confronti della scrittura.
Ovviamente, dal momento in cui l’uomo ha scoperto come conservare e riprodurre il suono tutto è cambiato.
Oggi il target delle partiture a stampa è sostanzialmente limitato ad esecutori ed interpreti, mentre la massa del pubblico, ma anche l’elite di consumatori colti, di specialisti, si affida al disco, o a qualsiasi altro strumento di riproduzione sonoro, che permette di confrontarsi con la materialità attuale di un’esecuzione.
Dallo scripta manent, verba volant, antico adagio classico, insomma, in un mondo in cui la digitalizzazione dello scritto lo moltiplica all’infinito, in cui la proliferazione di ipertesti, che non si ripetono mai uguali a se stessi, lo rende volatile ed assolutamente instabile, si è, in un certo senso, passati nel tempo del verba manent, scripta volant…
Cosa ci sarebbe di strano, dunque, se un processo simile, prima o poi, si mettesse in moto anche per la poesia?
Da anni sostengo che non c’è niente da stupirsi di fronte alla povertà del mercato di libri di poesia.
Si tratta di prodotti estremamente specializzati, peraltro incapaci di porre il fruitore di fronte alla realtà del testo ‘in atto’, e dunque necessariamente limitati a nicchie piccolissime. Ci sarebbe da stupirsi del contrario. Né credo che ci sia soluzione a questo problema, che poi, a mio modo di vedere, problema non è, visto che la poesia nei libri sta stretta, imprigionata da lacci e bavagli che la costringono al silenzio.
Ma se tutto è di nuovo cambiato nei rapporti tra orale e scritto, allora dovremmo piuttosto aspettarci che la poesia si confronti con altri ‘mercati’: quelli del suono, inciso o digitalizzato, concreto, o liquido che sia.
Tutto ciò è un processo storico e antropologico indipendente dalle volontà e dalle scelte formali dei singoli: è un contesto e come tale andrebbe affrontato.
#8
Una delle ragioni per le quali la poesia ‘muta’ e gli integerrimi custodi della letteratura, i critici letterari e i filologi, hanno avuto cura di rifiutare con costante fermezza ogni rapporto possibile tra poesia e musica, pur dinanzi all’evidenza storica di un dialogo costante e di una condivisione sentita a lungo come necessaria da entrambe le arti, è probabilmente proprio il bisogno di cancellare ogni memoria di un rapporto che, al solo ricordarlo, avrebbe posto di nuovo la poesia di fronte alla sua natura sostanzialmente orale e sonora.
Per altro verso, molti musicologi hanno storto il naso, intimoriti dal dover rinnovare il loro strumentario – spesso ormai squisitamente musicale – con nozioni e attenzioni strettamente linguistiche e ‘letterarie’.
Se si pensa alla competenza metrico-prosodica, ma anche ‘musicale’, del Carducci, nell’analizzare, ancora alla fine del XIX secolo, i generi ‘misti’, dal Medioevo sino al Romanticismo, si resterà stupefatti di tale impoverimento dello strumentario ermeneutico della critica attuale.
In Italia, poi, la divaricazione tra poesia e musica ha una storia tutta particolare e particolarmente aspra, così come sostanzialmente noncuranti l’una dell’altra sono state le due corporazioni dei filologi e dei musicologi, almeno a partire dai primi del XX secolo.
Con tante eccezioni, ovviamente. Ad una di queste, a quella di Nino Pirrotta, musicologo insigne, che ai rapporti tra musica e poesia ha dedicato decenni di studio, sui cui sentieri mi ha condotto la mano ferma di Stefano La Via, che molte intuizioni del primo ha poi coerente sviluppato, ritornando ad interessarsi con competenza ed acume di entrambi i versanti del problema, farò esplicito riferimento nelle righe che seguono.
E’ tutta italiana, intanto, la polemica dell’Arcadia contro il melodramma ‘serio’, accusato di occupare territori che gerarchicamente gli sarebbero stati vietati, una discussione che di fatto renderà dogma ciò che era solo faccenda di gusto, ma c’è dell’altro, che a mio parere ha avuto ed ha ancora una grande influenza sull’atteggiamento di gran parte della critica letteraria e musicale.
Mi riferisco alla tesi del Contini studioso del Petrarca (poi ripresa, approfondita, ribadita da Roncaglia) secondo il quale uno dei meriti dei poeti della Scuola siciliana sarebbe stato proprio l’aver sancito «il divorzio così italiano (onde poi europeo) di alta poesia e di musica […] l’iniziativa, tanto vivace rispetto ai provenzali classici, d’avere in tutto disgiunta la poesia dalla musica».
La tesi è, però, come ampiamente dimostrato da Pirrotta, del tutto apodittica e fa una certa impressione a rileggerlo ora, quel “così italiano” che avrebbe certo fatto rabbrividire il De Sanctis, così come resta un mistero cosa il Contini trovasse di «vivace» in un divorzio che esiliava la poesia dal suono e dalla voce, relegandola all’immobilità del segno scritto.
Basti pensare al Dante del De vulgari, che ancora registrava come assolutamente possibile l’esecuzione di poesia ‘soni modulatione’, cioè insieme con musica.
Nota al proposito Zumthor, affidandosi anche all’autorevolezza di studiosi del ritmo come Henri Menschonnic che «l’idea di poesia esposta nel Convivio e nel De vulgari eloquentia si fonda sul ricordo di uno spazio vuoto in cui è sorta, il primo giorno, la sonorità pura di un dire, anteriore all’articolazione, materializzandosi poi, in una frase immaginaria, sotto la forma del concerto vocalico a-e-i-o-u… che in latino assomiglia alla prima persona di un verbo». È evidente, dunque, quanto ancora per Dante il concetto di poesia fosse legato alla concretezza della voce e non a caso egli nel De vulgari parla della creazione di una poesia come di una ‘composizione’.
Colpisce, oggi, rileggere anche un passo del citato Pirrotta sull’Arcadia, in cui a me pare di poter individuare la matrice di tante posizioni schiettamente conservative e corporative che sono ancora di circolazione comune: «dall’Arcadia in poi grava sulla letteratura italiana l’ombra di un persistente pregiudizio che, facendo aurea eccezione per la poesia cantata di tipo trovadorico, tende a considerare come inferiore ogni poesia destinata ad associarsi con la musica». Già: proprio così.
Né si potrà negare che da atteggiamenti del genere non sia stata esente la stessa poesia sperimentale e della Neo-Avanguardia, almeno nel suo aspetto più conosciuto, che pure voleva se stessa profondamente anti-Arcadica.
Per altro verso, nel corso dei secoli, i generi ‘misti’ hanno visto un impoverimento progressivo delle qualità del testo poetico, che ha fatto sì che molti di essi migrassero definitivamente in ambito musicale.
La stessa ‘forma canzone’, così come noi la conosciamo oggi e per come essa è praticata da un ventaglio vastissimo di autori e interpreti è, con buona probabilità, una di queste.
Peraltro già dal Quattro-Cinquecento il rapporto tra musicisti e poeti è sostanzialmente interrotto e i madrigalisti preferiscono pescare i loro testi dal ricco e prezioso serbatoio dei secoli precedenti, da Petrarca e Boccaccio, ad esempio.
Per altro verso, si dice, soprattutto dal versante musicologico, che ogni rapporto tra poesia e musica sia inopportuno, perché la poesia avrebbe già in sé la sua ‘musica’, a cui giustapporne un’altra non sarebbe di giovamento.
Giusto: la poesia ha certamente una sua musica, una sua ritmica, una sua melodia, ciò che non è chiaro, però, è perché mai non dovremmo eseguire quella, anche vocalmente e strumentalmente.
D’altra parte il lavoro del poeta si aprirà, a quel punto, alla collaborazione di altri, che pur arrivando in un secondo tempo, saranno decisivi nel rendere concreto ciò che è ancora un semplice testo linguisticamente codificato, almeno nella misura in cui il poeta non voglia, o non sia in condizione di comporre da se stesso la musica per i propri testi ed orature.
Tutto ciò non mette soltanto in crisi il concetto di autore in poesia (con tutta la problematica che ne consegue, in primo luogo per quella che chiamiamo usualmente ‘poesia lirica’), ma coinvolge il processo stesso della nascita dell’opera [Zumthor] affidando al poeta propriamente inteso non solo un ruolo ‘creativo’, ma una funzione di ‘arrangiamento e temperamento’ da cui dipende in buona misura tutta la qualità complessiva della poesia, indipendentemente della qualità dei suoi elementi singoli (testo letterario, esecuzione vocale, musica, ecc..).
Va chiarita, a questo punto, una volta per tutte, una questione, qui in Italia centrale nello sviluppo di questo dibattito: il rapporto tra poesia e cosiddetta ‘canzone d’autore’.
Da anni si sprecano sull’argomento fiumi d’inchiostro in una singolar tenzone testardamente capace d’ignorare i termini essenziali in cui, in realtà, sta la questione.
La discussione resta pendolarmente prigioniera tra coloro che, nel negare ogni valore poetico alle composizioni di questo, o quel cantautore, in realtà tengono soprattutto a riaffermare una superiorità della parola scritta (e della poesia) nei confronti della canzone, e chi invece, con superficialità pari alla supponenza altrui, si affretta a consegnare patenti da poeta a questo, o quell’autore musicale.
D’altra parte, la confusione che sovrana regna sotto il (nostro) cielo fa sì che bravi cantautori si avventurino spesso nella composizione di brani, o spettacoli, che vogliono poetici, ma che si rivelano, il più delle volte, soltanto mediocri esercizi letterari, in cui, nel momento in cui non è più la musica a dettare il tempo, ma tutto viene affidato alla direzione d’orchestra d’una espressione ‘poetica’ piuttosto claudicante, si perdono anche tutte quelle qualità e quella forza espressiva che le loro canzoni portavano con sé.
Recentemente, un bravo poeta, Valerio Magrelli, polemizzando con l’ipotesi che il premio Nobel della letteratura potesse essere assegnato a Bob Dylan è insorto, sostenendo che Dylan non è un poeta, poiché le sue parole sono accompagnate dalla musica, e dunque giocherebbe sporco, sarebbe un ‘poeta con la protesi’.
Cito letteralmente: «proporre Dylan è un’idea insensata e pericolosa. Ha milioni di fan, si può accontentare senza invadere il campo di altri. Sono due mestieri diversi. Prometto solennemente che non chiederò mai di suonare su un palco. Ognuno al suo posto. La parola cantata è una parola con una protesi. Sarebbe come confrontare un pugile con uno spadaccino. Il Nobel è stato vinto anche da cattivi scrittori, ma scrittori. Dylan non è uno scrittore».
Sorvolando sul singolare lapsus che fa, eventualmente, di Dylan uno «scrittore» non ho difficoltà a concordare sul fatto che il cantante americano non sia un poeta, non concordo affatto, invece, con l’idea che non lo sia poiché di serve della ‘protesi’ musicale, poiché, come visto prima, la poesia si è ‘temperata’ con la musica per secoli e secoli e, con buona pace di Magrelli, ha ripreso a farlo oggidì.
La differenza tra la poesia e la cosiddetta ‘canzone d’autore’ non sta nel fatto che in caso vi sia solo parola scritta, o al limite ‘pronunciata’, e nell’altra anche musica, come ingenuamente (e anche un po’ superficialmente) crede Magrelli, a meno di non voler, di conseguenza, considerare i padri della poesia occidentale e romanza, Arnaud e Rimbaut, per non citarne che due, degli chansonnier ante litteram; essa sta piuttosto nella relazione diversa che si stabilisce tra le due ‘sonorità’, nella differente collocazione delle scelte formali (tanto verbali, quanto ritmiche, melodiche e più complessivamente musicali): a dare il tempo e a suggerire la melodia, in poesia, anche quando essa si sviluppa e si realizza in accordo con la musica, sono le parole; nella canzone d’autore, invece, è la musica a ‘concertare’ il tutto, e questa è la ragione per la quale i testi delle canzoni, senza musica, non stanno in piedi, mentre quelli della spoken music, se è buona spoken music, sì.
Non si tratta, si badi, di rapporti gerarchici, ma di funzioni differenti: semplicemente in poesia è la parola a ‘dettare il tempo’ e a intonare la melodia.
Insomma, se De Andrè non è un poeta, se non lo è neanche Conte, o de Gregori, o Fossati, ciò non dipende dal fatto che nel loro lavoro sia presente la musica, cioè da un surplus musicale, da una protesi in chiave di violino, quanto, all’opposto, dal fatto che nelle loro canzoni non c’è un linguaggio capace di stabilire e dettare autonomamente i propri ritmi e la propria linea melodica.
Un enunciato linguistico è percepito come poetico proprio a partire dalla sua musicalità, dal suo ritmo, dalle caratteristiche metriche e prosodiche, sovrasegmentali.
Provate allora a spogliare codeste ‘poesie in musica’ di molti dei nostri cantautori (che spesso sono splendide canzoni, canzoni che io stesso amo profondamente) dalla loro melodia, dal ritmo che dona loro la musica, provate a leggere quei testi in silenzio, o ad alta voce, ma seguendo la loro propria prosodia: ciò che vi rimarrà tra le mani è ben poca cosa e questo vale anche per molti dei più noti autori, da Conte a De Gregori, Fossati, Capossela, Caparezza, per non parlare del mediocre e sin troppo celebrato Vecchioni, o di tanti noti rapper.
Questo vale anche per De André, certamente il più importante tra i cantautori italiani degli ultimi decenni, che non a caso rifiutava per sé l’etichetta di poeta, preferendo, con grande acribia, attribuirsi un ruolo di «ponte» tra poesia e canzone d’autore, impegnato com’era a traghettare nel mondo della musica grandi testi poetici, da Alvaro Mutis ad Edgar Lee Master. Alcuni dei suoi testi hanno questa capacità di stare in piedi, autonomamente, anche senza musica, ma sono eccezioni (penso qui alla Domenica delle salme, o al Bombarolo, o al limite alla melopea struggente di Amico fragile), mentre altri, magari proprio quelli di capolavori della canzone d’autore, come La storia di Marinella, o Bocca di rosa, francamente no.
Insomma Bob Dylan (o Capossela, o De Andrè, ecc. ecc.) non sono poeti, assolutamente no, ma non perché abbiano per sé un surplus di musica, che fa di loro ‘poeti con la protesi’, come suggerisce Magrelli, quanto per difetto di caratteristiche e qualità ‘letterarie’. E la differenza non è di poco conto.
Ciò non toglie che molti di loro siano artisti di primissima levatura, ma l’arte che praticano non è la poesia. E in tutto questo non c’entra la musica, c’entra, come sempre in poesia, piuttosto la parola.
#9
A questo punto occorre almeno accennare ad un problema piuttosto complesso, quello che qui potremmo indicare come il problema delle ‘forme dell’esecuzione’.
Nel momento in cui un poeta non si pone come proprio obiettivo soltanto quello di scrivere un testo, ma anche quello di eseguirlo, interpretandolo, e magari di accordarlo, temperarlo con la musica i problemi formali e ‘tecnici’ che gli sorgono davanti sono molteplici e spesso piuttosto complessi.
Le sue scelte vocali, ritmiche e ‘musicali’ avranno, infatti, un evidente valore estetico, tanto quanto quelle strettamente linguistiche.
Nel momento in cui un poeta decide di comporre testi destinati all’esecuzione orale e/o a ‘temperarsi’ con la musica, i suoi problemi tecnici aumentano grandemente, come anche quelli formali: essi non sono più soltanto di natura linguistica, o letteraria, ma anche vocale, ritmica e musicale.
Eseguire un testo di poesia orale, o di spoken music, non ha nulla a che vedere con il semplice pronunciare ad alta voce quel testo.
Zumthor ha efficacemente messo in luce quest’aspetto del problema, sin dal punto di vista storico-antropologico: «la poesia orale comporta generalmente un numero maggiore di regole, e di maggiore complessità, di quella scritta: nelle società a forte predominanza dell’oralità, essa costituisce spesso un’arte molto più elaborata della maggior parte dei prodotti della nostra scrittura».
Da questo punto di vista il ‘temperarsi’ della lingua poetica nel suo trasformarsi in scritto, in testo, non fa che rendere ancor più complessa questa situazione.
Eseguire un testo oralmente, ‘metterlo in voce’ non ha dunque nulla a che fare con il semplice ‘pronunciare’ quel testo.
Intanto poiché, come ha notato Zumthor, «l’esecuzione è l’azione complessa mediante la quale un messaggio poetico è simultaneamente trasmesso e ricevuto, qui ed ora. […]. Nell’esecuzione si intersecano i due assi della comunicazione sociale: quello che congiunge il locutore all’autore, e quello che unisce la situazione alla tradizione. A questo livello gioca appieno la funzione del linguaggio che Malinowsky ha definito ‘fàtica’: gioco di contatto e di richiamo, di provocazione dell’Altro, di domanda, di per sé indifferente alla produzione di un senso».
Al di là di tutto ciò, in ogni caso, come ho avuto modo già di sostenere, perché una poesia viva, occorre che essa sia ‘eseguita’, sia pure soltanto mentalmente.
È ovvio che se si decide di ‘metterla in voce’ non si potrà tradire ciò che, a livello prosodico e non solo, essa presuppone e porta con sé. Se si decide di far vivere quella poesia nella voce, non basterà certo limitarsi a pronunciarla.
Ciò che vedo accadere giorno dopo giorno attorno a me, invece, è esattamente questo.
Tutti i poeti, che pur si affannano a riconoscere alla poesia solo una sostanza silenziosamente ‘letteraria’, non si negano affatto di salire sui palchi e pronunciare le loro poesie.
Basti qui citare, per sineddoche, i nomi di due dei più noti tra loro, Maurizio Cucchi e Milo De Angelis.
I poeti ‘muti’, insomma, sono in realtà dei “muti di guerra”, a voler parafrasare il Gadda della Cognizione, poiché, pur di trovare spazio nella semiosfera mediale, appena possono, parlano di nuovo, salgono sul palco e ‘pronunciano’ la poesia scritta. Operazione ambigua. E’ una menzogna, alla fine della quale nulla più esiste: il testo scritto viene nientificato dalla balbuzie ritmica, melodica e prosodica dell’autore, il testo vocale, l’oratura, non nasce nemmeno: là dove era poesia (poesia muta, se non altro) resta il vuoto di un io che si autopromuove, dimenticando che , in ogni caso, la voce della poesia è sempre la voce del poeta, ma la voce del poeta, invece, non è mai, in sé, la voce della poesia.
L’esecuzione poetica porta con sé, insomma, i medesimi problemi di qualsiasi esecuzione sonora di un codice scritto, ad esempio musicale: essi sono sia esecutivi, che interpretativi.
L’interpretazione non è mai oggettiva e non è mai unica, l’esecuzione al contrario richiede una lettura ‘filologicamente’ corretta del testo, o, se si preferisce, dello ‘spartito linguistico’.
Nonostante la parola abbia assunto una sua forma scritta ben prima della musica, è evidente che in essa non compaiono sufficienti elementi diacritici per indicare una serie di ‘regole d’esecuzione’ che sono invece ben delineati in uno spartito musicale, forse a causa del fatto che la codificazione definitiva delle forme linguistiche scritte e la loro omogeneizzazione, soprattutto a livello ortografico e dei segni diacritici, avviene proprio in sincronia con l’invenzione della stampa e con quella, ben più decisiva, dell’utilizzo della carta per la realizzazione dei libri, con quella che potremmo chiamare la ‘scoperta della carta’, cioè con l’esordio della ‘civilisation de papier’ che Henry Chopin valorosamente denuncia ed attacca in una sua celebre ‘oratura’.
La nascita della lettura muta ha ucciso l’oralità e la maschera di carta dello scritto si è preoccupata di nascondere ogni traccia del delitto appena commesso, limitando al minimo ogni segno che rimandasse all’esecuzione orale e limitandoli a quelli della cosiddetta punteggiatura, cioè a quanto era necessario esplicitare a proposito dell’intonazione, che rimane comunque un dato indispensabile per la costituzione del senso, anche a livello strettamente mentalistico, in prosa tanto quanto in poesia.
D’altra parte la punteggiatura in sé ha poco da dire a proposito di una serie di problematiche esecutive che ne prescindono (volume, velocità, intonazione, ‘intenzione’, tonalità, armonia, ritmo, accento, ecc…), anzi la tendenza ad abolirla del tutto nei testi che sottostanno alle orature non ne è che la presa d’atto, né la semplice esecuzione degli accenti prosodici (laddove essa sia dettata da questa, o quella ‘forma chiusa’) esaurisce in sé le problematiche connesse all’esecuzione orale di un testo.
L’esecuzione autoriale ha perciò, in quanto essa sia disponibile in un qualsiasi record, una funzione indispensabile per la corretta lettura dello ‘spartito’ della poesia, anche se poi l’interpretazione che da altri se ne darà potrà essere diversa e potrà sin prescinderne. L’interpretazione successiva resta certamente libera ed infinitamente variabile (visto che si tratta di un testo artistico, non referenziale), ma essa acquisterà il suo senso solo in quanto, prima di tutto al nuovo esecutore, sia chiaro lo ‘scarto’ di questa dall’esecuzione e dall’interpretazione autoriale, che non funziona certo da ‘princeps’, filologicamente parlando, ma, d’altra parte, resta polo di riferimento essenziale per l’eventuale vita futura di quella poesia.
La riflessione sulle forme dell’esecuzione orale di un testo, specie se esso è nato come oratura, mettono in luce anche un aspetto non secondario della poesia in generale.
Nonostante quanto si crede più comunemente il verso non è affatto la caratteristica fondante della poesia.
Se nel testo scritto esso funziona da ‘marca’ del tipo di scritto che stiamo per leggere a mente, nella sua concreta sostanza sonora e nel suo dispiegarsi temporale il verso perde qualsiasi senso e funzione, mettendo al suo posto quella che potremmo qui chiamare l’esecuzione delle ‘cellule ritmiche ‘ del testo. Se ne era accorto, fin dal 1925 Marcel Jousse, e i successivi studi di Zumthor non fanno che confermarlo.
Per tornare al presente della nostra poesia avevano dunque visto lungo e bene i Noigandres di Haroldo ed Augusto De Campos quando nel loro Plano-piloto para a poesia concreta dichiaravano ufficialmente chiusa l’epoca del verso.
L’esecuzione orale di un testo poetico è, d’altra parte, assolutamente diversa dalla sua interpretazione attoriale, essa è cioè lontanissima da ogni tipo di ‘lettura espressiva’, proprio perché l’interpretazione attoriale tende a privilegiare l’espressione dei significati sull’esecuzione delle linee melodiche e ritmiche del testo, che sono, a mio parere, fondamentali.
Ciò non significa che, a uno strato superiore, o successivo, l’interprete di spoken word non lavori anche su di essi e sulla loro espressione e modulazione, anzi, ma ciò accade solo in un secondo tempo.
Altra questione è poi se dalla ‘messa in voce’ della poesia si intenda esplicitamente passare alla sua ‘messa in scena’, cosa certamente possibile e con esiti a volta eccezionali (penso, ovviamente, a Carmelo Bene), ma la ‘messa in scena’ della poesia non si limita a coinvolgere il corpo del poeta ‘staticamente’, o comunque limitatamente a quella prossemica che per ragioni sin fisiologiche si accompagna alla ‘messa in voce’, ma dinamicamente, mettendo in relazione il corpo e la voce dell’interprete non solo con il tempo, ma con lo spazio e con una serie di stimoli molto più complessivamente visivi, che strettamente sonori.
Ma ciò, inevitabilmente, porta la poesia a diluirsi nel teatro, o, al limite nelle cosiddette arti performative. Nulla di male, ovviamente, io stesso ho provato più volte a ‘mettere in scena’ la mia poesia, soprattutto attraverso la contaminazione con la video-arte.
Bisogna, però, che sia chiaro che quando si parla di spoken word ci si sta riferendo a qualcosa che ha poco a che fare con il teatro, almeno per come esso si è autonomamente sviluppato dal momento del suo divorzio da poesia e musica, o si penserà che l’Opera lirica sia una forma teatrale, prima che musicale, o che un ‘attore’ e un poeta che interpretano un determinato testo su un palco stiano facendo la medesima cosa, mentre, a mio giudizio, è ben evidente il contrario.
La bravura del Bene eccezionale lettore teatrale di Maiakovskyi e Dante, non a caso, fallisce palesemente il suo obiettivo nel tentativo, solo sonoro, di lettura di un poeta come Campana, dove cascami simbolisti convivono con vividi squarci ‘sonori’, sia pure soltanto affidati all’a capo del verso, o alla sonorità delle allitterazioni, o al ritmo dell’anafora logicamente e sintatticamente incongrua.
Ovviamente ciò non significa che l’esecuzione orale di una poesia non possa essere affidata ad altri che non sia il suo autore, anzi. Si dice, più semplicemente, che questo eventuale ‘esecutore secondo’ dovrà porsi una serie di problemi esecutivi differenti da quelli richiesti da un copione teatrale, in prosa, pena la distorsione evidente diei meccanismi formali e di senso che tale testo implica in sé.
La faccenda si complica ancor più se proviamo a farci domande sulle forme dell’esecuzione poetica quando essa decida di ‘temperarsi’ con la musica.
Come sottolineato da una neuropsicologa della musica che sta portando avanti con il suo BRAMS Laboratory (Brain, Music and Sound Research) studi di evidente interesse per chiunque pratichi spoken word e spoken music, Isabelle Peretz, noi siamo, una specie «musicale, tanto quanto una specie dotata di linguaggio (linguistica)» , oltretutto, pur non essendo l’unica specie a ‘cantare’, siamo l’unica ad utilizzare il canto non per ragioni strettamente comunicative, ma estetiche.
Come ho ampiamente esplicitato in precedenza, solo quando viene eseguita una poesia acquista la pienezza del suo significato, in questo senso anche la musica non accompagna la voce e la parola, ma le conferma nel loro senso, ne svela l’aspetto più oscuro, quello che, pur esistendo ed essendo in realtà l’obbiettivo del dire, non è possibile grammaticalizzare, quello cioè che pertiene alla voce, al suono e non alla parola.
Tra poesia e musica, nello spoken music, non c’è accompagnamento, ma ‘accordo’, ‘temperamento’, nel senso più ampio della parola.
Si dovrebbe parlare, cioè, mi si passi la metafora azzardata, dello sviluppo di un contrappunto tra le linee melodiche (e i ritmi) della parola e le linee melodiche (e i ritmi) della musica , tra accenti prosodici ed accenti musicali, tra cursus del linguaggio e melodia musicale, tenendo sempre ben presente che la musica viene (anche temporalmente) dopo le parole e che è essa a doversi temperare nel tutto sonoro e ‘concreto’ che darà vita alla poesia vera e propria.
Ciò vale a maggior ragione poiché una delle caratteristiche formali di entrambe le forme artistiche, il ritmo, pur essendo apparentemente desemantizzato, assume in realtà valenze semantiche evidenti: «il ritmo è senso, un senso intraducibile in lingua con altri mezzi» [Zumthor].
Esiste, cioè, un ‘senso non linguistico’, o, se si preferisce, ‘non alfabetizzabile’ di ogni transazione comunicativa e tale senso è presente – almeno a livello originale, nella ‘motivazione a dire (e a scrivere)’ – in ogni enunciato linguistico, nel suo essere un ‘atto’, ed esso è assolutamente di pertinenza della poesia, prima ancora che di qualsiasi analisi linguistica.
La poesia è precisamente il tentativo di accedere a un ‘senso pieno’ della lingua, e dell’espressione, colmando con i suoi tratti sovra segmentali le lacune della comunicazione linguistica quotidiana e referenziale, di tutte le sue non casuali reticenze, visto che ogni parola è, in realtà, il confine «tra ciò che si dice e ciò che si tace» [Foucault]. A ciò è chiamata a collaborare anche la musica.
Quando musica e linguaggio tentano di fondersi in poesia si tratta, allora, dell’equilibrio difficilissimo di facoltà tanto simili, quanto diverse, il loro ‘accordo’, il loro temperarsi ritmico e melodico, ma anche linguistico e semantico, è il risultato di un progetto accurato, mai può realizzarsi attraverso l’aleatorietà di un qualsiasi ‘accompagnamento’, o la giustapposizione di poesia ‘pronunciata’ e siparietti musicali. Non basta neanche tentare di accoppiare i colori o i toni: l’esigenza è quella di un contrappunto complesso, di un accordo, di un temperamento ben più profondo e ‘strutturale’ tra il livello semantico del linguaggio e quello sonoro, ma altrettanto ‘espressivo’, della voce e della musica. Esiste cioè una necessità compositiva tanto a livello linguistico quanto, ed a maggior ragione, a livello musicale.
L’affermazione del sistema ‘tonale’ in musica, a partire più o meno dal XVII secolo, in qualche modo segna una svolta anche per i rapporti tra questa disciplina e la poesia: laddove le melopee, il canto trobadorico e quello gregoriano, lo stesso madrigale, tendevano ad adattare le forme musicali alla parola e al suo andamento ‘sonoro’, da questo momento in avanti il rapporto si inverte e sono i cursus alfabetici a doversi modellare alle melodie e ai ritmi musicali.
Ovviamente questo rende ancor più complesso il problema di escogitare oggi forme nuove di temperamento tra poesia e musica che siano, però, prima di tutto, esplicitamente poetiche e non esclusivamente musicali (e meno che mai cantautoriali).
Non è questa la sede per la disamina delle differenti strategie sinora messe in atto per raggiungere questo scopo, visto che ciò richiederebbe moltissimo spazio e non potrebbe non partire dall’approfondimento di quanto fatto in prima persona, cosa che sposterebbe troppo il focus generale di questo scritto.
Fatto sta che ciò a cui sono chiamati coloro che oggi scelgono di tornare a percorrere il sentiero che unisce in poesia la parola e la musica hanno davanti un compito impervio dal quale però dipende in buona sostanza il destino stesso della poesia.
Difficile che il cammino giusto possa essere individuato abbandonandosi all’ammiccante aleatorietà di questo, o quell’accompagnamento musicale, o all’adozione di consolatori siparietti musicali che fungano da intermezzi tra atti linguistici che, per parte loro, si limitino oltretutto a pronunciare un testo scritto.
#10
In poesia il problema dell’interpretazione è sempre, prima che un problema ermeneutico, un problema di esecuzione, è una performatività, e solo dopo, eventualmente, esso prende consistenza, diciamo così, critico-letteraria.
Ciò significa che la prima interpretazione di un’oratura poetica è sempre del suo autore.
Senza di essa quel politesto complesso che è l’esecuzione reale (vocale e/o vocale-musicale) di una poesia, semplicemente non esisterebbe nella sua totalità.
L’analisi critica di essa, così come la sua eventuale esecuzione da parte di nuovi interpreti, sono, a mio avviso, ermeneutiche di secondo grado, ma, a causa di questa caratteristica della poesia appena esplicitata, esse hanno, paradossalmente, il medesimo grado (di legittimità), anche per quanto riguarda la formazione di un eventuale ‘canone’. Cosa che, d’altra parte, accade abbastanza normalmente, a mio modo di vedere, in ambito musicale e/o più generalmente performativo (teatro, danza, ecc.).
L’analisi critica riservata sinora alle opere di spoken word e spoken music, oltre che gravata quasi sempre in modo esplicito dal preconcetto arcadico di cui ho discusso appena sopra, anche nei casi degli interpreti più avvertiti ed aperti, è però più o meno costantemente limitata al testo ‘letterario’ e anche quando si fa riferimento non al testo, ma all’opera, cioè alla sua esecuzione reale, esso si limita alla semplice menzione, quasi si trattasse di elementi di puro décor, o al limite a tic di questo o quell’autore che nulla tolgono, in buona sostanza, a quanto ci sarebbe di essenziale e cioè il suo coté strettamente letterario.
Come abbiamo visto le cose non stanno affatto così, glissare, o far finta di nulla, minimizzare, o limitarsi ad interpretare il tutto che è oltre il testo letterario come accessorio, o ininfluente ai fini del giudizio estetico è compiere una sineddoche come minimo imprudente, è leggere con i teoremi dello spazio bidimensionale, un oggetto concreto che è, invece, schiettamente tridimensionale.
Limitare l’analisi al solo testo ‘letterario’, però, non è semplicemente un approccio parziale a un oggetto complesso, ma in sé distorce in maniera schiettamente ideologica l’interpretazione, relegando una serie di tratti dell’opera che non sono affatto laterali o decorativi, quanto invece costitutivi dell’oggetto stesso, nell’angolo della pura ‘evenienza’ che nulla toglie e nulla aggiunge all’analisi più importante che resterebbe così quella ‘letteraria’. Quando, in tante altre sedi, ho lamentato l’assenza di una ‘critica poetica’ mi riferivo esattamente a questo fenomeno.
Una delle ragioni dello scarso successo in sede ‘critica’ delle opere di spoken word e spoken music, di là della loro qualità formale, risiede precisamente in questo: l’incapacità della critica letteraria di leggere un fenomeno tanto diverso e ben più complesso della poesia ‘muta’. L’ostentata noncuranza che la corporazione dei critici letterari riserva alle esplorazioni formali ed estetiche dello spoken word e della spoken music non è che la conferma, a contrario, della sua incapacità a leggere un’opera nella sua integrale complessità, del suo essere rimasta indietro, enormemente indietro, rispetto alle mutazioni e ai progressi effettuati da quell’arte di cui pure dichiara d’essere esperta, la sola legittimata a dettarne i canoni.
Tale incapacità e tale insufficienza sono, tanto formali ed analitiche, quanto storiche ed integralmente antropologiche.
Da questo punto di vista le attuali analisi della poesia orale, gravate come sono dal loro essere innanzi tutto analisi storiografiche ed etno-antropologiche, prima che ermeneutica e critica del presente, pur fornendo materiale prezioso sulle tradizioni e i canoni dell’oralità spesso si limitano ad accennare ai mutamenti della poesia orale nel presente.
Lo stesso Zumthor che pure parla di poesia mediale e/o mediata, poi proietta spesso su questa i tanti dati e conclusioni raggiunti sulla poesia del passato, o comunque in società ‘non mediali’.
Ora è evidente che i mutamenti storici e antropologici sono stati di tale portata da richiedere una revisione degli strumenti e delle categorie critiche utilizzati dai pochi che dedicano i loro studi alla poesia orale e prima di tutto al suo odierno essere ‘opera’ e ‘testo’, nell’accezione che a questi termini dà lo studioso francese.
Chiarire come la poesia orale oggi abbia ben poco a che vedere con la poesia che interessa gli etnologici e come si qualifichi, almeno per quel che concerne, lo spoken word e la spoken music, la poesia per musica, proprio a partire dall’esistenza di un testo di livello alto, temperato, che con le sue melodie e i suoi ritmi in qualche modo detta la musica, è problema della massima importanza.
Ho provato a dare una prima idea dei tanti livelli a cui dovrebbe svolgersi quest’analisi in altra sede, avanzando timidamente la proposta di quattro categorie (durata, ritmo, suono, lingua) che certo non risolvono il problema, né esauriscono i suoi tanti aspetti, ma che pur contengono in esse gran parte dei problemi e degli aspetti sin qui esaminati.
Un’ermeneutica di un’opera plurale come una poesia richiederebbe in ogni caso al suo protagonista una serie di competenze che vanno ben oltre quelle strettamente letterarie, comprendendo aspetti di prosodia, analisi dell’esecuzione, analisi musicale, ritmica e soprattutto la capacità di leggere le tante interazioni che a molteplici livelli si mettono in moto nella composizione e nell’esecuzione di una poesia.
Un primo esempio di quanto intendo può probabilmente essere individuato nell’analisi che Stefano La Via riserva a Can vei la lauzeta mover di Bernart de Ventadorn e, forzando la buona educazione che mi imporrebbe di tacerne, il saggio dedicato al mio ben più modesto Lai lento. In quelle righe si respira un’aria nuova e chi scrive spera che presto altri vogliano aiutarlo in un’opera complessa, ma certamente indispensabile, quella della nascita di una ‘critica poetica’, capace infine di sostituirsi alla ‘critica letteraria’ per quanto riguarda le opere di poesia.
Ma questa poesia di cui andiamo parlando, che chiede a gran voce nuovi ermeneuti, è poi una poesia che, come detto prima, non soltanto riscopre le sue radici, ma, riscoprendole, rivoluziona dalla base le sue scelte formali, tanto quanto le sue più complessive caratteristiche estetiche. E’ una poesia che, nuovamente, migra da un medium ad un altro, dal libro alla voce del poeta, al disco, al supporto digitalizzato. E’ una poesia che dunque si fonda si nuovo.
Ma la critica da tempo adopera ciò che comunemente chiamiamo la storia della letteratura come salvagente capace di ridurre all’interno di un rassicurante sviluppo storicista i tanti cambiamenti e sussulti della poesia: essa cioè è abituata, al più, a leggere una dinamica di sviluppo, mentre si ostina a ignorare che ciò che sta accadendo è qualcosa di imprevedibile fino a ieri, qualcosa di assolutamente nuovo, un oggetto che per essere analizzato chiede a chi lo studia di mettere in discussione prima di tutto se stesso e le categorie su cui fino ad ora ha fondato le sue analisi.
Perché tutto ciò accada occorre però che siano anche i poeti stessi a prendere l’iniziativa, a proporre nuove possibilità, nuovi percorsi, nuove metodologie di lettura e di ascolto delle loro opere, ad interrogarsi sul loro fare, tanto quanto sul loro ‘desiderare’.
I poeti dovranno essere capaci, cioè, proprio a causa dello iato provocato dalla dittatura delle forme ‘mute’ in poesia, durato per secoli, non soltanto di dare la lettura dello svolgersi di una dinamica ‘storica’, ma di caricarsi il peso e la responsabilità del giudizio e dell’analisi di una serie di atti estetici in qualche modo ‘fondativi’. Che è tutt’altra cosa.
Come nel caso di Dante e del suo Convivio, cioè, al poeta resta oggi il compito di comporre le sue poesie, guardando ad un pubblico che ancora non c’è, ma di fare altrettanto anche nei confronti della critica, dell’ermeneutica della sua opera, che anch’essa non c’è ancora, immaginandone una nuova: il poeta dovrà essere, cioè, egli stesso il suo primo ‘interprete’.
Un cammino iscritto, insomma, tra Dante e Deleuze. Un cammino stretto, certo, erto ed irto di difficoltà, al di fuori del quale, però, a mio parere, non gli resta che la sorte dell’epigone, quella del nipotino di questo, o quel ‘novecentismo’, macchia infamante che, tanto ingiustamente, fu affibbiata ai componenti di quel Gruppo ‘93 nel quale, pure a prezzo di tante cadute, superficialità, insicurezze, prendeva vita, invece, molto del nuovo che gli anni successivi avrebbero confermato essere il midollo stesso del nostro presente e mi verrebbe di azzardare del nostro futuro in poesia.
Di tutto ciò questo breve scritto non è che un primo, timido e certamente lacunoso tentativo.