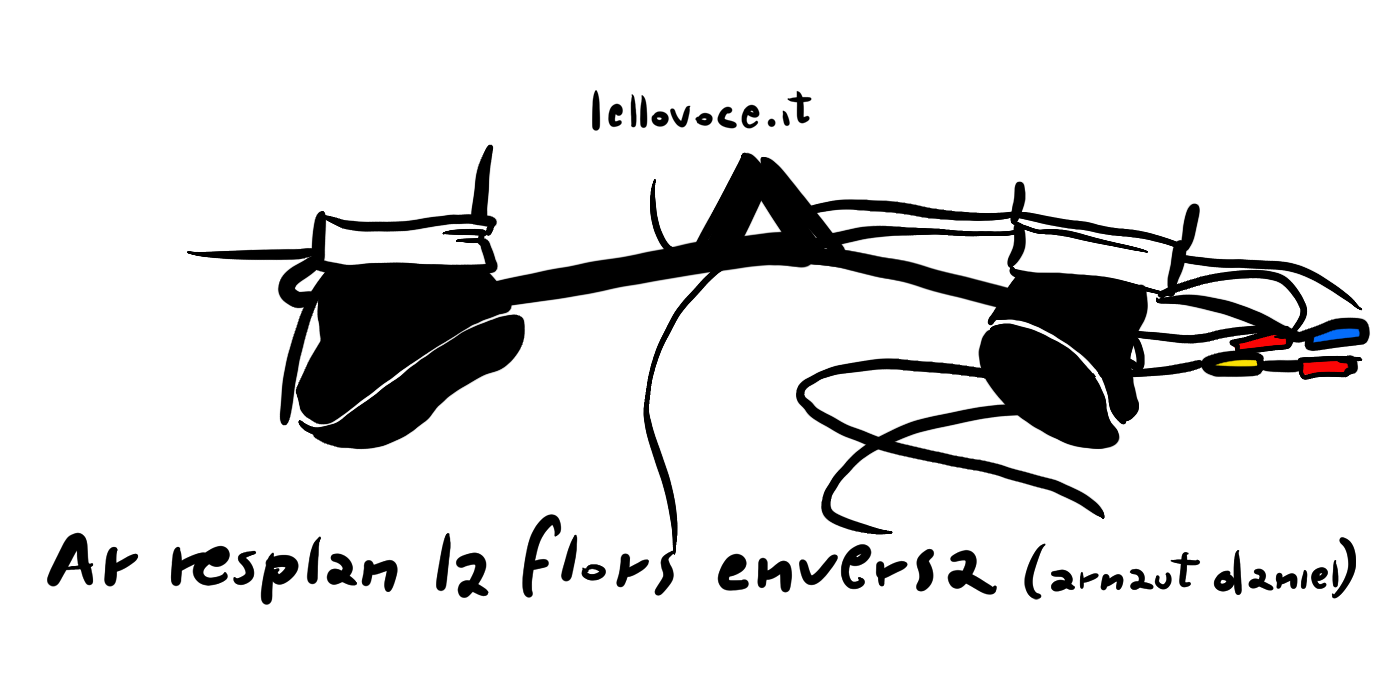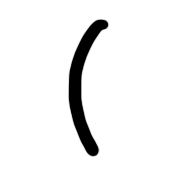Gian Mario Villalta torna alla poesia con un intenso libretto, dall’ossimorico titolo Vedere al buio. Si tratta di una silloge tutta giocata sulla trasparenza formale, che però è solo una pellicola sottilissima che separa il lettore da un’immersione interiore profonda, che a volte ha addirittura il coraggio della spudoratezza interiore. Distillato da una lima accuratissima, questo libro, pur tutto imperniato intorno alla figura del ricordo e del paesaggio, è poi un discorso sul tempo e sul suo trascorrere, sul suo mutare i luoghi, i corpi, le parole. Così accanto a una sorprendente (ma coraggiosa) impronta ‘pascoliana’ e/o crepuscolare, evidente prima di tutto nella scelta dei temi (la morte, il ricordo, il ‘nido’, sia pure un nido che ormai può trovare pace solo in una sorta di ‘dissimulazione onesta’: «(…) ricostruisco la casa vecchia. / E mi inabisso / con i visi e le mani che si pensano, / proprio quando è il momento di riunire / tutti in cucina, con le voci che feriscono / per proteggere, mentono per salvare»; la natura, certe scorie scintillanti del ‘fanciullino’: «(..) finalmente pieno / come un bambino con le scarpe bagnate / di una bella infelicità che non sai cosa dire») ben altro attende il lettore. Perché accanto a questo dolore, prima di tutto privato, veicolo di coscienza e di identità, sta il disegno di un reale condannato ad un presente eterno, che può indurre il poeta sino a desiderare lo scacco, la sconfitta. In questo deserto della durata, azzerata da un brutale istante, che non passa mai, ma si ripete, si distende un deserto di luoghi, spazi sordi, una geografia morente, vuota. In essa, in questo dopo che non c’è, perché è sparito nello stesso istante in cui una società cronofaga divorava il prima, si aggira il poeta, un po’ uccello, un po’ agnello crocifisso: «Camminiamo come uccelli sul piazzale. / Legno nelle braccia lungo i fianchi.»
Completamente diverso è invece la seconda raccolta di poesia di Massimo Rizzante, Nessuno. Rizzante realizza, con questo testo di grande complessità, un’esemplare architettura di temi e forme, tutti giocati intorno al nucleo duro e affilato di un dolore, a volte addirittura di uno sbigottimento ‘civile’ che trasforma la voce del poeta in quella del disilluso testimone cui solo un’inarrivabile distanza dal mito, un’immersione senza limiti nel disincanto (e nel dis-canto) impedisce di trasformarsi in arte della vendetta e del sogno. La figura di Telemaco ne è l’emblema, con le sue radici classiche che risuonano in armonica con i rimandi al più spericolato degli sperimentatori della parola, Joyce e il suo Dedalus. Rizzante trascorre con acrobatica e raffinata abilità da un registro all’altro: ai versi lunghi si alternano quelli più brevi, e fin un lampo di poesia concreta, alcune ‘prose’, unisce ai suoi testi ‘transcreazioni’ di Seferis e Oscar V. de L. Milosz (a dimostrazione che sempre il futuro dei versi è nella loro capacità di essere anche il ventriloquio di molteplici tradizioni), mentre i temi, in un caleidoscopio ordinatissimo, sciorinano sotto gli occhi del lettore un campionario stringente di occasioni mancate, di contraddizioni, aporie. Che si tratti del rapporto ormai impossibile, con la memoria e con la storia («Non è più l’epoca che dialogava con i morti / (…) / Se poi la vita è mettere radici, / allora io non sono mai vissuto»), o invece di un più ‘politico’ e quotidiano j’accuse a questa Italia da «lap poetry» («Mi resta solo questa ex repubblica dei limoni / vivaio di gerarchetti e pater nostri, / paradiso terrestre per chiunque cammini a quattro zampe, / penisola di ignoti militi a se stessi»), che l’obbiettivo sia stretto sui destini della specie, o che invece sia piuttosto il linguaggio a descrivere paesaggi imprevisti e invisibili a mente nuda di parole («la smania del piolo di diventare scala, / la cieca obbedienza della trottola alle rivoluzioni del globo»), o scene quotidiane attraversate da «studentesse cubiste» e «Calamity Jane del Nuovo Texas» disperse nel deserto di questa nostra «Ex Magna Grecia, / caput mundi, repubblica romanza», la poesia di Rizzante scorre veloce e crudele come una staffilata sul volto della lirica, della melodia, delle facili speranze. Quella di Rizzante è un’arte del distacco esercitata con dedizione assoluta, come se fosse l’ultima strada praticabile per un definitivo e inappellabile coinvolgimento.
Gian Mario Villalta
Vedere al buio
Sossella Ed.
Massimo Rizzante
Nessuno
Manni Ed.