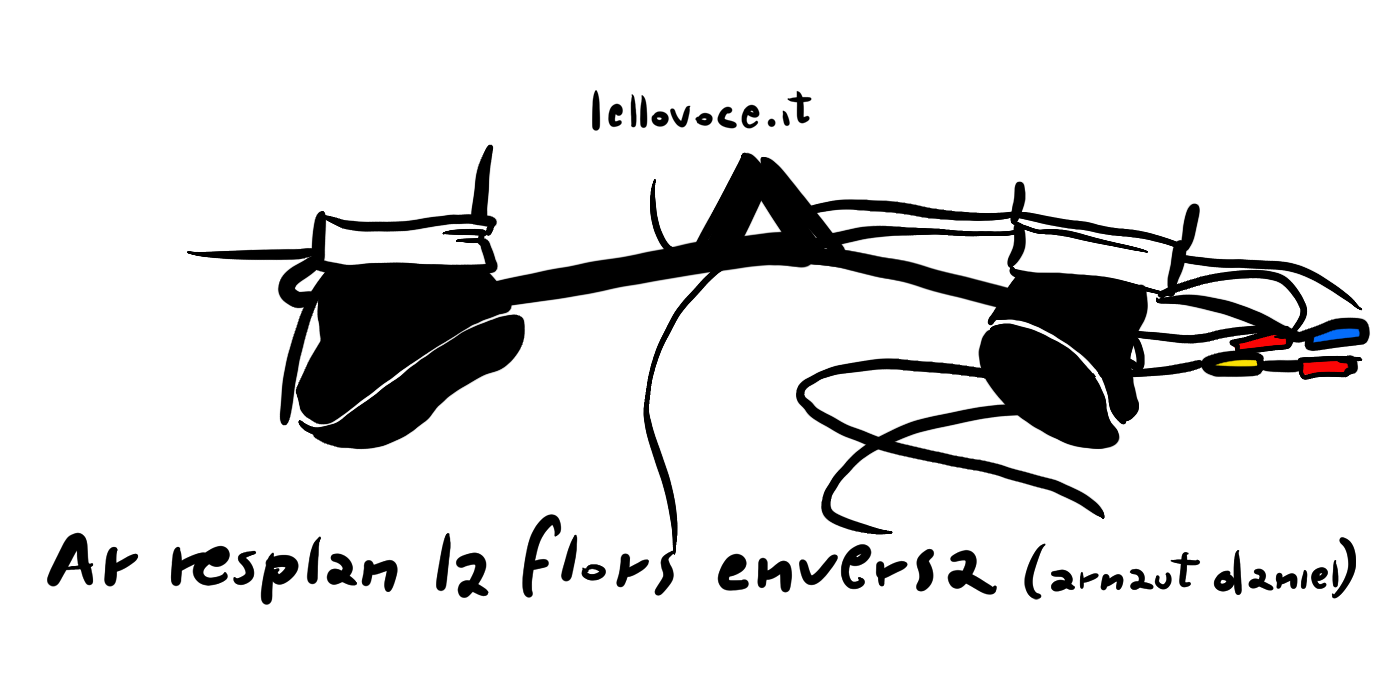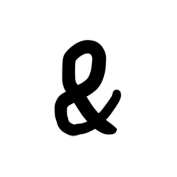LelloVoce: Allora, Marco, io direi di partire dalla fine… da Vajont e da un’impressione netta che ne ho ricevuto. Mi sembra che tu, come me, vada cercando ciò che c’è d’essenziale nel tuo specifico artistico ‘fuori’ dallo specifico stesso. Mai cercare la poesia, il ‘poetico’, per fare buona poesia, e mai cercare il teatro, la ‘teatralità’, per fare del buon teatro, del teatro davvero ‘necessario’. E’ il poetico il nemico principale della poesia ed il ‘teatrale’ il nemico principale del teatro. Mi pare che Vajont, per quanto ti riguarda, sia, da questo punto di vista, un risultato assai rilevante e fondamentale. Potresti raccontare cos’è Vajont ed, insieme, discutere con me di questo primo tema gettato sul tavolo?
Marco Paolini: Io sono d’accordo su quanto hai detto, anche se penso che il risultato non sia frutto di un lavoro diretto coscientemente in questo senso, quanto piuttosto di una serie di singole percezioni. Io faccio teatro e incontro il racconto del-la tragedia del Vajont nella scrittura del libro di Tina Merlin. Non è la prima volta che mi imbatto in questa storia, già mi era capitato da bambino di avere dei ricordi vivi di questa storia, poi mi è accaduto da adolescente di leggere un libro di Mario Passi, Morire sul Vajont, e l’ho letto nel periodo in cui io facevo politica: ero studente, facevo politica e quello era un libro politico e, dunque, la cosa mi riguardava. Provai un’enorme rabbia a leggerlo, ma in quel periodo io avevo un’idea della politica molto simile alla geografia… Cioè, sostanzialmente, mi interessavo di ‘Inter-nazionalismo’ che è un certo modo di considerare le carte geografiche e mettere dei cerchi su Portogallo, Vietnam, Cambogia, Cile e una serie di altri posti del mondo su cui va concentrata la propria attenzione. Forse il Vajont era troppo vicino a casa per concentrarcisi su, ero troppo distratto dagli altri cerchi e così l’ho dimenticato una seconda volta. La terza volta che ho sentito parlare del Vajont è proprio quando ho letto nel 1993 il libro di Tina Merlin. Quando ho terminato il libro mi sono detto: ma io questo libro devo farlo leggere a qualcun altro… ma poi come si fa e a che serve farlo? Passi il libro ad un altro, ma non puoi passargli anche il malessere che hai provato e che t’è rimasto dentro. Ti tocca per forza parlarne e come si fa a parlarne davvero? In realtà devi raccontarlo, se ci parli solo su, ti ritrovi a menare il can per l’aia, non sei in grado di produrre in chi t’ascolta niente di paragonabile a quello che t’è successo leggendo il libro… Ho cominciato allora ad imporre la fatica di ascol-tarmi ad alcune persone, usando alcune abiltà e tecniche del teatro, ma con nessuna intenzione di fare uno spettacolo. Solo dopo un certo periodo ho cominciato davvero a raccontarlo in pubblico. A questo punto
L.V.: Ti proporrei, adesso, di approfondire un paio di punti. Primo: il problema della ‘memorabilità’. Tu parlavi poc’anzi di caratteristiche fisiche e di suoni che erano stati utilizzati per rendere immediatamente riconoscibili, ‘memorabili’ alcuni personaggi che tu stesso interpreti in Vajont. In realtà uno dei meccani-smi utilizzati dalla poesia orale, dall’Iliade o dall’Odissea, per esempio, è proprio questo della ‘citazione’, in base alla quale una serie di personaggi sono resi imme-diatamente riconoscibili e memorabili… Achille è sempre e comunque «il pie’ veloce Achille», e così via. C’è dunque un qualche rapporto tra Vajont e l’oralità, la poesia e il racconto orali? Secondo: c’è, mi pare una punta di polemica in Vajont nei con-fronti della scienza, della sua capacità di ‘prevedere’, di interpretetare in maniera corretta e completa l’uomo e il mondo tutto in cui egli vive. E mi pare anche che l’indice sia puntato soprattutto contro una sua certa mancanza, grave mancanza, etica, nel momento in cui, pur di dimostrare un’ipotesi, essa si rende comunque di-sponibile a ignorare una serie di segnali d’allarme che il reale stesso propone, visibili a chiunque. Ingegnere e geologo sono, infatti, e forse non solo all’inizio, dei ‘rabdomanti’. Mi pare ci sia in tutto Vajont, proposta se non altro implicitamente, la possibilità che l’arte possa, per parte sua, costituire comunque un valido strumento di conoscenza e di denunzia alternativa, indispensabile alla nostra vita.
M.P.: Allora… io prima, in realtà, non ho risposto a quanto mi chiedevi a proposito di
L.V.: Dunque, se capisco bene, l’oralità è per te anche un meccanismo di traduzione che permette la memorabilità della tragedia, soprattutto dopo quello che tu chiami minimalismo e che noi poeti definiremmo probabilmente il ‘pensiero debole’, per tornare comunque ad avere fondamenti forti, ma a partire dal minimo, dall’assolutamente necessario, dall’ essenziale?
M.P.: Assolutamente sì, questo è il vero problema: ritrovare dei fondamenti forti. Io con Vajont mi sono detto: di tutto il lavoro che ho fatto questo è l’unico che è tramandabile, e non perché lo faccia io, ma perché questa storia è molto più grande di altre e la ragione per cui me ne sono occupato è perché non potevo non farlo. C’è una ragione prima per fare questo. E ci sarà. E allora sai cosa sto facendo io adesso? Io vorrei non raccontare più
L.V.: Si aprono comunque degli strappi, al cui interno si possono scoprire prospettive nuove. Certamente nella società del progresso tecnologico a ogni costo, della tecnomania, rimane una necessità di quello sguardo che qualsiasi specifico artistico ci può dare sulla realtà, perché senza di esso una parte della realtà ri-marrebbe comunque sconosciuta. Il ‘rischio calcolato’ all’interno di un mondo governato dalla ‘ragione tecnologico-scientifica’, o da quella economica, è accettabile, mentre invece, all’interno di un mondo in cui non vi sia posto solo per esse, ma anche per la ‘ragione etica’, per quella poetica e artistica, esso viene smascherato e diviene inaccettabile…
M.P.: Certo, è chiaro. La poesia, il teatro, l’arte devono rivendicare una loro voce non succube, non accessoria, ma necessaria, indispensabile rispetto alla qua-lità dell’esistenza e non solo, ma rispetto alla determinazione stessa delle scelte…
L.V.:Vorrei ora riprendere per un attimo quanto dicevi prima rispetto alla ‘irrappresentabilità’ della tragedia. Mi pare che Vajont compia una scelta pre-cisa a questo proposito, quella di ‘raccontare’ la tragedia, piuttosto che rappresentarla sulla scena, che si ritragga di fronte alla possibilità, al pericolo del grand guignol da macelleria, alla cruenza… Scelta classica, questa di Vajont, perché in fondo, nella tragedia classica, in quella greca antica, l’assassinio, l’efferatezza, il sangue, non vengono mai rappresentate, quanto piuttosto raccontate, a cosa fatta, da un testimone… penso alle Baccanti di Euripide dove l’episodio cruciale lo smembramento e l’assassinio di Pèleo da parte delle Baccanti capeggiate dalla madre stessa della vittima, viene narrata dal Messo, per esempio… La tragedia classica non prevede cadaveri in scena… Credo altresì che questa tua scelta sia strettamente connessa ad una precisa percezione della fisicità drammatica dell’espressione, del racconto orale, rispetto a quella che potrei qui definire, con tanta imprecisione, la virtualità del mostrare e del ‘rappresentare’. E’ come se l’attore che non tenta la mimesi della tragedia gettandosi sul palco, facendo il morto, ma che, invece, racconta questa morte, questa morte istantanea e collettiva,raggiunga una sorta di realismo successivo, memorabile, fisico, che è affidato tutto alla voce, alle sue vibrazioni e intonazioni, che toccano lo spettatore. Egli, raccontando la tragedia, la rende memorabile e quindi ‘trasmissibile’, si crea, attraverso la voce del griot che racconta, una ‘tradizione’ della tragedia, essa entra a far parte della nostra tradizione intesa come enciclopedia delle cose memorabili… E certo nella nostra recente storia esistono luoghi ed avvenimenti che sarebbe assolutamente necessario ricordare e tu, non a caso, ne incontri anche altri,oltre al Vajont… un altro è Brescia, Piazza della Loggia, di cui parli in Aprile ’74 e’75. E’ la frase dello speaker, attraverso la cui voce avviene il riconoscimento e la trasmissione ‘memorabile’ della tragedia: una bomba, state calmi, state calmi, è una bomba… E la bomba viene immediatamente riconosciuta da quella voce come appartenente già alla sua memoria e viene, nell’intenzione almeno, ritrasmessa ai posteri perché non si dimentichi che nella storia d’Italia non ci sono solo terremoti, alluvioni, disastri ingegneristici, ma anche tante, troppe bombe…
M.P: Io questa cosa della necessità di raccontare la tragedia, piuttosto che di mostrarla, di rappresentarla l’ho capita grazie a Franco Loi… Un giorno mi ha det-to: vedi il problema della memoria è che ci è difficile accettare che tutto ciò che abbiamo vissuto sia finito e non possa più essere rivissuto. Spesso la funzione della tra-gedia è proprio quella di far ‘rivivere’… La funzione dell’attore – Stanislavsky lo afferma- è la ‘riviviscenza’. L’attore deve provocare in sè l’emozione della realtà per farla rivivere allo spettatore… ma, se siamo d’accordo con Loi e crediamo, come io credo, che niente potrà più essere davvero rivissuto, allora il racconto, l’oralità, è il solo mezzo capace di ‘orientare verso’ quel punto perduto e non più raggiungibile del passato nella maniera più efficace possibile, è quello che meglio di qualsiasi altro, inoltre, mette noi tutti in una condizione di serenità rispetto all’impossibilità di rivivere qualcosa… L’esperienza della rivivescenza è un’esperienza fallimentare, destinata fatalmente a scontrarsi contro questa impossibilità. L’esperienza della narrazione è l’esperienza che assumendo l’impossibilità, ‘orienta verso’, mette cioè nella condizione migliore per fare un’esperienza nuova che conduca ‘da quelle parti’, e ciò vale, ovviamente, anche per cose che non si sono vissute personalmente. L’assunto che faccio è che
L.V.: Ma viviamo poi tutti nell’epoca dell’assoluto presente, in cui il passato è divenuto addirittura un peso di cui liberarsi, nell’epoca dei post-comunisti e dei post-fascisti, insomma, e questa mancanza di storia, questo rifiuto della storia comporta, di conseguenza, una mancanza di futuro, o comunque della capacità di immaginare un possibile futuro. Chi non ha nostalgia della storia non ha nostalgia del futuro… Parliamo di memoria ancora un po’, allora, magari a partire dalle tue altre operazioni da ‘single’ sulla scena: gli “Album”. Gli album, anche se si tratta degli album Panini con le figurine dei calciatori, sono cataloghi della memoria per immagini, per frasi, per suoni…
M.P.: Parto da una specie di proponimento, di motto per la vita: solo il presente è obbligatorio, passato e futuro si possono scegliere e io li voglio bellissimi… Questo è il punto di partenza del mio lavoro sulla memoria, degli Album, ma anche sul futuro. Il rapporto per me è quello della scelta, non della ricostruzione. Nei confronti della memoria non ho nessun debito, non si tratta di accettare una storia, la Storia, dal mio punto di vista, ma si tratta di scriverla la mia storia e visto che, tutto sommato faccio della letteratura, l’autobiografia di cui sono protagonista sulle scene non è l’autobiografia di Marco Paolini, ma quella di Nicola, il mio alter-ego che coincide con me, ma è poi la sommatoria delle esperienze mie e di tutto un universo di persone reali che mi raccontano le loro storie che io ricombino e poi riscrivo. All’inizio questo gioco d’intreccio era più ingenuo. Poi è arrivato
L.V.: D’altra parte, come si fa a non pensare a Piazza Fontana, vivendo a Treviso, con Freda e Ventura che sono parte integrante della storia politica locale…?
M.P.: Infatti… Mano a mano che passa il tempo, poi, mi rendo conto che sono sempre meno le persone che ‘ricordano’, che sono in grado di contraddire ciò che dico. Gli spettatori, ma anche i critici, non hanno più gli strumenti culturali, storici, per comprendere, riconoscere, contestare il lavoro della scrittura. Questo mi dà una spaventosa sensazione di vuoto, di solitudine e mi fa pensare che, dato che il sistema dell’informazione è fondato su questo infinito eterno presente, che sostituisce e annulla qualsiasi riflessione, e poiché sembra che il sistema dell’informazione abbia sostituito qualsiasi ideologia, noi sappiamo, sì, smascherare immediatamente un approccio ideologico alle cose, ma tendiamo a considerare l’approccio alla realtà dell’informazione come un approccio oggettivo, mentre in realtà è anch’esso eviden-temente un approccio manipolatorio, perché blocca il pensiero. Sono poche, in que-sto periodo, le persone, gli artisti gli scrittori che sento vicini per il modo che hanno di lavorare sul tempo, per esempio sento vicino Stajano, il lavoro su Serantini, o Bianconi e il suo libro su Fioravanti e Mambro, o coloro che lavorano al confine tra giornalismo e narrativa, ma sono pochi, pochissimi….
L.V.: Hai citato Stajano, a me viene in mente Capote, insomma libri ‘impegnati’… bada lo so che questa parola non si può più dire, che è demodé, eppure questi libri, faticosi da leggere e da scrivere, sono libri importanti…
M.P.: Certo… e costringono l’autore a porsi in relazione con il mondo ed è questo che mi affascina, il fatto che comunque, poi, in queste esperienze la scrittura si avvicina al teatro, nel senso che il teatro è comunque un gioco di squadra. Io adoro i lavori di squadra, anche se poi sulla scena sono da solo, quindi mi sembra straordinaria la possibilità di lavorare con altri per indagare sulla realtà…
L.V.: Per concludere, cosa accade oggi nel teatro italiano e come si si-tua la tua esperienza all’interno del quadro attuale? Magari anche qualche parola sulla situazione – come dire? produttiva…
M.P.: Il teatro è, per definizione, quasi sempre considerato come un edificio, un luogo senza finestre, e con un certo odor di stantio, un odor di vecchi velluti e muffe, dovuto alla scarsa aereazione dei locali. Quando io ho iniziato a far teatro, però, negli anni ’70, esso non era più un luogo: era un territorio. C’erano città intere dedicate al teatro, straordinarie… Sant’Arcangelo, Nancy, Avignone, Edimburgo, luoghi dove il teatro letteralmente ti esplodeva tra le mani. Io tornavo a casa e pensavo con gli amici: facciamo anche noi il teatro, perché la vita è questo, mettersi in viaggio e percorrere territori… Poi sono arrivate le mazzate, gran mazzate, su quelle piazze, su quelle esperienze di produzione culturale e teatrale che hanno fatto tanta paura, sia a chi andava a vedere quegli spettacoli, che a chi li faceva. C’è stato da parte di un’intera generazione una specie di effetto lumaca che ritira le antennine dentro il guscio e molta gente che io conoscevo e che predicava il raggiungimento, il superamento addirittura, di certi limiti dell’arte e del teatro, della convenzione, persone attive nella critica alla distribuzione dei fondi ministeriali e impegnate nella ricerca di fonti alternative, anche grazie a una vivacità delle periferie dei piccoli comuni a una loro dinamicità infinitamente superiore alla lentezza del centro, dei centri maggiori, ha dichiarato la resa e tutto è terminato entro il primo quinquennio degli anni ’80. Ad esempio, tanto per fare delle date, il 1983, l’incendio del cinema Statuto di Torino.Che vuol dire, per restare sul concreto, la chiusura di circa 450 sale in Italia. Piccole sale, certo, non grandi teatri, che vengono invece adeguati facilmente alle nuove norme di sicurezza, emanate successivamente al disastro torinese, sale parrocchiali e teatri di ricerca, auditorium, salette di quartiere ed aule magne, i luoghi in cui di fatto di svolgeva gran parte, non solo dell’attività di ricerca artistica, ma anche una buona fetta di quella mirata anche solo al puro intrattenimento. Ora non è un caso che precisamente nello stesso periodo sia possibile riscontrare l’esplosione delle discoteche come luogo di incontro e intrattenimento di massa… E’ la discoteca la cattedrale degli anni ’80 e sono discoteche gli edifici più grandi dedicati all’intrattenimento costruiti negli anni ’80. Allora si tratta di una scelta e non di caso, la scelta dello spostamento dei consumi ‘estetici dal teatro e dal cinema alla discoteca non è un caso, si tratta di fatto di un modello culturale che viene pesantemente in-dotto ed avallato, come si è avallato quello delle autostrade rispetto a quello delle ferrovie. A tutto ciò corrisponde un riduzione delle occasioni di fare spettacolo, una guerra tra poveri, una assunzione della ‘qualità’ come criterio unico per l’accesso alle sovvenzioni ministeriali e dunque per la sopravvivenza stessa dei gruppi di produ-zione, col Ministero che si ritrova ad essere arbitro assoluto della situazione, il quale effettua una drastica politica di disboscamento, per far crescere gli ‘alberi forti’, più ‘competitivi’. Questa politica ha certo aspetti salubri, ma i criteri adottati poi per le scelte non lo sono stati altrettanto. Sta comunque di fatto che che in quegli anni il teatro smette di essere un territorio e ritorna ad essere un edificio e così il suo pubblico si riduce drasticamente al pubblico che normalmente si reca la teatro, insomma gli spettatori ‘alternativi’ si riducono a una specie in via d’estinzione che viene rinchiusa in rassegne-ghetto che si alternano con le più regolari stagioni e gli spettacoli che sono compresi in queste rassegne si ritrovano a lottare tra loro per la conquista di fette di pubblico sempre minori. E’ come un periodo di glaciazione che viene accettato supinamente anche dagli artisti, che si ritrovano ad essere sempre più in difficoltà e così molti di loro si chiudono alla ricerca e ricominciano, in maniera difensiva, a fare i classici. Io non ho niente contro i classici, con Teatro Settimo di Torino ho fatto Goldoni, Shakespeare, tentando di reinventarli e sono contento del lavoro svolto… Ma questo oggi si sta trasformando in una sorta di bene-rifugio in cui molti artisti si sono trovati un impiego, perdendo la propria identità collettiva e formandosene una tutta personale, più vendibile sul mercato, visto che i teatri comprano i singoli artisti e non le formazioni complete, spaccano e selezionano i gruppi di ricerca, cooptano gli individui più utili alla conservazione e alla perpetuazione del vecchio modello culturale e delle correnti modalità produttive. Questo è accaduto di fatto dalla metà degli anni ’80 ad oggi, con un impoverimento di spinta complessiva e con la perdita della loro funzione di intellettuali da parte degli artisti coinvolti in queste dinamiche. Artisti senza più strumenti critici, senza nessuna presenza pubblica, nessuna opinione sull’andamento che ha il tempo che viviamo, sulla nostra identità storica. Si è lasciato al cinema il compito di tentare di raccontare questi anni, con pochissime eccezio-ni. Tutto questo è funzionale alla conservazione dell’idea del teatro come edificio. Mi viene allora l’idea che di quella puzza di chiuso e di stantio che c’è nei teatri non siano responsabili solo muffe e vecchi velluti, ma anche coloro che ci vivono dentro e che sono un popolo di moribondi e morti putrefatti che continuano a calcare le scene… figli d’arte, direttori di nomina politica che sono arrivati lì al termine di un’onorata carriera fatta all’insegna del portaborse, o perché hanno un ‘finissimo’ spessore culturale… Capaci di mediare, abili cuochi, abilissimi nel mescolare ben bene gli elementi della pietanza che serviranno sul mercato tradizionale per soddisfarlo. Di quel teatro, oggi, chiunque può fare a meno, senza tema di rischiare la reputazione. E’ poco più di un vezzo che le città si mettono all’occhiello… Contenti loro…
Previous Reading
Continue reading
Villadrome
20 Novembre 2003
È lo ‘scomparso’ per eccellenza della Storia della nostra Letteratura del Secondo Novecento. Messo ai margini praticamente da tutti, ostentamente...
Next Reading
Continue reading
Berchidda: il jazz si fa trans-gender
20 Novembre 2003
“Quadri di un’esposizione” era il titolo di una celeberrima composizione del russo Mussorgskij che, nel 1874, dedicò le sue note...