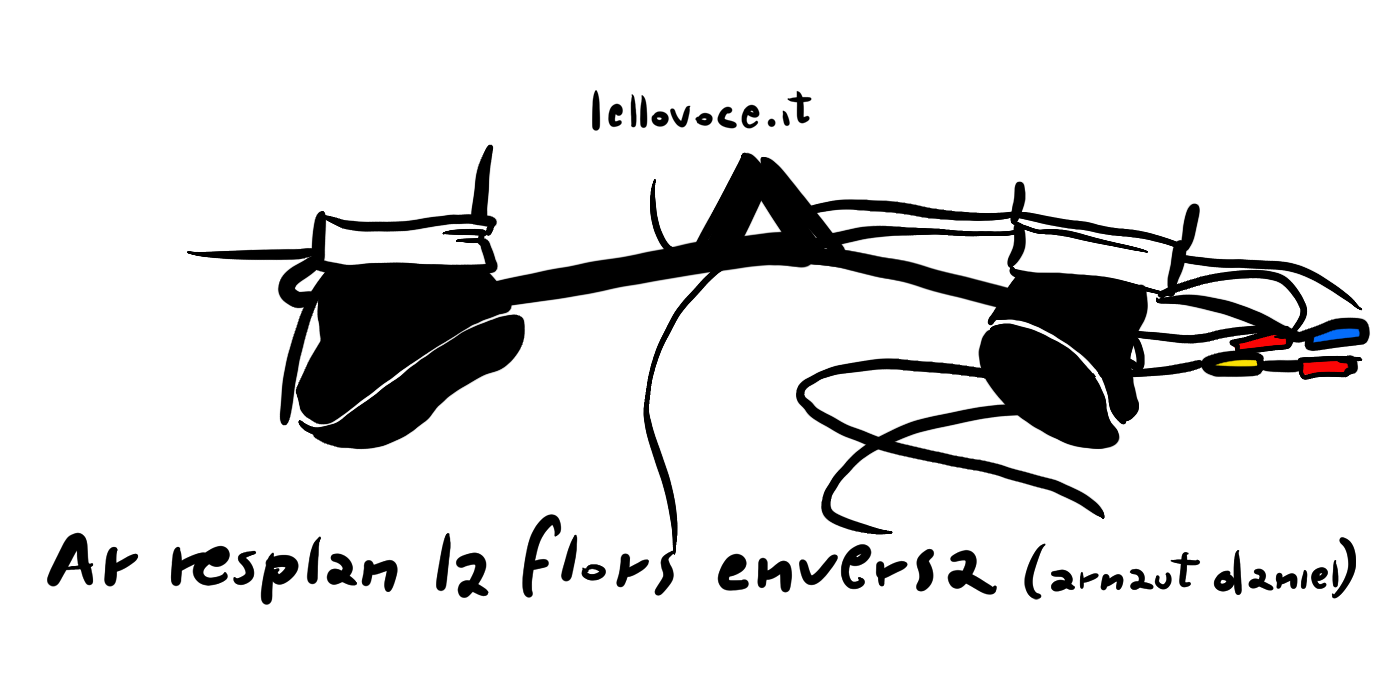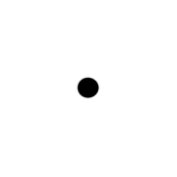I
La vita è come una miniera. Solo che invece di camminare nel ventre impietrato della terra, tra lastre di minerale e lave, si scavano gallerie nella pancia obesa del tempo…
Si grattano minuti e secondi e secoli con le unghie spuntate, per precipitare di colpo nel camino spaventoso che ci attende appena oltre la svolta dell’ultima galleria e ci precipita, come silice proietta, sino al fondo sfolgorante del nulla.
Io cerco mio padre. Mio padre che si chiama Misciu ed è il padre di tutte le caverne e le miniere e le grotte, perché mio padre è il mare, è l’acqua maschia che atterra e rode. Che dà la vita.
Mio padre, che è scomparso come me, cercando, tra la rena rossa e lo zolfo, il passaggio nascosto che porta fino alla quota di Dio.
Io scavo rena rossa e zolfo. Come mio padre. E ho seguito le sue impronte leggere, stampate sulla sabbia sanguigna della galleria che va nel cuore della montagna di polvere dura che se lo è mangiato.
Poi le sue impronte sono terminate. E allora ho seguito il suo odore, l’odore d’olio di noci della sua lampada. E ho camminato, camminato, camminato, fino a quando lo stoppino della mia non si è spento.
E anche oltre. Immensamente oltre. Oltre il buio, quando il nero rivela d’incanto i profili nuovi delle cose, quando gli occhi si fanno occhi di gatto, di topo, di talpa.
Ho camminato fino alla fine della galleria scavata dalle unghie e dal piccone di mio padre, sono entrato nella grotta immensa che si apriva oltre l’ultimo diaframma. E sono andato avanti, lungo passaggi che nessun uomo ha scavato, sottopelle al pianeta intero, nel luogo che abita solo l’acqua, che distilla rumori e riflette il buio.
Ho camminato seguendo i segni. I segni dell’essere profondo che ha forma d’uomo e che graffia il suo profilo sulle rocce. Perché si sappia che la roccia è viva. Che respira.
Poi ho seguito l’unico odore che riconoscevo. L’odore dello zolfo. E sono giunto alle basi dell’altro vulcano ed anche lì ho trovato i segni e li ho seguiti.
Nel frattempo imparavo l’ aroma di ogni minerale, apprendevo il risuonare in vibrazioni d’ogni scaglia di pianeta celata lì, sotto le radici degli alberi, sotto l’erba, le case. Uno per uno.
Sentivo il mare sopra di me e ho provato a scavare verso l’ alto,a mani nude, per raggiungerlo. Ma più scavavo, più il mare s’allontanava. Fuggiva. Come io fuggivo dagli uomini. Come mio padre e la sua morte sfuggivano al mio cammino, si sottraevano alla ricerca.
Quante miniere ho incontrato lungo il mio cammino?Decine, centinaia…
Dall’alto mi giungevano i colpi sordi dello scavo, le voci concitate degli uomini, sopra di me. A volte sono restato un tempo immemorabile ad ascoltare i suoni della vita che si infiltravano attraverso le spaccature della roccia, o scrosciavano d’echi, amplificate dal corno immenso delle caverne. Lingue sempre diverse. Solo i gemiti della fatica non cambiavano mai.
Ma io andavo avanti. A Nord, sempre più a Nord. Senza stelle a condurmi, seguendo la forza magnetica che fa scorrere i suoi fasci nelle vene del pianeta. A Nord.
Finché sono giunto in un punto in cui tutto sembrava vibrasse. Era come se la montagna fosse riuscita ad imbrigliare le lave profonde senza dar loro sfogo. Come se le avesse fulminate nell’immobilità della pietra, un attimo prima dell’esplosione e quelle, impietrate com’erano, seguitassero a fremere. C’erano centinaia di minerali intorno a me, uno diverso dall’altro, sentivo le loro forze cozzare frenetiche e ho capito che dovevo salire. Che mio padre e la sua morte erano lì, vicino a me, a un passo, a un respiro, e che per trovarli dovevo tornare nella luce, guardare di nuovo le stelle negli occhi.
C’era gente lì su che parlava, si scambiavano ordini, qualcuno rideva. Ho visto il camino da cui, con le voci, giungeva fin lì una bava infinitesima di luce.
Misciu era lì, lo sentivo quasi respirare accanto a me, percepivo l’alito immondo della morte che gli era montata in groppa…
Tutte le rocce intorno a me erano piene dei segni. Dei profili degli strani esseri graffiti a forma d’uomo. Dei cerchi magici che disegnavano mappe incomprensibili sulla massa inerte della roccia profonda.
Ho iniziato ad arrampicarmi lungo il pozzo. E mentre salivo sentivo un rombo, quasi la montagna tutta, sopra di me, si ribellasse come madre, urlasse per il dolore di partorirmi di nuovo alla superficie.
Ma io salivo, salivo, salivo come lava, aggrappandomi alle pareti del pozzo con le ginocchia ed i gomiti. Con le unghie.
Poi ho visto la luce e i miei occhi si oscurati, sfolgorati dal sole…
II
Il Barivèl era venuto fuori prima del tramonto. A gennaio. Il giorno del piccolo crollo della galleria Mongenet. Poca roba. Uno o due massi squilibrati. Che avevano fatto tanta polvere e nessun danno. Per primo l’aveva visto Giachetto Giuseppe, il Bioch insomma, che era tornato dentro subito, perché nella fretta di scappare aveva abbandonato gli arnesi e per ricomprarseli ci volevano due mesi di miniera.
L’aveva visto venire su da un camino, da un pozzo che precipitava giù sino alla quota della galleria del Piss, come fosse un fantasma, o il mostro terribile del ventre della terra. Attaccato alle pareti sconnesse del foro che precipitava al livello inferiore della miniera con unghie che parevano artigli. Tutto bianco di polvere e rosso del sangue di graffi e ferite dove la pelle si era strappata e lacerata contro la roccia. Il Bioch, appena l’aveva scorto, aveva dato un urlo ed era scappato fuori ad avvertire gli altri.
Erano entrati in cinque, compreso l’Intendente del Conte di Netro, perché in fondo la miniera era del Conte ed erano suoi pure gli eventuali fantasmi, o mostri che ci comparivano e di cui, dunque, lui Intendente aveva il dovere di occuparsi.
Il Barivèl era steso lì, appena oltre l’orlo del camino. L’acqua che veniva giù dalla volta della galleria gli aveva lavato via la polvere e il sangue qui e là.
Tanto per capire chi era, Bernardo Colombo gli aveva sferrato un calcio nel costato ed era schizzato via all’indietro, come avrebbe fatto con una belva appena abbattuta. Ma quello non aveva reagito. Si era limitato a girarsi sul fianco e a grugnire. Gli avevano tirato addosso due secchiate d’acqua gelida per ripulirlo e vedere com’era. Quello aveva allungato fuori gemiti strazianti e si era rigirato sulla schiena. Allora l’Intendente aveva dato ordine che lo trascinassero fuori e loro l’avevano preso in quattro, mani e piedi, e, dondolandolo come fanno i pesi sospesi ai baduj, l’avevano portato davanti all’ingresso della Mongenet.
L’essere, appena all’aperto, si era contorto tutto per un po’, come se la luce gli lacerasse le pupille, gli incenerisse palpebre e pori. Poi si era calmato, aveva dato un ultimo sussulto ed era rimasto steso lì, pancia all’aria.
Aveva il volto raggrinzito di un ragazzo a cui avessero succhiato via la giovinezza. Tutto a pieghe, come se sotto la pelle non ci fossero che ossa e nervi. Aveva i capelli rossi. Ma non un filo di barba. Un corpo gracile, smunto. Le unghie lunghissime ai piedi e alle mani, qua e là spezzate e sanguinanti, come gli artigli di un rapace dopo la lotta feroce con le sbarre della gabbia che l’imprigiona. Gli occhi grigi, vuoti.
Si era raccolta una piccola folla. Minatori, mulattieri, carbonai, donne e frotte di bambini cenciosi. Gli avevano gettato addosso altra acqua e quello, invece di protestare, si era gettato con la faccia nella pozzanghera a bere. Allora qualche donna gli aveva avvicinato una ciotola d’acqua e del pane con una scheggia di toma ammuffito. Aveva divorato e bevuto tutto. Come fa un uomo. Come un qualsiasi cristiano. Senza dire una parola.
Avevano provato a parlargli, a domandargli. Ma niente. Il Barivèl non parlava, o meglio parlava una sua lingua strana, che nessuno sapeva capire. In nessuno dei Cantoni, in nessun luogo della Valle si usavano quelle parole lì, nemmeno a Vico, dove parlano mescolando le lettere, come fosse la lingua del demonio.
Aveva detto poche cose, affannate, che nessuno aveva compreso. Poi aveva smesso.
Ma capiva. Capiva tutto. E quando l’Intendente del Conte di Netro gli aveva detto – Alzati animale! quello si era alzato, come un automa, come se ogni fibra del suo corpo capisse quello che la sua mente non comprendeva, come avesse dentro, nel costato, l’anima del servo della gleba, che non ha mai le parole per ribellarsi, ma comprende sempre gli ordini del suo padrone.
Alzati animale!
Il Barivél si era alzato, dondolando e strizzando gli occhi. E l’Intendente gli aveva dato due scudisciate secche sul volto, come si fa coi cani che si vogliono ammaestrare. Aveva barcollato ed uggiolato immobile. Allora anche gli altri, gli uomini, si erano avvicinati e avevano cominciato a colpirlo, fino a quando non era crollato di nuovo a terra. E loro non avevano avuto la prova irrefutabile che quell’essere lì era inoffensivo. Che era un servo dei servi. Schiavo come loro.
Non era un mostro, solo una bestia a forma d’uomo. E non era di pericolo per nessuno. Un povero Cristo capitato lì chissà come e perché.
E lì lo lasciarono, all’imbocco della miniera, come un sacco abbandonato.
III
Sono uscito. Perché sono un vigliacco. Perché avevo bisogno della luce come loro, della luce che mi impedisse di vedermi dentro, perché lì, nel buio della miniera, quando guardi davanti, vedi chiaro nel mondezzaio dell’anima, come in uno specchio. Vedi i visceri che macinano sentimenti, il fegato gonfio di rabbia, vedi tutto il tuo dolore, la tua vigliaccheria, che grondano via attraverso l’ano che chiamiamo vita.
Quando m’hanno visto, sono fuggiti, quando m’hanno visto, io vedevo tanta luce da essere cieco. Ma sentivo il loro odore e l’odore della miniera. E sentivo il rombo incessante della vita e del torrente che precipita dall’alto sin qui, per lavare il minerale, il torrente che piomba sino a valle, per servire la miniera.
M’hanno lavato come per un Battesimo: due, tre volte. Poi ricordo una donna che mi passava pane, formaggio…
Il pane sapeva di pane e il formaggio di formaggio, la muffa di muffa. Come sempre. Tanta strada per niente.
Poi ricordo le scudisciate sul viso, dure come quelle del Gentiluomo di Floristella, dure come quelle di mio padre, Misciu Bestia, tanto più dure quanto più dure erano state quelle che aveva appena subito lui, ma meno dure di quelle che io poi infliggevo al somaro, al somaro che ora è una carcassa conciata dal sole in fondo al burrone che costeggia la via che sale a Monserrato.
Io che ora, mentre ansimo tra i colpi di questi uomini attorno a me, sono come quel somaro: conciato dal dolore e dalla luce. Calcificato, dopo tanta strada per tornare dov’ero, a centinaia di miglia da dov’ero…
Eppure, se resto, se non scappo come una serpe nel fondo del pozzo da cui sono appena uscito, è perché so che sei vicino. A un fiato da me, padre.
E presto ti acciufferò. Non ti proteggerà la massa di magnetite in cui ti sei celato, per sfuggire alla vita, agli uomini.
A tuo figlio.
E fossi tu pure al centro della massa enorme di ferro, che sento vibrare al fondo della miniera, o dietro l’angolo delle vene che innervano la montagna, ti scaverò, ti scoverò e ti libererò dalla morte che è stata la tua unica salvezza.
Resto per questo: non per il vostro cibo, non per il vostro fuoco, non per la vostra acqua.
Siete troppo simili a me, perché io vi possa amare. Ma devo restare.
E’ per questo che ho ricominciato ad ubbidire e a travagliare.
IV
I primi a chiamarlo Barivèl erano stati i bocia, perché, nonostante fosse un uomo con gambe e braccia come tutti gli altri cristiani, lo capivi subito che quel rosso lì non era uguale a loro proprio per niente, che con lui non valeva quello che valeva con gli altri, che non potevi fidarti, che era matto e testardo come un somaro, che era cattivo dentro, fino in fondo al pozzo dell’anima sua.
Che era, insomma, un barivèl: uno matto e cattivo, uno strano e diverso, uno feroce e solitario e vigliacco, come una bestia che ti striscia alle spalle e che, se può, ti colpisce. Un barivèl…
Ai ragazzini, che lo inseguivano con frasi sconce e pietre aguzze, reagiva sputando, o graffiandoli al viso, lasciando loro tagli profondi alle guance, o al torace, tanto profondi e selvaggi che poi, alle madri, sembrava che avessero incontrato un lupo, o un orso affamato e non quel maledetto Barivèl, che Dio la danni e lo faccia scomparire di nuovo nel fondo della galleria oscura da cui era venuto fuori, quella maledetta mattina di gennaio.
Perciò lo chiamarono Barivèl. Fu qualcuno dei bocia a urlarglielo in faccia con rabbia, appena scansata l’unghiata con repentina mossa di fianco. Barivèl, Barivèl, Barivèl: come fosse un insulto sanguinoso, e lo era per davvero. Barivèl, Barivèl, Barivèl…
Lui non se n’era dato per inteso. Come un cane, che, se lo chiami sempre Maledetto, lui poi, quando glielo urli sul muso, ti corre vicino, perché pensa che lo chiami per nome…
Aveva cominciato a lavorare da subito. Come se fosse la cosa più naturale del mondo. E si era visto immediatamente che il Barivèl le miniere le conosceva bene, che ci si muoveva a suo agio come la tinca nello stagno.
Aveva iniziato portando fuori le ceste del minerale, insieme con le donne e i bambini. Si arrampicava sulle risalite che collegano le gallerie alle diverse quote come una di quelle capre che vedi all’alba, mentre salgono i costoni del Betogno, dirette all’alpeggio.
Saliva respirando a bocca aperta, biascicando chissà che in quella sua lingua cupa e incomprensibile. Scaricava la cesta e tornava dentro di corsa, come se trovasse freddo e luce insopportabili.
Poi un giorno, mentre Minich e Morello erano lì a discutere con l’Intendente su dove era meglio mettere le mine per fare la volata, aveva preso in mano un piccone e aveva incominciato a battere dove nessuno avrebbe pensato a battere, aveva frantumato la roccia con colpi possenti, finché la pietra aveva cambiato colore. Aveva fiutato nel buco e aveva cominciato a dire quelle sue cose incomprensibili, fino a quando non li aveva convinti per sfinimento.
Avevano fatto lì la volata delle mine. E avevano trovato tanto minerale come non se ne vedeva da tempo, alle miniere di Traversella e in tutta la Valle.
Perché il Barivèl era come un cane da ferro. Sentiva il minerale con le froge. Ne percepiva le vibrazioni battendo col piccone sulle lastre durissime dello sterile che lo celava agli occhi avidi degli uomini. Batteva, fiutava e quasi sempre trovava.
Ma non c’era modo di costringerlo. Lo faceva quando gli andava, quando sentiva che anche la miniera voleva che accadesse. Non era valso pregarlo, non era valso batterlo, non era valso pagarlo. Lui diceva di sì, con un cenno del capo, tirava qualche colpo svogliato qua e là, indicava un punto a casaccio e se ne andava. Ed era tutta polvere da mina sprecata.
Se aveva voglia, scavava con gli altri, se no si caricava sulle spalle una cesta e faceva il mulo.
A vederlo era venuto persino il Conte di Netro, a cavallo. Era smontato giusto il tempo per guardarlo, il fenomeno che gli era capitato in casa, e per concluderne che era un altro pezzente che veniva a sfamarsi nella sua miniera. Lo aveva toccato con la punta del frustino e quello si era inginocchiato e l’aveva baciata, rispettosamente. Il Conte aveva guardato l’Intendente con l’aria di chi si sente di aver fatto strada per niente. Quello era un miserabile come tutti gli altri e non aveva proprio niente di speciale. Come gli altri andava trattato.
E di quell’opinione rimase. Anche quando l’Intendente corse da lui col polso spezzato, tutto penzoloni, urlando che quel Barivèl era il diavolo in persona.
Era successo che a fine settimana, quando si era messo in fila con tutti per la paga, a lui l’Intendente i soldi non li aveva dati. Solo pane e companatico. D’altra parte, a che cosa dovevano servire dei danari a un tipo così, a un animale da galleria, che non si muoveva mai di là?
Il Barivèl era rimasto con la mano tesa e l’Intendente, tanto per toglierselo di torno, gli aveva messo sul palmo un altro tozzo di pane. Era stato allora che quello gli aveva afferrato il polso e aveva iniziato a stringere, a stringere, a stringere e a torcere, e aveva continuato sino a quando l’Intendente non aveva tirato fuori dal sacchetto le monete che gli spettavano. Poi s’era andato calmo, senza dire una parola, lasciando lì la miseria di rame appena conquistata, mentre quello guaiva e si guardava disperato il polso frantumato e prometteva vendetta, seduto culo a terra, intanto che i mocciosi sbellicavano e due mulattieri si precipitavano a tirarlo su in piedi.
Alla fine del racconto anche il Netro aveva riso e aveva minacciato l’Intendente di licenziamento. Lui i suoi soldi glieli affidava perché li desse a quei miserabili, perché stessero calmi e scavassero. E ci teneva. Quella era gente che aveva sangue caldo nelle vene e su certe cose era bene far attenzione. Al Barivèl avrebbe pensato lui, sia per i soldi che per le botte… Ma i danari del Barivèl li avrebbe trattenuti sulla paga dell’Intendente. Che ascoltò muto e andò in paese a farsi steccare il polso dal barbiere, con la coda tra le gambe.
Il Conte aveva poi mandato due dei suoi alla miniera che avevano trascinato il Barivèl fino al centro del grande magazzino che si apre alla fine del primo ramo della galleria. Lì, al centro della grotta che faceva risuonare i colpi amplificati, lo avevano frustato per bene, davanti a tutti. Poi gli avevano gettato davanti i tre soldi che gli aveva rubato l’Intendente. E gli avevano spiegato che se era ancora vivo era solo perché l’Intendente, imbrogliando lui, imbrogliava il Conte. Ma che lui, bestia che era, doveva mettersi bene in testa quale fosse il suo posto.
Da allora le storie sul suo conto si erano moltiplicate, rimbalzando da una galleria all’altra, risalendo i camini e rimbombando contro il corpo ottuso della massa.
C’era addirittura chi, dopo la faccenda dell’aggressione all’Intendente, andava dicendo che il Barivèl era la reincarnazione del Capra, il capo dei Ribelli, il Tuchino che aveva messo a ferro e fuoco e fuoco tutti i castelli della Valle, tanti secoli prima, perché anche il Capra aveva i capelli rossi, e che quel Barivèl lì, da un momento all’altro si sarebbe rivelato per quello che era. E i castelli della Valle sarebbero bruciati di nuovo come ai tempi della Ribellione Tuchina, quando le bande condotte dal Capra sfondavano le porte e invadevano le corti, urlando. E si prendevano la carne nobile, a turno, bocche sguaiate che ridevano senza denti, con le barbe ispide che sapevano di stalla e caglio. I loro gioielli, le loro figlie e mogli. Si riprendevano quello che la vita aveva loro sempre negato: il danaro, il piacere, la vendetta. E ridevano, ridevano, ridevano…
Caterina però a quelle cose non credeva. Caterina era una donna anziana, l’unica che potesse avvicinarsi al Barivèl e toccarlo senza che quello scappasse, o provasse a graffiare con quelle sue unghie, affilate come artigli. Caterina diceva che la storia era un’altra e che lei lo sapeva bene che il Barivèl era stato inviato a lei per compensarla della perdita di suo figlio che era morto nel grande crollo del 1812, lasciandola sola.
Chi fosse stato a inviarglielo non si capiva: a volte santa Barbara, altre la Vergine in persona, altre ancora lo Spirito Selvatico che aveva graffito lungo il sentiero impervio che sale verso Ovest, sotto la punta del Cavalcurt, risalendo la corrente impetuosa del Chiusella, le figure antropomorfe e i circoli magici che narrano di un tempo di cui non c’è più memoria, quando le orde Salasse invocavano la protezione del Sole e i falcetti dei loro druidi recidevano le erbe che sconfiggono il dolore e la malattia e i Celti raccoglievano il minerale che affiorava nelle foreste, fitte sino alla sommità del Betogno.
Lei diceva così e urlava isterica a chi glielo negava, anche se in paese lo sapevano tutti com’era andata davvero la storia del figlio, lo sapevano tutti che quello non era mica morto nel grande crollo, che quella mattina là in miniera nemmeno c’era andato, che era montato sul somaro e se n’era scappato con la Maria, che aveva dieci anni più di lui ed era vedova, perché Caterina piuttosto che tirarsi in casa quella vecchia cenciosa puttana che parlava strano, che si succhiava via tra le sue cosce tutta la vita giovane del figlio suo, l’avrebbe ammazzata. E poi forse avrebbe ammazzato anche lui, il suo unico figlio, e il somaro e le due vacche macilente. E se stessa.
Lo sapevano tutti che quello, a un bel momento, aveva deciso che allora era meglio andarsene via, oltre la montagna e i passi più alti, fin dove c’era la gente che parlava come Maria, al suo paese, lontano, oltre il valico più lontano.
L’avevano visto in molti, con la sua ganza, partire all’alba, ridendo e spronando il mulo sulla strada che va verso Francia. E l’avevano detto a Caterina, che al sentirlo nella gran confusione che c’era, davanti la galleria che vomitava fumo e polvere e lamenti, il giorno del grande crollo, aveva urlato più forte dei feriti, più forte della montagna e della miniera, che no, suo figlio era là sotto e che lei l’aveva perso per sempre. Per sempre!
Era a lei che il Barivèl dava sempre i soldi di rame della paga, limitandosi a tenere per sé il pane, il vino e quel po’ di formaggio. Lei gli aveva portato in cambio qualche panno, una casacca, un paio di brache lunghe, una vecchia pelle di pecora per la notte. A volte gli allungava un piatto di minestra calda, qualche bicchiere di vino in più.
Non si erano mai detti una parola. Si spiegavano a gesti. A sguardi. Condividevano solitudini e silenzi. I vuoti in cui lo sguardo sostituisce la voce.
V
Qui scavano ferro, invece di rena e zolfo, ma fa lo stesso. Pesano uguale i cesti che mi caricano sulla soma. Pesano il peso esatto che un uomo può sopportare prima di stramazzare sulle ginocchia, come mulo bolso.
Io sono prigioniero, loro non lo sanno, ma io sono prigioniero. E’ la terra che mi imprigiona. La terra senza mare, la terra che ti lascia libero solo se la penetri sottopelle e la scavi e che in superficie ti lega col laccio dei tramonti e delle albe, del caldo e del freddo pungente che ti aspetta allo sbocco della galleria.
Ma è uguale, perché se la miniera non esistesse, nemmeno io esisterei.
Se continuo a stare qui è perché sento che lui è vicino, sento il suo odore e il suono della sua voce che viene da qualche galleria e allora scavo, scavo, ma trovo solo minerale. Inutile.
Loro sono stupidi come bestie, perché esultano quando si trova la massa di magnetite che cova il ferro. Il guadagno va al padrone e a loro solo pochi soldi di rame falso e va bene così.
Perché la miniera è lì, certa com’è certa la povertà, è lì che ti aspetta, ogni mattina, prima ancora che faccia mattina, quando li vedo venire dal paese, come pipistrelli ritardatari e infreddoliti, uno dietro l’altro, simili a ciechi imprudenti che si facciano strada a vicenda. Sino al buco nero che li inghiotte. Per qualche soldo di rame. Per la certezza che domani la fatica sarà dura come oggi, tanto da lasciarti sciancato, vuoto come un magazzino tenuto su dai pilastri di gambe malferme. Ma non di più. Non di più.
Non capisco una parola di quello che dicono. Sono come bestie abbrutite, parlano una lingua di vocali liquide come i loro fiumi, che a volte finiscono in solfeggi cupi.
Non capisco una parola di quello che dicono. Tranne gli ordini e gli insulti. Quelli si capiscono in qualsiasi lingua, perché sferzano i timpani, si comprendono con lo stomaco, con il cuore e con il dolore. E non mi occorre capire altro.
Perché sono di passaggio e troverò la strada indicata dai segni, il percorso che mi riporterà verso casa, verso il calore della sconfitta.
Io sono stupido come una bestia, perché non so vivere senza padrone.
Ma io conosco il suo volto da belva, tanto simile al mio. E non è quello di nessuno di loro.
Nemmeno quello da cane da guardia del servo dell’uomo a cavallo, nemmeno gli occhi da serpe dei suoi scagnozzi.
E neanche il profilo sfuggente dell’uomo a cavallo, tanto simile a quello del Gentiluomo di Floristella. E nemmeno il volto strappato della vecchia. Nemmeno i suoi occhi che guardano all’indietro.
Qui scavano ferro, invece di rena e zolfo, ma fa lo stesso. Pesano uguale i cesti che mi caricano sulla soma. Pesano il peso esatto che un uomo può sopportare prima di stramazzare sulle ginocchia, come mulo bolso.
Io appartengo a mio padre e alla sua morte. Ne sono parte decisiva. Io sono qui per interrompere la sua morte, per sospendere la fine, per invertire il tempo e precipitare il cielo sino all’infimo dell’ultimo camino che si spalanca nelle viscere fangose della miniera.
Siamo un popolo di orfani e vedove. Tutti. Uomini, donne e bambini.
E io qui cerco il mio vero padrone, per smettere di essere servo di chiunque.
VI
In paese, a Traversella, il Barivèl non c’era sceso mai. Ma era uguale, perché il paese vero era lì sotto, in miniera. Era lì che passavano la vita quasi tutti, tutti quelli, almeno, che erano in grado di camminare sulle proprie gambe e di nutrirsi con le proprie braccia. Uomini, donne e bambini.
Le case servivano per dormire, o per il pranzo della domenica, quando bisognava mettersi gli abiti della festa per andare alla Messa.
Ma il paese vero era in miniera, era la miniera. Con le sue strade e piazze.
C’era la Galleria della Rosa e quella della Speranza, il Pozzo del Dì e quello del Toro, il Piano dell’Acqua e la Galleria di Santo Stefano, la Cisterna dei Ciapeij e la Discesa dell’Allegria che, inopinatamente, sbucava ai piedi della Scala della Malinconia, c’era la Pianella dell’Alba e la Discenderia della Luna, dove, se proseguivi sempre dritto, ti trovavi subito di fronte la Posta dei Matti, che di lì era meglio non proseguire, perché era lì che era venuto giù tutto, nel 12, e i livelli erano franati, l’uno sugli altri, le quote si erano precipitate addosso, fino ad azzerarsi in un vortice di polvere e tonfi e scricchiolii, di corse disperate, interrotte dal maglio spietato della montagna che si riassestava sulle sue viscere scavate e torturate.
Forse era proprio di là che quel Barivèl era arrivato sino al fondo della Cisterna del Piss, da dove era saltato fuori, come l’avesse mandato il demonio in persona.
Dormiva in miniera, il Barivèl, si metteva a qualche centinaio di metri dall’ingresso, dove le gallerie si biforcavano come lingua di serpente, all’altezza del Bornello del Marmo. Sotto un aggetto della roccia. Coperto della pelle di pecora che gli aveva portato Caterina.
Ed era strano per uno come lui, che sembrava proprio che preferisse la miniera all’aria aperta, al bosco e alla Valle, ma lui accendeva attorno a sé due o tre lucerne, come per scacciare il buio, quasi che il buio, col silenzio, fosse troppo da sopportare anche per una bestia da galleria par suo.
Ché certo la luce non era per spaventare i topi, che lo sfuggivano anche loro, quasi intuissero in anticipo la beffarda, vibrante crudeltà con cui il Barivèl, appena poteva, apriva loro il ventre, con un veloce, preciso, cattivo colpo dell’unghia lunghissima e affilata che gli coronava il pollice destro.
Dalla miniera veniva fuori raramente, all’imbrunire, quasi fosse uno singolare pipistrello rosso a cui avessero tagliato le ali, costretto a zampettare. Qualche volta s’arrampicava persino sinsullacimadegli abeti,odellebetulle e stava lì a scorgere chissà che in lontananza, quasi fosse vedetta sull’albero maestro, che scruta l’orizzonte, pronta a gridare: terra, terra! agli sfiniti compagni stesi sulla tolda, ficcati a mucchi nella stiva, buia come una miniera…
Ma cosa cercasse di vedere nessuno l’aveva mai capito.
Una volta, una sola volta aveva superato gli invisibili confini che si era stabilito da solo.
Quel giorno lui se stava lì, che scrutava intorno, come fosse una bussola impazzita, come se il ferro, tutto il ferro della miniera, si divertisse a scuotere e a far vorticare l’ago della sua volontà. Era come se il cane da miniera che era in lui sentisse contemporaneamente tutte le centinaia di minerali che si affollavano nella Valle, uno sull’altro, e non sapesse che traccia seguire.
Era fermo su una distesa scoscesa di lastre di pietra piatta, messe l’una sull’altra, quasi fossero le tegole che coprivano le case in paese.
Caterina era giù che discuteva con due sgherri del Netro. Che c’era poco da star a far storie: quella legna lì, quella che Caterina si stava trasportando in paese, l’aveva rubata dalle cataste preparate per i forni del Conte. Ed avevano gli scudisci in mano. Ed erano nervosi ed arroganti, come si può esserlo con una cagna anziana, inutile alla guardia, buona solo a far sparire avanzi.
Il più giovane la colpì sul volto, mentre quella pure da terra difendeva la sua fascina. La gente intorno protestava che basta, che erano legni secchi, povera vecchia pazza, che si vergognassero. Ma quelli niente, facevano i padroni e la colpivano di nuovo e infine le strapparono la legna e Caterina gridò come se le avessero strappato un figlio dal grembo.
Il Barivèl guardava dall’alto e ansimava per la rabbia. Poi quando vide che toglievano la fascina alla vecchia, di colpo, prese uno dei lastroni che coprivano il pendio e lo lanciò in basso, poi un altro, un altro, un altro ancora, cercando di schiacciare i due sgherri, di farne letame spappolato e uno quasi lo prese e le schegge del lastrone lo ferirono al volto e alle braccia, facendolo urlare dal dolore. Allora anche gli altri, quelli giù, presero coraggio e iniziarono a lanciare pietre, pietre, pietre, fino a che i due del Netro non saltarono a cavallo e sparirono lungo la strada che scendeva al paese.
Caterina raccolse la sua legna e s’inerpicò sin dov’era il Barivèl, più stupita che grata, quasi non credesse che al mondo potesse esistere qualcuno disposto a rischiare per lei. Almeno non da quando suo figlio era morto. Gli andò vicino e gli mise al collo il gropìn, il fazzoletto rosso con le due palline all’estremità, che portano tutti gli uomini di Traversella, quello che suo figlio aveva lasciato abbandonato sulla madia, il giorno che s’era perso in miniera. Il giorno che era morto. Il giorno che se ne era andato per sempre. Tanto rosso da confondersi col rosso dei suoi capelli, coi capelli spessi e intricati come carote del Barivèl. E stava lì a guardarlo, mentre l’altro ancora respirava a bocca aperta per la fatica di scagliare dall’alto tutti quei lastroni. Col suo fazzoletto rosso al collo.
Ma a quelli giù non piacque la faccenda del gropìn e salirono in due e glielo strapparono. Perché lui, il Barivèl con loro non c’entrava niente e non volevano che la gente pensasse che un diavolo così, uno come il Barivèl, fosse del paese, o avesse qualcosa a spartire con loro.
Le cose come il gropìn sono robe che meritano rispetto e metterlo al collo del Barivèl era come metterlo al collo di un mulo, o di un verro.
Lui all’inizio non ci aveva fatto caso, poi, di colpo, aveva iniziato a tirar fuori suoni strani, a urlare cose incomprensibili.
Vogghiumari, vogghiumari!
Girava di nuovo in tondo, come una bussola impazzita, o un cane che cerca disperato il punto dove seppellire il suo osso. Poi s’era fissato a guardare verso Est, lungo il crinale del Betogno che nasconde Brosso alla vista dei minatori. E s’era incamminato, come seguendo un orientamento antico e insensato. Verso Est.
Aveva iniziato a risalire il Betogno, sempre ululando quel suo incomprensibile grido: vogghiumari, vogghiumari! Era montato tra gli abeti e le betulle, su per il Riondello, sempre più su, fino a scomparire alla loro vista, s’era inerpicato, come fosse una capra selvatica, sin quasi alla cima, sul pianoro, da dove si scorge la punta innevata del Gregorio e, verso Ovest, il Cavalcourt, che dall’alto minaccia e protegge il paese. Saliva dritto, quasi seguisse una strada segnata, o sognata, come se a trascinarlo fosse un torrente d’energie, più impetuoso del Bersella, quando precipita a valle, sotto la miniera, ma lui invece saliva, saliva, saliva. Senza prendere mai fiato. Si arrampicava sulle falde del Betogno e ormai guardava verso Brosso, ai fuochi lontani che illuminavano la morena che abbracciava la città, quasi fosse la cornice che circonda una pietra preziosa.
Si lasciò piombare in basso, urlando, a braccia aperte, quasi volesse spiccare il volo, ma, tacchino che era, restava lì, attaccato alle zolle, alle pietre, ai rovi, ma andava giù veloce sempre più veloce e ormai s’era lasciato alle spalle la fonte e planava verso Vico, avanti, sempre più giù, evitando il paese, mentre le nuvole scure dell’altoforno che fondeva il minerale tirato fuori alla brossasca aggiungevano rosso al tramonto.
Giù, sempre più giù, sino a Brosso e alla morena che s’affaccia sulla pianura. Ed è ormai notte e la gente viene fuori dalle case a vederlo, mezzo uomo e mezza bestia selvatica e strana, che urla di dolore guardando la pianura sterminata che gli si apre davanti. Immensa come un mare su cui galleggiano, movendosi alla risacca, le luci fioche di Calea e Lessolo e avanti, sino a Ivrea, sfavillante come una caravella, o un veliero nell’oceano buio d’erba che il Balteo ghiacciato s’era lasciato dietro, fuggendo verso il cielo.
Ululò per ore, disperato, tanto che i monaci della Cappella di San Rocco quella notte salirono sin sul campanile per riuscire a vedere cosa accadeva in paese, chi era il demonio che da Brosso faceva sentire la sua voce fessa a tutta la pianura.
Poi di colpo smise e tornò indietro, prima piano, poi sempre più di fretta, ripercorrendo, passo dopo passo, il medesimo cammino, senza sbagliare, come se a guidarlo ci fosse un magnete fatto d’odori e impressioni, calpestando la medesima erba, rifacendosi la medesima ferita , su, su e poi arrancando e inciampando, rotolando, sfatto dallo sforzo, sino a piombare di nuovo davanti alla miniera, tra nuvole di terriccio e radici, come somaro che precipita nel burrone, a zampe in su, quando lo zoccolo va in fallo e il vuoto lo inghiotte.
Restò lì, rintontito per un po’… Poi, ragliando di sofferenza, si tirò su.
E quando vide che in miniera ormai si lavorava, si prese la sua cesta, concio com’era, e si avviò a fare il mulo.
Quel giorno, per la seconda volta, gli uomini gli andarono vicino. Gli dissero di fermarsi, gli chiesero – Tutto bene?
Qualcuno addirittura gli batté una mano sulla spalla e gli diedero vino e pane.
Perché era un barivél, ma in miniera ci sapeva stare e anche questo meritava rispetto.
VII
Non capisco l’altezza immensa delle loro montagne, come non capisco la loro lingua e i loro silenzi. Eppure siamo uguali, la miniera ci rende uguali.
Oppure no, ci rende uguali questo nostro comune sentire d’essere tanto diversi. Come due mondi, o due gocce d’acqua.
Chi va in miniera appartiene al buio e alla terra. Anche chi come me viene dal mare.
Ma io conosco il sogno, come conosco le onde, il loro rumore. Perché il mare è la via d’uscita, è lo strappo nella rete, da cui sfuggire alla cattura. E’ l’identico che non si ripete.
Ma qui non c’è mare, c’è solo acqua. E ghiaccio. E c’è la miniera.
Ho corso perché mi sembrava di sentire la voce del mare. Ma c’era solo l’erba di una pianura sterminata, senza fine, che mi imprigiona.
Ieri, però, ho ritrovato i segni. In superficie. Ed erano segni che mostravano un cammino. Il cammino che mi porterà da Misciu e dalla morte che come conchiglia lo imprigiona.
Perché io ora andrò via dalla miniera. Perché c’è un giorno in cui ogni minatore deve abbandonarla, uscire all’aperto e proseguire diritto, guardando il sole. Uscire alla luce, spegnere la lucerna, smettere di scavare e lasciare che sia il tempo che a scavargli dentro l’ultima galleria, quella che gli farà catturare le nuvole. E gli farà comprendere l’orizzonte.
Ho seguito i segni, lasciando la miniera dietro di me, lasciando che i minerali tornassero a mormorare ad orecchie sorde tutte le loro infinite immaginazioni.
Vado da Misciu. Anche per morire c’è bisogno di un padre. Senza non si può. Si resta sospesi nell’infinito indistinto che luccica come certe pietre azzurre e fluorescenti, al fondo della miniera.
Mi affido al fiume perché mi riporti al mare e nel salto immenso della cascata infine agguanterò mio padre e gli strapperò dagli occhi il velo della morte.
Ora vado, ma tornerò. Con un altro nome, un’altra lingua, un’altra faccia. Tornerò.
Perché io sono il capro. E, senza di me, voi non avete scampo.
VIII
Il Barivèl se ne era andato una mattina di luglio, all’alba, poco dopo la sua corsa insensata sino a Brosso.
Una mattina, semplicemente, non c’era più.
Nessuno, in realtà, aveva visto quando e come se ne era andato, ma, proprio per questo, ognuno aveva la sua storia da raccontare.
C’era chi diceva di averlo visto sulla grande spianata circolare, di fronte a Brosso, all’alba, che lentamente si trasformava in talpa, tirando fuori gemiti indescrivibili, piccolo, sempre più piccolo, e poi scavare, scavare, sino a sparire sottoterra. E che c’era rimasta solo una ciocca di capelli, rossa come il fuoco dell’altoforno.
Altri invece raccontavano che erano venuti a prenderlo in sette, di notte, a cavallo, zoccoli che montavano zoccoli, mantelli neri che celavano esseri senza volto e che gli si erano inchinati davanti e lui allora era balzato in sella, coprendosi di un uguale mantello nero, e che anche a lui erano spuntati zoccoli, neri come la notte della miniera, quando il vento spegne le lucerne e il buio ti guarda sino in fondo agli occhi.
Molti uomini, per mesi, dissero d’aver trovato sue tracce in miniera, alle quote più basse, in caverne e magazzini dove non entrava più nessuno da anni: pezzi di pane mangiucchiato, topi morti, squartati come solo il Barivèl sapeva fare, strani segni graffiti sulle rocce, cerchi e profili antropomorfi. Ciocche di capelli, rossi come labbra di donna.
A volte si fermavano di colpo, a mezzo del lavoro, e sembrava loro di sentire il suo inconfondibile ansimare risuonare lieve e soffocato lungo una discenderia, i suoi passi disordinati che ciabattavano al fondo di un camino. Poi più nulla. Era come se si aspettassero di rivederlo spuntare lì, davanti a loro, d’improvviso, come quella mattina di gennaio. Ed alcuni avevano addirittura sprangato con assi di legno i camini dove avevano sentito rumori. Poi avevano desistito. Quella miniera era un verminaio di tunnel e pozzi e nessuno avrebbe potuto chiudere tutti passaggi e i buchi che conducevano all’inferno oscuro da dove era venuto fuori il Barivèl.
Due pastori, quando tornarono dall’alpeggio, dissero di aver visto, in una splendida mattina di luglio, un essere strano, con i capelli più rossi delle fragole, che avanzava zoppicando lungo il sentiero che sovrasta il Chiusella, dove su ogni roccia la mano del tempo, o di un Dio, ha impresso segni incomprensibili, simili a quelli che gli uomini avevano trovato al fondo della miniera.
Era sparito tra i boschi e a loro era sembrato che seguisse una strada, o un percorso segnato. Né più lo avevano rivisto.
Un bambino, un giorno di novembre, disse di aver trovato sul greto del torrente un pezzo di tela scura, come quella dei calzoni del Barivèl, ma l’aveva lasciata lì e quando gli uomini si erano precipitati a raccoglierla, non c’era più, trascinata chissà dove dal vento, o dall’acqua del torrente.
Erano tutte storie, fantasie buone da raccontare la sera e nemmeno tanto, visto che, dopo qualche anno, nessuno ne parlò più.
Una sola cosa fu chiara a tutti, nei giorni successivi alla sua sparizione: da quando il Barivèl se ne era andato, era come se loro non fossero più loro. Come se lo specchio non riflettesse più il loro volto, ma solo il vuoto che ne scandiva i lineamenti.
Ma anche di quello si dimenticarono presto.