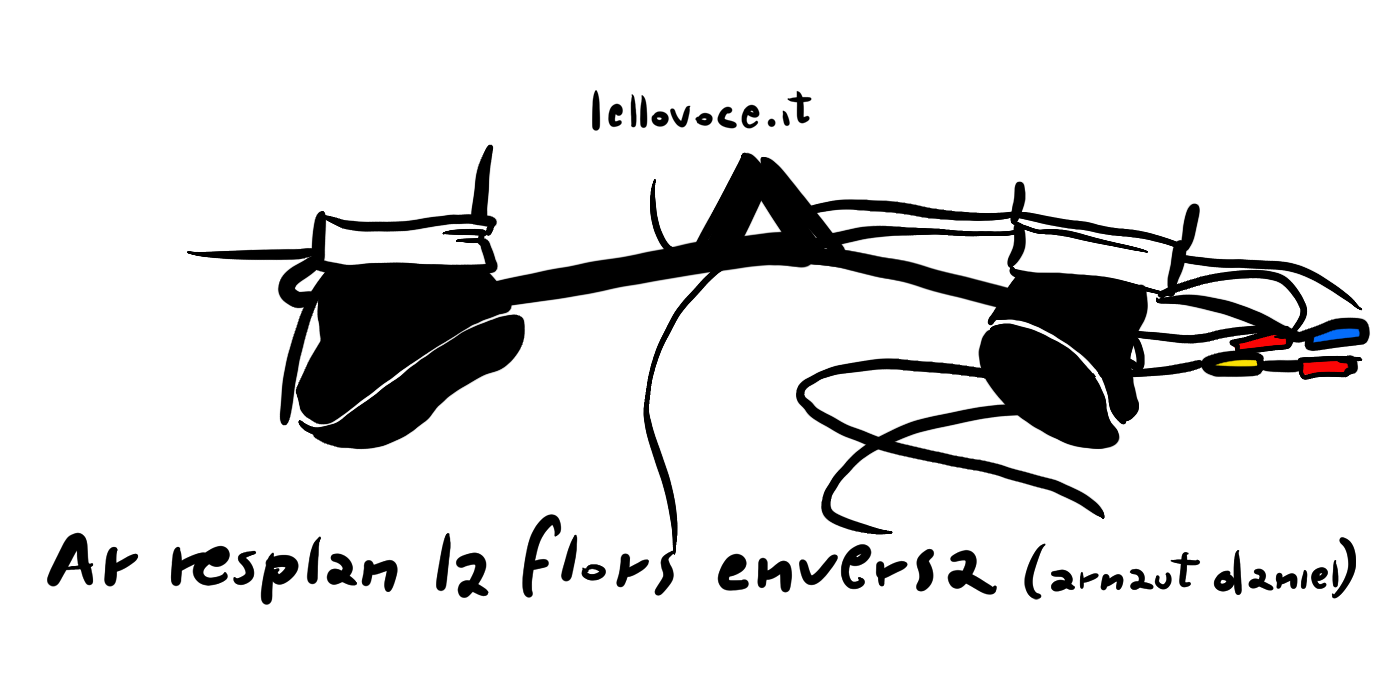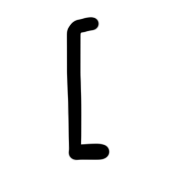Per certi versi, Lima è il Perù, ancor più di quanto Parigi non fosse, nel XVIII secolo, la Francia…
Mi spiego: su una popolazione di circa 30 milioni di abitanti, circa 15 risiedono a Lima, o nella sua ‘provincia’.
La metà del Perù, dunque, vive, o comunque gravita, intorno a questa megalopoli che la garúa (ma i limeñi dicono la neblina) rende tanto grigio-fumida e simile a Londra.
Lima è, in realtà, una grande sineddoche di tutto il Perù.
Dai quechua andini, agli indios della Selva, dai pescatori del Titicaca sino agli amazzonici di Iquitos, ai discendenti dei complici di Pizzarro, tutti son là, a Lima, dispersi e mixati nelle bidonville di Victoria, o nei quartieri operai di Rimac, arrampicati sul Cerro San Cristobal, o a godersi gli agi ormai millenari dei conquistadores, tra San Isidro e Miraflores.
L’antropologo dilettante non avrebbe difficoltà a trovar materia per il suo saggio sulla cultura peruviana senza muoversi dalla capitale, che, peraltro, come mi faceva notare Jerome – una delle mie ‘guide’, insieme a sua moglie Maria Antonietta, due letterati improvvisatisi per me tour operator – è forse l’unica città al mondo al cui interno si trovino indicazioni stradali per giungere dove si è già, a Lima, appunto, divisa com’è in distritos sostanzialmente indipendenti l’uno dall’altro, a volte addirittura governati da norme differenti (e così i taxi a 3 ruote che circolano dappertutto, a Miraflores e a San Isidro, i quartieri della jet society e degli stranieri ricchi, europei, americani, giapponesi, non hanno diritto d’accesso: troppo pericolosi, guidati in modo troppo sconsiderato, perché sia loro permesso di mettere a rischio i lombi ricchi dei pochi che contano davvero qua).
A Lima si è a Lima solo se si è nel centro storico, se no si è a Barranco, o a Victoria, o a Rimac, anche se ovviamente essere a Barranco, a Victoria, a Rimac è essere a Lima. Ma anche no…. Miracolo dell’Inca, o memoria maligna di un’ideologia à la Pizzarro, o à la Valverde?
A rispondermi occorrerebbe il genio di Garcilaso de la Vega, sommo poeta, ma lui, ahimè, è ormai fuori dalla mia portata di poeta postero, sotto le mentite spoglie di turista.
Resta solo una casa-museo, in centro, cioè a Lima, che ancora una volta evito di visitare: mi fanno orrore le case-museo, soprattutto quelle dei poeti, i quali, per parte loro, usualmente sono come lumache e si portano appresso la propria casa fatta di parole, fin nell’aldilà.
Mi sembra offensivo, sin spudorato e pornografico, mettere in mostra, post mortem, penne e calamai, y mesas y camas…
Pur di non vedere quelli, rinuncio volentieri anche alle prime edizioni, o ai manoscritti.
A volte il passaggio da un distrito all’altro di Lima è simile all’attraversamento di una frontiera, e i distritos più ricchi sono spesso costituiti da agglomerati di castelli pronti alla difesa dall’invasore ‘straniero’.
Le villette a schiera di Miraflores, o di San Isidro, sono difese da cavalli di frisia che coronano le cimase dei muretti. Elettrificati. E allora penso: che libertà è quella che, per essere esercitata, deve rinchiudersi da sé in una sorta di campo di concentramento, per quanto dorato? Che sensazione si prova a vivere in una villa protetta da reticolati a 220volts?
Ma a Lima è normale, evidentemente. Molti, se non tutti, lo ritengono necessario.
Troppa ricchezza troppo vicina a troppa povertà. La corrente a 220 volts, in questi casi, a taluno, può sembrare un’ottima soluzione, a quanto pare.
Per altro verso, però, Lima non è che una pallida metonimia del Perù, della sua tripartizione geografica: Costa, Sierra, Selva. E’ una relazione con la cosa, non la cosa in sé.
Perché il Perù è un luogo tanto meraviglioso da poter offrire a chi lo visita sia il caldo soffocante di Iquitos e della Sierra, della selva dell’Amazonas, che il freddo pungente delle Ande, gli strapiombi mozzafiato che circondano Machu Picchu, o l’indimenticabile Titicaca, lago capace d’onde grandi quanto palazzi, o il multicolore deserto di Paracas, che poi si tramuta in spiaggia oceanica, in costa Pacifica.
E questo perché, pur essendo edificata sul deserto, a Lima di deserto e di sabbia non v’è più traccia, pur essendo costruita più o meno a strapiombo sull’oceano, le sue spiagge sono lungomare tristi, soffocati da grattacieli, pur essendo sovrastata dalle Ande, le montagne Lima non le lascia vedere, coprendole di grattacieli, bidonville e neblina, né la neblina, mixata con il deserto, lascia scampo all’esplosione di vita e natura delle Amazzoni.
Tutto il Perù è a Lima, insomma, anche se poi, sostanzialmente, il Perù è altrove.
Cosa ne sia stato della Sierra e della Selva, che visitai ormai un trentennio fa, non saprei dirvi…
Me ne sono tenuto a debita distanza, dopo aver saputo che ormai a Machu Picchu si paga un biglietto d’entrata (io ci dormii in sacco a pelo – avendo perso l’ultimo bus che porta giù, sino alla stazioncina del treno a cremagliera sovrastata dallo Hyuana Picchu che dalle pendici del monte arriva sino a Cuzco – protetto dalle mura del acllahuasi, il locale in cui alcuni sostengono che i sacerdoti Inca preparassero le droghe rituali per i sacrifici: pagare un biglietto sarebbe stato inquinare uno dei più bei ricordi della mia vita) e che la pista dell’aeroporto di Iquitos è ormai ben asfaltata ed efficiente. Allora i comandanti dell’AeroPeru atterravano morbidi su terra battuta, nella sovrana indifferenza di chicos amazzonici che proseguivano a giocare a biglie, utilizzando le buche della pista per costruirsi percorsi di gara.
Nelle baracche di cemento prefabbricato di quell’aeroporto, un mio me poco più che ventenne incontrò il primo transessuale della sua vita. Stazionava in attesa di assai improbabili clienti sull’unica panca dissestata della sala arrivi. Capelli blu, unghie lunghe, artigliate, brache attillate, siliconi… Totalmente incongruo, nel cuore dell’Amazzonia…
I ricordi son ricordi, a volte meglio preservarli dal presente. La memoria è un oppiaceo indispensabile a noi umani, almeno quanto l’oblio e la distrazione.
Questa è stata la volta del deserto, della Costa vera, dei crani allungati e delle misteriose stoffe della cultura Paracas, del guano delle isole Ballestas, dove passò, ben prima di me, sin Garibaldi, che quel guano faceva raccogliere, per poi trasportarlo via mare sin negli States.
L’italico Risorgimento s’era appena compiuto e il mazziniano che era in lui doveva essere piuttosto disgustato del come.
Meglio il guano, in fondo, che fare i conti con il ricordo del faccione Sabaudo tronfio, a Teano…
Prima del deserto e delle migliaia d’uccelli del Pacifico, però, tra una lettura e l’altra di poesie, mi sono riservato una pausa per visitare un luogo unico al mondo e che, per chi come me pensa che in fondo i ‘tarocchi’ e le riproduzioni illegali di abiti, film, CD e annessi siano cosa sostanzialmente buona e giusta, è una sorta di paradiso: Polvos Azules.
Le merci ormai basano troppa parte del loro valore (e del loro prezzo) su faccende che definirei ‘estetiche’: sono indisponibile a pagare il brand per una percentuale sovente superiore al 50% del prezzo (e dunque del valore intrinseco, materiale) di un bene.
Trovo stupido che, per andare in giro a far pubblicità al nome di questo, o quel marchio, indossando magliette, o braghe griffate, non solo non mi si paghi, ma debba pagare io un surplus raramente motivato dalla qualità della merce.
Mi sento truffato e mi domando sempre se truffare un truffatore sia un reato, o non invece una corretta applicazione della dantesca legge del ‘contrappasso’ e, peraltro, trovo penose le geremiadi di taluni artisti, già plurimiliardari, che, invece di fare pressione sulla catena distributiva e sugli editori, per far abbassare prezzi proibitivi e già enormi margini di profitto per permettere a chi ama la loro opera di accedervi con facilità, stiano lì a suonar la banda a chi decide di perseguitare qualsiasi onestuomo che, mosso dall’amore per l’arte e dalle tasche vuote, faccia sharing di file musicali et similia.
Entrare a Polvos Azules è accedere in un mondo separato, in una sorta di bengodi, un paradiso dell’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, un passage post-benjaminiano dove tutto ciò che è irraggiungibile per molti, diventa di colpo a portata di mano per tutti.
E non si pensi a un mercato all’ingrosso di prodotti mainstream di bassa qualità. No a Polvos Azules si può trovare ogni cosa, anche quello che non si troverebbe mai altrove, dai vecchi film del neorealismo italiano, o dell’avanguardia brasiliana, a chicche musicali imperdibili.
Polvos Azules è la più grande cineteca e discoteca del mondo latino, probabilmente.
Ognuno di codesti ‘truffatori’ è in realtà un esperto filologo che ha la sua specializzazione: tutto si può comprare, tutto rigorosamente alla faccia del copyright: basta trovare il banco giusto e chiedere. Io ho chiesto Cancer mitica pellicola di Glauber Rocha. Tempo 24 ore e sarebbe arrivato. Provate a cercarlo a Roma…
L’edificio è enorme, impossibile far finta che non esista. Le autorità tollerano. Segno d’arretratezza? Forse, ma anche grande spazio di libertà, per tutti.
Che l’Inca sempre lo protegga, dall’alto del suo paradiso fatto di inaccessibili montagne, il palazzone multipiano di Polvos Azules…
E dopo le polvos il deserto.
Ma, prima del deserto, l’altro itinerario, quello che dura più di un’ora e che mi porta dal centro di San Isidro, attraversando mezza città, via via, fuori dall’orbita della capitale.
Uscire da Lima è un viaggio nel viaggio, lunghissimo infinito…. Distrito dopo distrito fin dove la città diventa polvere di abitato su polvere di deserto, una polvere fatta da migliaia di capanne-granelli, di tane di adobe, che si alternano a immensi lager per polli d’allevamento, tutte rigorosamente abusive, tutte con le pareti coperte dalle reclame dei candidati alle prossime presidenziali, una sfilza di adobe trasformata in un’enorme adervertise-wall, migliaia di abitazioni della povertà, mascherate da spazio pubblicitario per i ricchi che quella povertà creano ed amministrano a loro esclusivo interesse.
Arrivano ed edificano, i poveri. Senza permessi e senza speranze, da tutto il Perù. Per loro Lima è quella…
Li hanno scacciati, scatenandogli contro la cavalleria, appena pochi giorni dopo la mia partenza, da Pachacamac.
Che pretese che hanno, a volte, i poveri: andare a metter tende su un bene archeologico, riprender possesso – con i loro corpi vivi – di ciò che è sempre stato loro e che coloro che oggi ne conservano il cadavere impietrito hanno assassinato a tradimento, secoli e secoli fa.
A far la parte del leone è la candidata Keiko.
Keiko, Keiko, Keiko: capanna dopo capanna, ai lati della superstrada, persino i massi più grandi di questo deserto grigio scuro fatto di schegge di pietra, sono coperti dal suo nome scritto in rosso su sfondo bianco. Anzi: bianKo.
Keiko è Keiko Fujimori, ovviamente, la figlia di tanto impresentabile padre. Che preferisce firmarsi con il solo nome. Il cognome meglio non pronunciarlo, anche se tutti, ovviamente sanno chi Keiko sia. Un residuo di pudore, in fondo, che non farebbe male a tanti parenti e discendenti di reucci e dittatorelli anche da noi, nell’europea e democraticissima Italia.
Il deserto mi viene incontro, interrotto, ai lati della Panamericana Sur ,da poblaciones minime, tutte in corrispondenza dei rios che scendono dalle Ande: ogni piccola oasi, un paese, ogni paese un piccolo appezzamento di vigne, vigne per Pisco, ovviamente. Ogni piccola poblacion qua e là, le rovine del terremoto del 2007, o di quello del 2010, o dello tsunami.
Poi i paesi spariscono ed inizia il deserto vero, il multicolore deserto di Paracas.
La strada svolta a sinistra, lasciandosi alle spalle stormi di fenicotteri rosa, che sulla riva del pacifico sembrano passeggiare come signorine impettite sulla battigia.
Lo scrigno che cela gli enigmatici crani allungati delle mummie di Paracas e le sfarzose stoffe multicolori che le ricoprono è ormai a un passo…
Il nostro Nissan Terrano rosso (la camioneta, come la chiama Maria Antonietta), corre su sentieri disegnati su un deserto amaranto da sassi messi in fila indiana, come fossero piste per automobiline giocattolo, disegnate da pantagruelici bambini figli di giganti, che, invisibili e piumati con i colori dell’Inca, ci guardano dall’alto. Le dune sono enormi, montagne di sabbia granulosa e gli scheletri di barche, che appaiono improvvisi dalla sabbia, forse scagliati sin là dalle onde dello tsunami, sembrano incongrue arche in minore, abbandonate ed inutili dopo l’ultimo dei diluvi, un diluvio dopo il quale non c’è da attendere più alcuna Buona Novella.
Ogni tanto la nostra camioneta incrocia un’altra macchina, che sparisce nel nulla. Dalla Lagunilla a la Catedral, dove il deserto strapiomba nell’oceano, di fronte a un indimenticabile faraglione.
Lì ci fermiamo. Il vento è teso, gelido. E, come rispondendo a un comando subliminale, appena scesi dall’auto, ci allontaniamo uno dall’altro, anche i due figli di Jerome e Maria Antonietta. Ognuno per sé. Giriamo in tondo nel nulla, di fronte al nulla dell’Oceano. Come bussole impazzite che cercano un Nord che non c’è più.
E’ la forza del deserto, penso. La forza che disorienta, che azzera. Nel deserto si può essere soltanto da soli, non si è mai in compagnia. Il deserto ti entra dentro, ti separa, fa calcina dell’animo e dopo, una volta fatta piazza pulita, ti restituisce a te stesso, ripulito.
Ci guardiamo da lontano. Ci veniamo incontro, per poi svoltare improvvisamente altrove, come formiche quietamente impazzite.
Immagino i figli di Jerome e Maria Antonietta trasformati in piccoli Paracas, con la testa stretta da bende e cunei, una testa allungata, coperta da stoffe che sono libri, lunari, mappe astrologiche ormai incomprensibili e penso che in realtà tutti i bambini hanno il cranio allungato, e grazie ad esso vedono più lontano di noi, a volte; immagino che le trapanazioni dei crani fossili di Paracas altro non siano che varchi per un terzo occhio, ormai perso da noi postmoderni occidui, con il cranio piatto e senza buchi che non siano quelli d’ordinanza.
La mattina dopo ci imbarchiamo per le Isole Ballestas. Le isole del guano, dei cormorani, dei leoni marini, dei pinguini di Humboldt, branco di turisti tenuti a bada da una guida che assomiglia all’orso Yoghi, preciso e silenzioso come un giapponese, e non è una novità, ché, a quanto pare, i giapponesi da queste parti c’erano arrivati quando ancora delle navi di Pizarro non c’era, per fortuna dell’Inca, alcuna traccia all’orizzonte.
Mentre lo scafo corre via dalla riva a più di 30/40 nodi, il cielo si copre di uccelli, di più, sempre di più, migliaia, a stormi compatti, in cielo e a raso d’acqua, dove enormi pellicani ci superano di lato beffardi, senza degnarci d’uno sguardo e senza bisogno d’alcun fuoribordo.
Prima arriva la puzza, poi le isole. Le isole nere coperte da guano bianco. La natura puzza. Noi tolleriamo solo odori, ormai.
Poi il rumore. Lo stridio di milioni di uccelli, le grida chiocce dei pinguini, i ruggiti fessi di centinaia di leoni marini. Impressionante.
Quando torniamo a riva, congelati, ma ustionati da un sole equatoriale, le orecchie fischiano di un brusio ostinato, assordante, che non passa, come quello degli elicotteri a Genova, nel 2001.
Prima di far marcia indietro, torniamo nel deserto. Ed io provo infine a scattare qualche foto. Ma non riesco a trovare l’inquadratura giusta. Mai.
Forse perché nel deserto non devi muovere la macchina fotografica per fare scatti diversi, è il paesaggio che si incarica di cambiare, attimo dopo attimo, ora dopo ora, a ogni soffio di vento, e a Paracas a mutare freneticamente sono anche i colori: grigio, rosso, il bianco delle incrostazioni saline, ocra, di nuovo rosso, poi amaranto.
Ed è allora che capisco che fotografare il deserto è impossibile, perché il deserto, nel caso accetti sdegnosamente l’eventualità, si fotografa da solo.