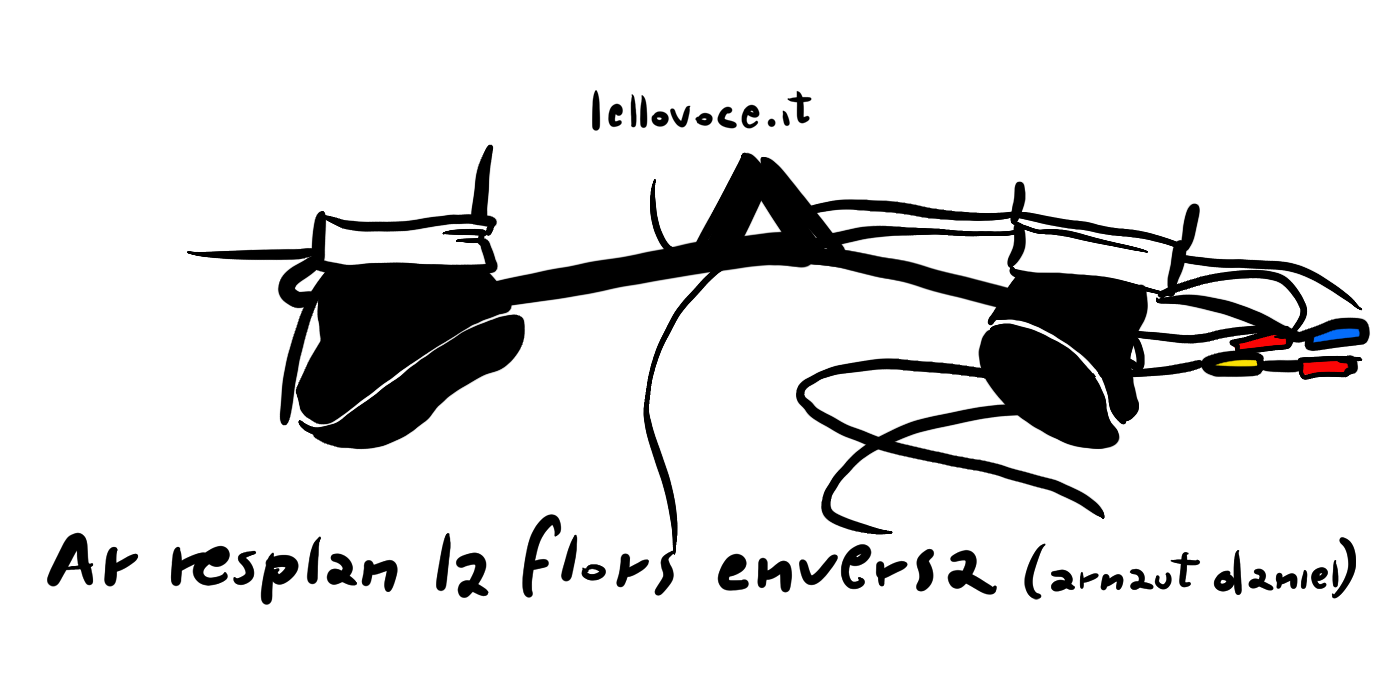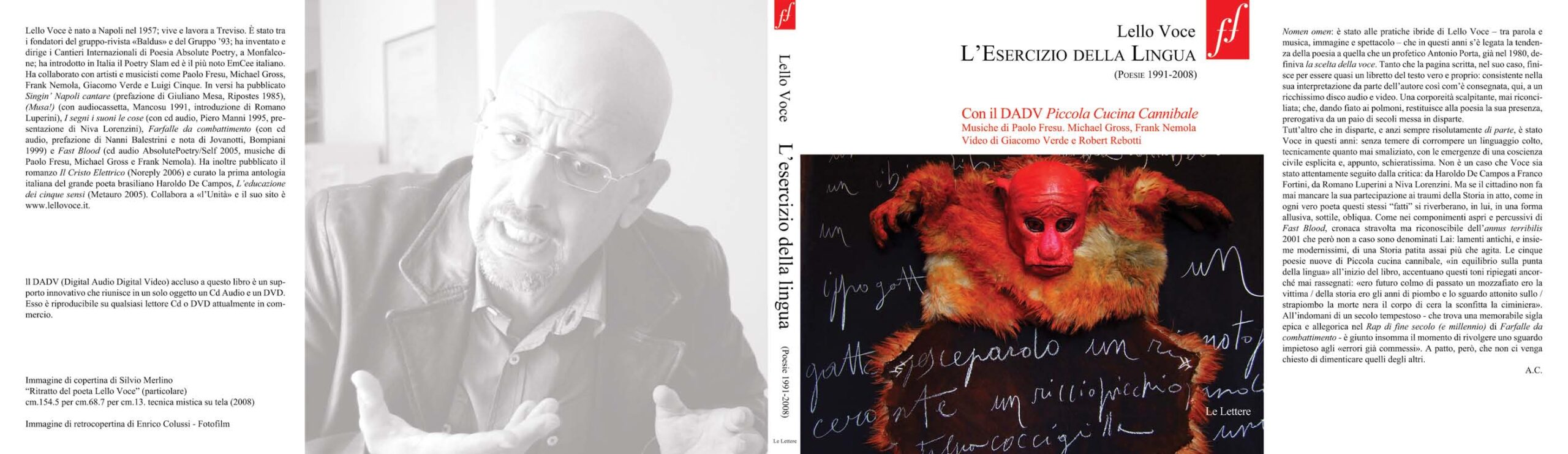E’ un EmCee Zanzotto? Nooo. Chi è un EmCee, anzi il più noto d’Italia? Lello Voce, partenopeo di Treviso, omen nomen per un poeta che si dispiega con ali di farfalla in un volo che brucia e bombarda (il corpo al centro delle bellissime ali è un fuso d’acciaio e porta bombe). Sapevate di avere un poeta, non sapevate di avere un EmCee: che, abbiamo cercato, è la parola suono di MC, master of ceremony. Maestro di cerimonia, cioè organizzatore di eventi, cerimoniere, presentatore, ma meglio sarebbe dire agitatore, provocatore, sobillatore di pensieri e incroci, via dallo stereotipo, via da lustrini lamè e sorrisi stampati, lì sul palco e a tirar fuori le proprie e altrui budella, per un piacere difficile e doloroso, con la voglia di fare autopsie a corpi viventi: il proprio, i nostri. Un’autopsia dove il bisturi sono le parole, e le parole il fegato e gli altri organi, cervello per ultimo.
Master of ceremony: e la cerimonia è “L’esercizio della lingua”, una specie di summa del fare poetico di Lello Voce, libro di emozioni forti, libro che se volete metterlo sotto l’albero vi cambia il giorno di Natale classico, libro che rimbomba anche rimanendo chiuso. In apertura, gli inediti che giustificano l’operazione (chirurgica), i versi di “Piccola cucina cannibale” nei quali si denuncia l’apostasia, il controcorrente: “c’è bisogno piuttosto di versi che sappiano ancheggiare di poesie pingui di sillabe che scavino la fossa di soli mandolini”. E lui, Voce, va dall’altra parte, con un verso lungo come la voglia di dire, come se la riga non bastasse a contenere il dicibile, con un ritmo costruito sulle pulsioni continue, incessanti, molte nello stesso verso, un tambureggiare ossessivo di verità nude e crude che non si allineano, ma si inseguono, si calpestano, si affollano le une sulle altre. E’ un’analisi che sceglie il tumulto, l’assenza di pause: dire di getto, tutto insieme, dopo aver pensato molto. Ma l’esercizio della lingua c’è: la velocità porta con sé la raffinatezza, la trattiene quel tanto che basta a farla riconoscere, e ci sono scelte, giochi perfino, musicalità di sillabe, rime che non sono rime ma allitterazioni, sparse dove pare a lui, l’EmCee che vi sta creando l’evento sotto gli occhi.
L’evento non è pubblico, l’evento avviene in voi per opera di Voce. Se avete in mente una tranquilla mezz’ora di lettura, poltrona lampada un buon bicchiere, lasciate stare. Con Voce la schiena non si appoggia più allo schienale, il bicchiere resta pieno, siete fermi ma in voi entra una forza cinetica improvvisa, siete trascinati dalle parole, quasi, al limite, non fosse importante il significato, ma la corsa verso la fine del significato.
Controcorrente, ma soprattutto corrente: ma una corsa ha bisogno di una superficie liscia, e invece Lello Voce corre forsennato sotto la superficie, dentro. Dentro dove? I nostri corpi, le nostre coscienze. Correre dentro un corpo è spaventosamente sanguinoso, ma la parola è bisturi, dicevamo, spazza tutto, taglia e rimuove, lasciandosi dietro pozze di sangue, pezzi di corpo. E’ tale la volontà di scavare che Voce si infila nella perversione, un grand guignol cauterizzato dai termini secchi: e leggiamo di chiodi conficcati, di labbra cucite, di gambe tagliate, di cuori spaccati. E’ tutto quello che non vorremmo vedere, e Voce ce lo impone alla vista: scarnificare l’uomo (“sono un osso innamorato”), con quella violenza che tutto pervade, e che qui torna visibile, attiva, maledettamente feconda.
Tutto è costruito attorno al sé, quello di noi tutti: l’uomo si vuota gridando, vomita grumi della propria essenza, si pone domande a cui non c’è tempo di dare o attendere risposta, perché c’è un altro grido da aggiungere, un’altra disperazione, ancora un harakiri. Non sono finiti i tempi della denuncia, dell’interesse sociale, marchio della poesia engagée di Voce, ma qui e ora passano attraverso il sé: il poeta si è fatto uomo, adopera la Tac per guardarsi dentro, e mica è sempre contento. Magari sente “il tellurico in me che si fa caos”, senso di vita primordiale che anima i colpi di mazza di Efesto (abbozzo riuscito di tragedia greca: andrebbe coltivato, sarebbe vero coup de théatre). Quei colpi di mazza che forgiano li sentite ad ogni verso, ad ogni strofa, un sottofondo metallaro che non vi lascia fino all’ultima parola. Questo sempre: è nel Dna di Voce, sorda percussione che non annacqua lo squillo delle parole, ma dà il timbro complessivo, musica non scritta eppure scaturente: non a caso il “Fast Blood” di qualche anno fa era un rap poetico, non a caso Voce cerca e trova chi gli regala note (Paolo Fresu, Frank Nemola, Giacomo Verde, Luigi Cinque, Michael Gross). Non a caso Gabriele Frasca, nella sua difficile introduzione (ostica, ma geniale in alcune
espressioni, tipo “questa parola in cerca della sua carne”) parla di “congegno fonografico”. Proprio così: suoni che escono dalla grafìa, per cui il libro rimbomba, anche chiuso. Ma apritelo, con il coraggio di farvi una radiografia: anche se ci si sente bene, siamo tutti malati di sentire.