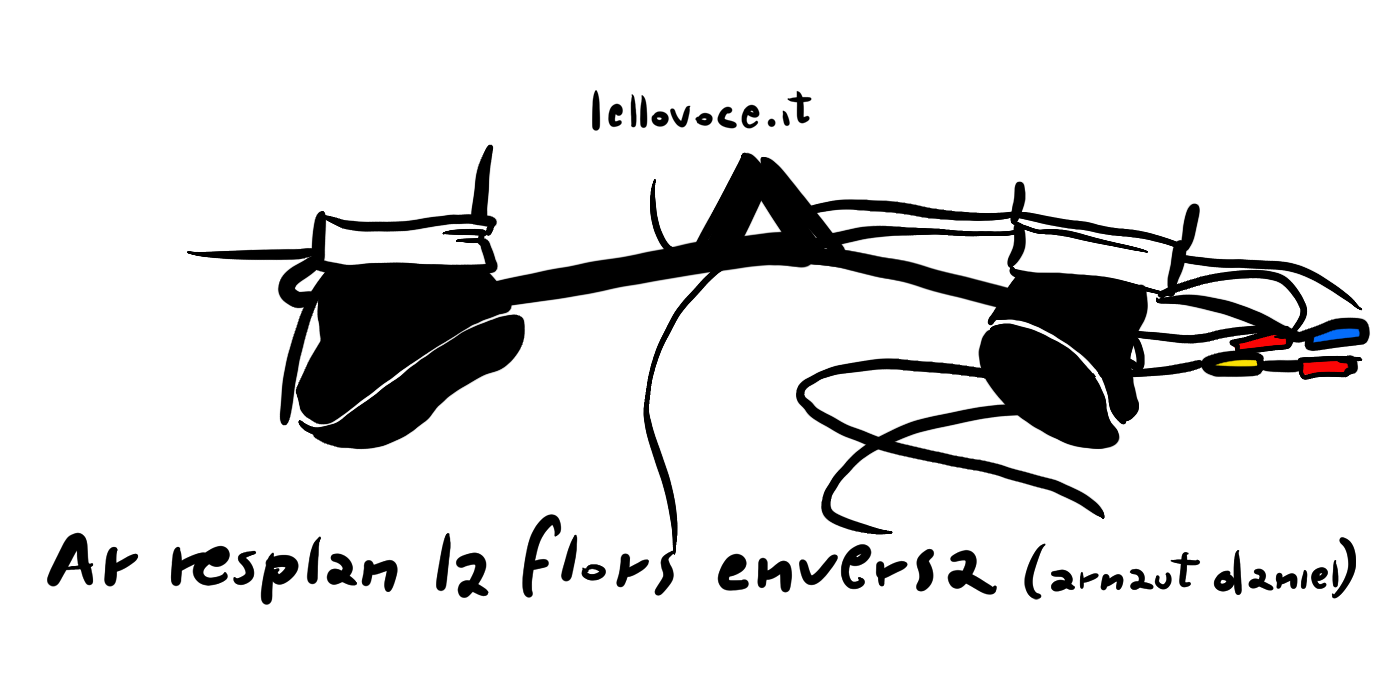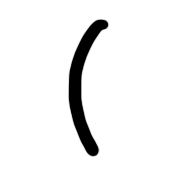Un libro bianco, con in copertina una foto bianco-nero, virata in seppia, della villa di Longone. Era l’edizione Einaudi del 1984. Un oggetto apparentemente inoffensivo. Docile, con quella sua aria fin de siècle, l’immagine familiare dello struzzo, in alto a sinistra…
Solo quel titolo, vagamente minaccioso e definitivo: La cognizione del dolore…
Quanto di più religioso possa dire un ateo, pensai, mentre lo pagavo e me lo portavo a casa, sotto braccio.
Certo dovevamo essere davvero una strana coppia, io e il mio Gadda: un ex-anarchico, ex-giovane-imprenditore-per-caso, ora in bolletta, con tonnellate di mali oscuri che ancora gli si aggiravano su e giù per l’angiogramma e più o meno gli attossicavano futuro e ricordi, mentre tentava tardivamente di laurearsi scribacchiando poesie, e lui, il romanzo, barocco verbale di un matricidio, di un delitto forse mai commesso ma solo immaginato e, proprio perciò, ancora più terribile, storia, tanto intricata, quanto evenemenzialmente evanescente, di Gonzalo Pirobutirro d’Eltino, un po’ Misantropo e un po’ Malato immaginario, che, dopo la morte in guerra del fratello, vive nella villa di famiglia con l’anziana madre vedova: fino alla sera terribile dell’aggressione contro di lei e – forse, ma il testo è, al proposito, assolutamente reticente, quasi che fosse lui l’imputato – del suo assassinio…
Cosa avrebbe mai potuto legarci, me, il figlio del geometra self made man, e lui, l’Ingegnere: cosa avremmo avuto mai da dirci? Cosa univa la mia villa e la sua villa, la mia solitudine e la sua solitudine; c’era dunque un colloquio possibile tra il male invisibile di Gonzalo e la coscienza oscura che si nutriva della sua stessa entropia che io sentivo ancora pulsarmi tra il fegato e lo sterno e che mi aveva squarciato le vene di crateri?
Cosa c’entrava la mia provincia centro-italiota, anniottanta, strabordante di yuppismo rampante e droghe pesanti, avvelenata di craxismo e merci, rifocillata di privilegi a basso prezzo e morte delle ideologie, con la sua Lombardia, travestita da immaginario e sudamerindo Maradagàl, con la sua Brianza mascherata da Latino-America? Cos’avevano in comune un ragazzo, figlio di un ex parà della Nembo e di una socialista lombardiana con simpatie rivoluzionarie, un po’ napoletano, un po’ calabrese, un po’ irpino e con un cognome etrusco, tirato su tra Impresa e Brecht, e l’ambivalente ed inquietante hidalgo gaddiano, Gonzalo Pirobutirro dei Marchesi d’Eltino, eroe dimidiato di un romanzo ancor più meticcio del suo protagonista e del suo casuale lettore, tragedia antica e insieme giallo all’americana, mescola ibrida di Amleto, Re Lear e Gargantua, con sullo sfondo, ironico e ammiccante, il Don Chisciotte di Cervantes?
Eppure quel libro, lo sapevo ancor prima di sfogliarlo, era urgente ed era – assolutamente – presente…
Ricordo di aver letto d’un fiato tutte le prime pagine, con la sensazione di avere di fronte a me un serpente pronto a colpire, che sgusciava di lato, come la trama di quel romanzo, celandosi tra le robinie maragadalesche di Lukones, spostandosi dalla storia di tale Pedro Manganones, a quella dell’eccezionale fulmine che, tautologizzando l’andamento della vicenda, improvvisamente si trasferì da una villa all’altra e fino al pianoforte a coda di Villa Enrichetta e, di lì, nella bagnarola della donna di servizio, e poi ancora, saltando a piè pari, giunge – digressione dopo digressione – al fantasma del Caçoncellos, aedo locale, per rimbalzare infine, sempre più turgida di virtuosismi sintattici e magnifici attriti lessicali, sui pensieri del medico condotto che, perplesso, si avviava a incontrare Gonzalo, il «figlio della Signora».
La prosa mi danzava davanti agli occhi, come un cobra lesto all’attacco, e io non capivo, seguivo il sentiero tortuoso e pieno di sassi che risaliva anche il Condotto, verso la Villa dell’Hidalgo, affascinato e ipnotizzato dal flettersi morbido e dall’ondeggiare del racconto, tra le voci ossessive e terribili che circondavano il figlio… «José, il peone, sosteneva che egli avesse dentro, tutti e sette, nel ventre, i sette peccati capitali, chiusi dentro nel ventre, come sette serpenti: che lo rimordevano e divoravano dal di dentro, dalla mattina alla sera, e perfin di notte, nel sonno»… « … e poi scoppia fuori in un verso che è buono solo lui di farlo, – a parlare adesso è la Battistina, gozzuta domestica della villa – come fosse il diavolo a ridere, ai piedi d’un morto, che lo ha appena usmato e sta per beccarselo via; e dice che le donne son bestie con addosso cinquemila pezzi di brillanti, e nient’altro che bestie, dice, porche bestie… e che intanto i morti hanno riempito i cimiteri, sicché non c’è più nessuno che si decide a morire, neanche le bestie… »
Il serpente si dondolava sulla coda, mentre migliaia di sonagli – sotto le mentite spoglie di avverbi, aggettivi, congiuntivi, neologismi – mi risuonavano negli occhi. C’era qualcosa che mi minacciava e che mi riguardava, alla fine di quella danza di una lingua che si trasformava in rettile e saettava biforcuta. Girai la pagina e lessi oltre… «E c’era, per lui, il problema del male: la favola della malattia, la strana favola propalata dai conquistadores, cui fu dato raccogliere le moribonde parole dello Incas. Secondo cui la morte arriva per nulla, circonfusa di silenzio, come una tacita, ultima combinazione del pensiero. E’ il “male invisibile”, di cui narra Saverio Lòpez, nel capitolo estremo de’ suoi Mirabilia Maragdagali.»
Capii allora che quel libro stava parlando proprio di me, che per qualche oscura, ma innegabile ragione, Gonzalo ero io. O, almeno, che lo ero stato fino a poco prima e che, per altri versi, lo sarei rimasto per sempre. Che quella era la condizione essenziale dell’esistenza mia, ma più in generale, della esistenza nostra. Senso definitivo e spiccio. Senza appello. La cognizione del dolore. E che se si falliva, l’alternativa era solo l’avverarsi del terribile sogno dell’hidalgo: « Un sogno… strisciatomi verso il cuore… come insidia di serpe. Nero. Era notte, forse tarda sera: ma una sera spaventosa, eterna, in cui non era più possibile ricostituire il tempo degli atti possibili, né cancellare la disperazione… né il rimorso; né chiedere perdono di nulla… di nulla! (…) Ogni finalità, ogni possibilità, si era impietrata nel buio. Tutte le anime erano lontane come frantumi di mondo (…) esuli senza carità da noi nella disperata notte…» O il realizzarsi della sua fantasia più violenta: «Estraeva dall’astuccio la leggera mitraglia, ne riprovava a vuoto il congegno… (..) Ecco il caricamento e il recupero: funzionavano? oh! se funzionavano! Tatràc, la molla! il gancio. (…) I caricatori eran lucidi, con acute punte, come pettini (…). Scendeva: le scale di casa sua, scendeva. La sala era piena di gaglioffi. Si piazzava allora sul terrazzo, ritto, a gambe larghe sul terrazzo di casa sua, con la pistola a mitraglia, come tenesse un bel mandolino, da grattarlo! da grattarlo ben bene, quel mandolino. Tatràc: la molla, il nottolino, il gancio. Un caricatore lucido, un pettine. La canna del mandolino infilava la sala. Oh! che bella romanza, che manduline, checcanzuna, che marechiare, nella casa liberata! disinfettata!»
Mentre leggevo, sempre più scoprivo quella specularità evidente, che suonava quasi come una condanna: soli entrambi, io e Gonzalo, in una villa deserta, mentre al piano di sotto si aggirava il silenzio dolente della madre.
Sopravvivere ai propri figli , come era rischiato che capitasse anche a mia madre, nella sua assoluta innaturalezza, è l’insulto più infame che il destino possa riservarci.
Dimostrazione definitiva e tragica dell’insensatezza del dolore e dell’immedicabilità della sopravvivenza, il dramma della madre di Gonzalo, che si aggira in cantina minacciata dallo scorpione, pensando al figlio morto in guerra, mi è sempre apparso come l’allegoria suprema del male e della sofferenza – allora come oggi. «Il suo pensiero non conosceva più perché, perché! dimentico, nella offesa estrema, che una implorazione è possibile, o l’amore, dalla carità delle genti. (…). Invano aveva partorito le creature, aveva dato loro il suo latte: nessuno lo riconoscerebbe dentro la gloria sulfurea delle tempeste, e del caos (..): e per lei la vecchiezza: questa solitudine postrema a chiudere gli ultimi cieli dello spirito. (…). Non vide più nulla. Tutto fu orrore, odio.»
Mi sorprendo oggi a chiedermi, dopo quasi un ventennio da quella prima lettura, cosa direbbe la madre di Gonzalo a quelle della Plaza de Mayo, cosa alle rughe assuefatte troppo presto alla vecchiaia e alla miseria delle donne di Hebron, di Gaza, o ai volti ben curati e straziati delle madri di Tel Aviv, New York, o Mosca. E a volte immagino che sia lei, la madre di Gonzalo, a parlare con la voce di Haidi Giuliani, mentre racconta di Carlo. Così come, sempre più spesso, di fronte a questo nostro mondo falsamente globale e realmente molto, molto ‘particulare’, ormai sull’orlo di un tragico collasso, mi domando se non era a questo che alludeva Gadda, quando, parlando della morte (di un uomo, di una civiltà, o di un sistema sociale), la definì come la «decomposizione estrema dei possibili».
Addirittura mi capita, se c’è il sole e sono in vena di sognare allegramente sino al delirio, con un volo più pindarico di quelli pindarici, di immaginarli tutti, oggi, i personaggi minori della Cognizione – José il peone, la Beppina, la Battistina, Pedro Mahagones, o almeno (almank, in maradagalese) i loro nipoti – in una Aguacaliente zapatista, piena di bambini, riuniti attorno a un passamontagna scuro, sollevato da «un naso prominente».
E immagino che il Sup scopra il suo volto, infine: quello di un Gonzalo che non odia più i bambini, ma che, anzi, infine, sorride loro sornione, con quel sorriso definitivo e profetico che dissolve il dolore delle generazioni, nel realizzarsi dell’Utopia che rinasce per chi domani nascerà.
Previous Reading
Continue reading
I cani di Fortini
28 Dicembre 2003
I cani del Sinai sono quelli che si affrettano a «correre in aiuto dei vincitori» e non vivono affatto sul...
Next Reading
Continue reading
Pedro Almodovar, <i>Fuoco nelle viscere</i>
28 Dicembre 2003
Tra il 1977 e il 1982, appena all’indomani del tramonto dell’epoca franchista, nelle strade di Madrid si muoveva – pendolando...