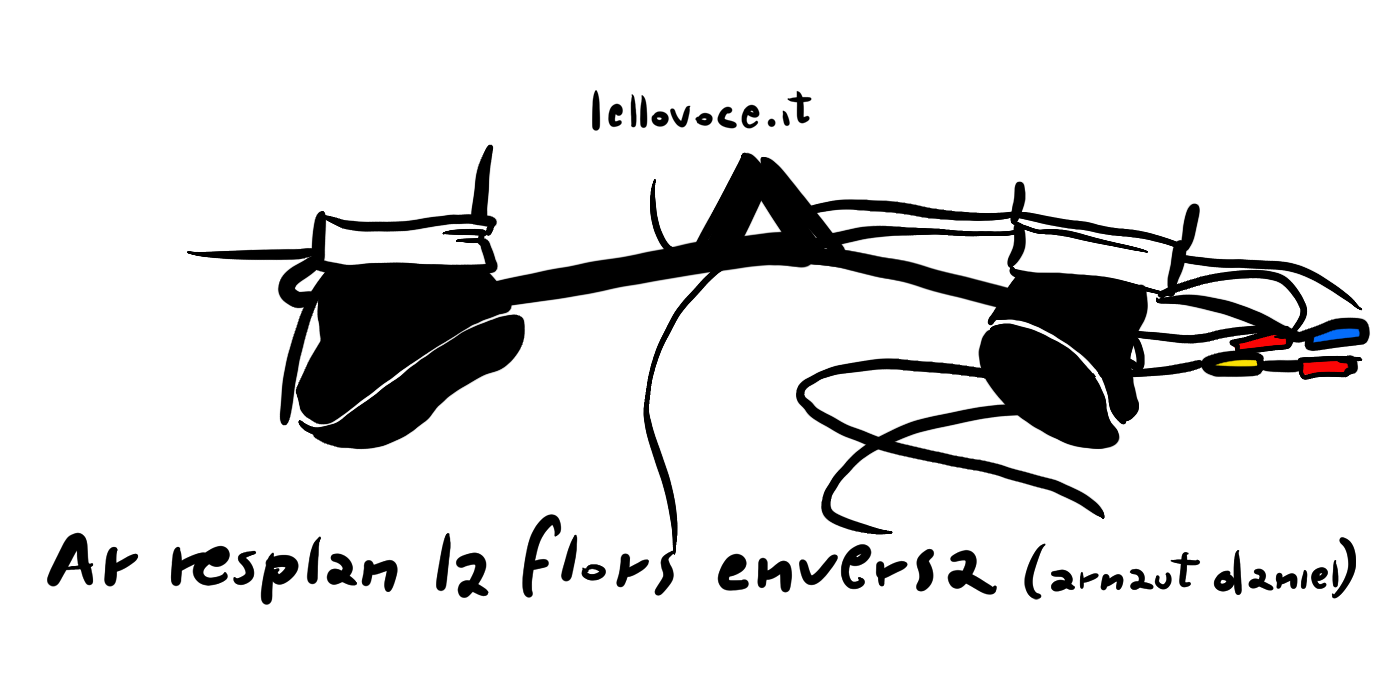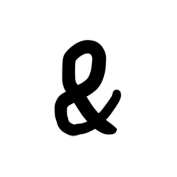Come è nato il progetto di “Piccola cucina cannibale”, che si presenta come un libro di poesia musicata a fumetti? Libri di poesia accompagnati da CD audio oggi non sono rari, ma libri di poesia a fumetti non mi sembra di averne ancora visti, al di fuori del tuo.
Sono ormai più di vent’anni che faccio ‘spoken word’, poesia ‘oralizzata’, e dunque il mio rapporto con la forma libro è necessariamente più complicato, complesso, di chi si limita a scrivere versi (e magari a pronunciarli sul palco, in occasione di questo, o quel reading).
Il testo scritto è per me solo una parte di ciò che chiamiamo usualmente poesia, sta in luogo piuttosto vicino a quello che occupa uno spartito per un musicista, per quanto il linguaggio verbale abbia un codice scritto singolarmente povero per tutto quanto riguarda la sua esecuzione, visto che poi ogni lingua è prima di tutto un evento sonoro, che lo scritto si limita ad alludere, o a codificare in modo spesso piuttosto lacunoso.
Per altro verso il libro, così come lo intendiamo noi oggi non è sempre esistito, né è l’unica forma attraverso cui può essere comunicato un testo scritto. Anzi probabilmente il libro cartaceo (che pure è a mio parere oggetto tecnologicamente ancora efficacissimo) oggi è in profonda crisi e non tanto per la concorrenza degli e-book (che ne mimano la forma, virtualizzandola) quanto per la presenza di Personal Computer e Rete.
La rete e i social network hanno evidenziato una caratteristica sinora ignorata dello scritto: la sua possibile impermanenza, il suo essere liquido, pensa alle chat, o al flusso enorme di scritti che costituisce l’evanescente, ma formidabilmente solida struttura di Facebook.
Tutto ciò accade proprio nel momento in cui l’oralità acquista – grazie alla sua possibile registrazione, analogica e digitale – quella ricorsività, e capacità di essere conservata, che prima era solo dei segni scritti. Quasi che si stesse passando da una società dello ‘scripta manent, verba volant’ ad una del ‘verba manent, scripta volant’.
Ovviamente il libro è al centro di tutte queste dinamiche, di questo ‘migrare’ dei segni e delle arti. Intanto si accoppia da un po’ di tempo con un supporto sonoro, prima le audiocassette, poi i CD audio, oggi basterebbe un link per interfacciarlo in Rete.
Sarebbe interessante, ma non è questa la sede, indagare un po’ sulle reciproche relazioni che si stabiliscono tra scritto ed orale in caso di supporti di questo tipo, supporti che definirei ‘transgender’. Farsi qualche domanda. Tipo: come si usano? Si legge prima il testo? Si ascolta il CD? Si legge, ascoltando?
Ognuno ha ovviamente le sue risposte, ma queste mi sembrano domande interessanti, innanzitutto perché tendono a destrutturare la ‘forma libro’, a renderla ‘mutante’.
Se può interessare il mio parere, io credo che, per cose come le mie, l’ascolto venga prima della lettura, perché nell’ascolto sono racchiuse tutte le forme artistiche dei miei testi, tanto quella linguistica, quanto quella sonora, a maggior ragione da un quindicennio in qua, da quando cioè, ho iniziato a lavorare stabilmente anche con la musica. Né credo ai luoghi comuni per i quali la profondità e la complessità linguistica siano solo dello scritto. Basta un’occhiata alla vulgata della linguistica antropologica (Hagege, per esempio) per convincersi del contrario.
In generale mi piacerebbe fare soltanto dei dischi, con il loro booklet ovviamente: credo che la ‘forma disco’ sia la più appropriata per me.
Per altro verso, come sempre, i nostri desideri cozzano contro la realtà: mi si propone di far libri, per lo più, sono un poeta, etc etc…
Allora nasce la curiosità di forzare la forma il più possibile, di espanderla, mutarla. Usarla a sproposito, se vuoi. A maggior ragione se si tratta di poesia, che è arte ‘amichevole’ per eccellenza, è un’interfaccia molto friendly, spesso disposta a sposarsi con l’altro da sé.
A parlarmi per la prima volta di Poetry comics è stato, circa due anni fa, Claudio Calia, vecchio amico ed ottimo autore di fumetto. Aveva scovato un numero di “Poetry” con la presentazione dei primi tentativi effettuati in questo senso da alcuni autori americani che ci sembrarono subito molto interessanti e stimolanti.
Il fumetto mi ha sempre affascinato, pur non essendo un esperto, mi ha sempre conquistato la sua duttilità, la sua ‘dinamica’ non necessariamente bustrofedica, la sua capacità di fondere così bene parole e immagini. Ho sempre pensato che avesse molto a che spartire con la complessità e ricchezza di fruizione che accompagna i testi poetici. E sono molto affascinato dalla libertà, dalla passione dalla profondità con cui il fumetto moderno riflette sulle sue forme, e le flette, le muta, le mette alla prova. Ben più che non la letteratura.
È nata così la complicità con Claudio e la decisione di tentare la prima esperienza di Poetry Comics italiana. Ciò avrebbe, inoltre, permesso di iniettare germi mutageni nella forma libro…
Credo che ci siamo riusciti: un solo titolo, tre autori (io, Calia e Frank Nemola per la generalità delle musiche, ma tanti altri, così da trasformare il tutto in un’opera invero collettiva), tre differenti medium di trasmissione (grafico, linguistico, sonoro-musicale), messi a regime insieme (dalla forza centripeta delle parole, della poesia, che è sempre sul proscenio) e costretti, proprio perché condomini, a sviluppare al massimo le loro singole peculiarità.
Da questo punto di vista PCC è un libro solo in senso lato: in realtà vorrebbe essere una ‘macchina celibe’, che dissipa sensi, dissipa forme (grafiche, linguistiche, sonore), ma che, proprio grazie a questa sua entropia, apre varchi nella rete di convenzioni (estetiche e sociali) che ci avviluppa.
Tu vieni da un’esperienza che è quella del Gruppo ’93 e dalla direzione di una rivista militante come “Baldus”, che si situava in rapporto critico, ma fondamentale, con le avanguardie novecentesche. Successivamente, se non sbaglio, tu parlasti di “avant-pop” e iniziasti a percorrere una via, che mi sembra essere ancora quella odierna di avvicinamento della poesia a forme di musica più popolare, come il jazz, il rap e oggi a forme d’arte visiva come il fumetto. Che ragioni dai di questa scelta? Trovavi che fosse esaurita la stagione della poesia sonora, delle sperimentazioni più “difficili” tra poeti e musicisti colti?
Non credo che si possa individuare nel mio sviluppo formale e poetico una svolta netta come quella che tu qui proponi.
Da sempre in Baldus ci siamo posti oltre certe opposizioni meccaniche. Già all’altezza delle inaugurali Tesi di Portici, dichiaravamo esaurito il bipolarismo Avanguardia/Tradizione, poi Biagio Cepollaro propose di parlare per noi di Postmodernismo critico, nozione accettata da anche da me e sviluppata poi in uno scritto per Allegoria in cui parlavo di Tradizione come genealogia delle Avanguardie. L’aporia dell’avanguardia che finisce in museo, su cui ha tanto riflettuto Sanguineti, è forse aporia di sempre, è condizione stessa dello svolgersi storico dell’arte, di tutte le arti. È, per l’appunto, il segno stesso del loro essere ‘forme storiche’ e, probabilmente, anche storicizzabili.
Il tentativo è stato sempre – almeno per me – quello di ricostruire la possibilità di una comunicazione, che però fosse contemporanea e complessa, non appiattita e monodimensionale come quella della postmoderna società dello spettacolo, o dei neo-orfismi liricheggianti che da decenni impazzano in Italia.
La ricerca formale per me è stata sempre un aspetto di una più generale ricerca tesa a ‘comunicare’, a comunicare in modo complesso, ricco, profondo, certo, ma anche tendenzialmente generalizzabile.
Si scrive sempre per un popolo che non c’è, come direbbe Deleuze, ma si scrive, appunto, per un popolo, mai per una élite… Il modello è stato il Convivio dantesco, direi.
Non suoni polemico: in realtà resto piuttosto freddo di fronte a divisioni così nette tra cultura ‘alta’ e cultura ‘popolare’, non ho buoni rapporti con Adorno, sono certamente migliori quelli con Benjamin e Bloch. Dell’Avant-pop mi affascinava proprio la possibile comunione di termini e ambiti apparentemente inconciliabili.
Le Avanguardie, peraltro, hanno sempre avuto un ottimo rapporto con le culture e le forme ‘pop’, quelle storiche, evidentemente, ma anche le Neo.
Vale per il Concretismo brasiliano (da Haroldo de Campos in avanti, sino alle splendide realizzazioni di Arnaldo Antunes) ma anche la Neo-avanguardia italiana, pure estremamente letteraria, è probabilmente più pop-friendly e multimedial-friendly di ciò che normalmente si creda.
C’è un’ombra sanguinetiana (ma vale anche per Giuliani) che non fa vedere abbastanza altro: dal multimedialismo accentuatissimo di un autore come Balestrini, all’oralità di Pagliarani mentre lo stesso Porta preconizzava un ritorno della voce e creava ottima poesia visiva.
Per non parlare dei più giovani, o più laterali: Da Costa a Spatola, a Vicinelli e Niccolai.
Definiresti Frank Zappa un autore ‘pop’? O Demetrio Stratos? O Miles Davis, Charlie Parker? Operazioni poetiche che si fondono volentieri con la musica, come quelle di Haroldo ed Augusto De Campos, di Horacio Ferrer, di Gil Scott Heron, John Giorno, o Linton Kwesi Johnson, sono cultura pop? E se lo sono, questo toglie qualcosa all’enorme impatto di rinnovamento che hanno avuto in ambito poetico e musicale?
Se mi si concede l’anacronismo, Arnaut era un trovatore, come Raimbaut, cantava, o meglio scandiva i suoi testi, ma si farebbe fatica a definirli esponenti di una cultura ‘pop’, eppure il loro canto monodico ne faceva, in qualche modo, autori che sarebbero risultati sospetti alla successiva esperienza musicale ‘colta’, spiccatamente polifonica .
A dispetto delle sue evidenti novità formali, una pièce come Sei personaggi in cerca d’autore gode da sempre di un grande successo di pubblico.
Può darsi che la Szymborska sia l’epifania della trasparenza, come crede Carabba, ma a me pare che abbia anche un impatto rivoluzionario e rinnovatore sulla tradizione polacca, magari non radicale come quello di Rosewicz, ma comunque evidente.
Mi rendo conto che in musica la separazione tra ‘pop’ e musica cosiddetta ‘colta’ è ancora piuttosto netto, per altro verso è innegabile che generi come il jazz, il rock e il punk-rock, il rock-progressive e per alcuni versi anche l’hip-hop abbiano prodotto risultati che implicano e inglobano in sé un livello di riflessione formale di altissimo livello.
So bene che la musica è andata ben oltre la ‘tonalità’, ma a me interessa molto, per le ragioni espresse prima, e quindi per la sua maggiore comunicabilità, lavorare su di essa, tentare un equilibrio nuovo tra parola e musica tonale, che non sia canzonetta, ma integralmente poesia. Far questo in una lingua ‘piana’ come l’italiano, che dunque non ha chiuse forti da accoppiare alle chiuse delle frasi musicali ‘tonali’, pone problemi pratici, formali e teorici piuttosto ardui, a maggior ragione se non si intende cantare, ma ‘scandire’, come credo debba fare la poesia.
L’innovazione formale non è sempre appannaggio di operazioni di nicchia, né fare operazioni di nicchia è garanzia che quello che si fa sia davvero ‘nuovo’, efficace, sperimentale.
Né credo sia corretto parlare di fumetto come arte pop: come accennavo prima, la riflessione formale, sui linguaggi, in atto oggi nel fumetto è anni luce avanti a quella che riesce a esprimere la prosa di romanzo, credimi… Fare Poetry comics significa sperimentare, non cercare un flusso mainstream in cui inserirsi.
Penso che questa ossessione ‘alto-formale’ e spesso ‘formalmente letteraria’ sia qualcosa che spinge alcune sperimentazioni e neo-avanguardie poetiche in campo simbolista. È una ricerca della forma per la forma che è fortemente ed evidentemente connotata storicamente. E non appartiene a Dada, piuttosto a Mallarmé e a D’Annunzio.
Con movimento paradossalmente identico, le collaborazioni di certi autori ‘sperimentali’ con la musica colta ne hanno fatto in realtà dei librettisti, come Sanguineti con Berio. Niente di male, ovviamente. Ma non è quel che intendo fare io. Io intendo ‘trobar’: la musica è parte integrante della mia ricerca poetica è una delle sue ‘forme’, anche quando nasce dalla collaborazione con musicisti veri e propri, come Nemola, Fresu, Salis, o Loguercio.
Insomma, il problema non è essere canta-poeta, ma far sì che la musica che si esegue sia già nella poesia, nei suoi ritmi, nelle sue melodie. È la musica che deve temperarsi con la parola: il Laborintus di Berio-Sanguineti è un’opera musicale, di cui Sanguineti è librettista, il Laborintus scritto è una splendida poesia di Sanguineti, una poesia nata per essere letta in silenzio, su carta.
Io non voglio scrivere testi per musica, fare il librettista, io cerco (insieme ai miei complici) la musica acconcia per le mie parole, musica per testi, anzi per orature. Cerco un nuovo ‘temperamento’ tra musica tonale e poesia contemporanea, dunque mi pongo problemi di metrica, di ritmo, di melodia, in una parola, di ‘durata’. Mi interessa riportare la poesia nel tempo.
Non credo certo che oggi sia possibile una poesia ‘orale’, tout court, ma mi piace lavorare sull’oratura dei testi scritti, sulla loro oralizzazione poiché ritengo che, per esistere davvero, una poesia debba essere comunque ‘eseguita’, fosse pure a mente, da un lettore.
La scrittura, infine, quella che utilizziamo per comporre poesia, è composta di ‘fonogrammi’, tutto nasce da un suono. E potrei continuare a lungo, magari annoiando te e gli eventuali lettori, preferisco rimandare tutti qui [http://www.inpensiero.it/archives/771 ], è uno scritto un po’ lungo, ma confido chiaro ed esplicito.
Non c’è nulla di ‘più facile’ in tutto ciò, anzi a me sembra faccenda piuttosto complessa.
Né ciò che faccio credo possa essere definito poesia sonora, si tratta di tutt’altro.
Credo fermamente all’affermazione di Zumthor che sostiene che in poesia non c’è parola senza voce, ma credo altrettanto che in poesia non ci sia voce senza parola.
Questo mi allontana radicalmente dalla poesia sonora, almeno da quella più ‘concreta’, penso, uno per tutti, ad Henri Chopin. Ma non credo affatto che essa sia morta, basti pensare alla indubbia qualità di esperienze contemporanee come quelle di Giovanni Fontana, Massimo Mori, o Enzo Minarelli e lo stesso Lamberto Pignotti, quando si dedica alla performance. Ed apprezzo profondamente il lavoro di molti poeti sonori nel mondo. E’ una ricerca diversa, tutto qua.
Come consideri, oggi, al di là del tuo lavoro, il panorama italiano in termini di contaminazioni tra generi, partendo soprattutto dalla scrittura poetica? È possibile individuare delle tendenze? Delle opzioni di fondo, tra i poeti che più spesso collaborano con altri artisti, musicisti o meno?
Il mio parere al proposito è piuttosto pessimista. Inutile ripetere qua cose già dette, più facile, visto che siamo in Rete, rimandare al mio intervento sul Corriere, qua [http://www.absolutepoetry.org/Voglio-vivere-in-un-altra-lingua ], e a quello su Satisfiction, dedicato alle nuove generazioni poetiche, che invece ora è qua [http://www.absolutepoetry.org/L-Italia-dei-poetini-di-Lello-Voce ].
A parte i fenomeni di trasformismo più smaccato su cui lasciami stendere un velo, o i dilettantismi sguaiati, su cui di veli ne stenderei due, credo che molto di buono ci sia e continui a svilupparsi, anche a livello editoriale.
Non sembri interesse privato in atti d’ufficio, ma mi pare che – ad esempio – quanto ha realizzato Andrea Cortellessa con la sua collana Fuori formato presso Le Lettere sia di eccezionale importanza, non solo perché ha finalmente messo a disposizione di tutti una messe enorme di scritti e materiali multimediali di autori importantissimi, ma censurati dall’editoria mainstream (Villa, Spatola, Vicinelli, Costa, Reta, Niccolai), ma anche per quanto ha saputo proporre di autori contemporanei, o comunque delle generazioni più recenti, Ottonieri, il romanzo di Baino, Bukovaz, Ventroni, giusto per fare qualche nome. Da tempo una rivista come inpensiero di Gianmaria Nerli porta avanti una ricerca internazionale appassionata e interessantissima, molto attenta alla contaminazione tra generi; festival come La punta della lingua, di Luigi Socci (poeta di valore anche in proprio) aprono spazi nuovi a nuove esperienze; gli Sparajurji e i loro Atti impuri continuano ostinatamente a cercare l’ago più pungente nel pagliaio di poetiche ed ipocrisie formali in cui ci dibattiamo, e poi l’opera individuale di tanti, meno giovani, Frasca, Lo Russo, la stessa Gualtieri, pur lontana da me a livello di poetica, Luigi Cinque con la sua ricerca sul ‘Cunto’ e le Identità selvagge, e più giovani, penso a Nacci, Garau, Raspini, Daino, Cera Rosco, Simonelli, Padua, Carrozzo, Bukovaz, la stessa Molebatsi, sudafricana, ma per lungo tempo udinese, per stare stretti al coté ‘orale’, o comunque di ‘contaminazione’ e potrei continuare a lungo, non se ne abbia a male chi non è citato.
Insomma la poesia italiana è viva, anche e soprattutto a livello di esperienze inter-mediali o, per usare una brutta parola, performative, ma la mancanza di spazi e occasioni rischia di ucciderla: la chiusura della collana di Cortellessa è segnale cupo, preoccupante.
Per quanto riguarda le tendenze in atto, il discorso è più difficile. Com’è in fondo comprensibile, la trasformazione mediale, la migrazione formale di cui è protagonista la poesia contemporanea, fanno sì che gli autori siano concentrati soprattutto sulle caratteristiche estetiche e comunicative del/dei medium. Non è tempo di manifesti, per noi, quanto di esplorazioni e di ricerche. Poi è evidente che, a guardar bene, anche se sia io che Gualtieri, o Lo Russo, per fare un esempio, apparentemente lavoriamo molto ‘vicini’ (sull’oratura), poi le differenze sono lampanti a livello di risultati finali.
Credo ovviamente che questa diversità sia una ricchezza, soprattutto a questo stadio di sviluppo della ricerca, ma è altrettanto evidente che gli equivoci sono acquattati dietro l’angolo, ma questa non è colpa dei poeti, piuttosto di una ‘critica ad una dimensione’, incapace di essere altro che filologia, in grado di studiare solo il testo e a volte neanche quello.
Questo non basta più, imho: occorre la nascita di una critica ‘poetica’, non solo letteraria e dunque non strettamente testuale.
Questo ci aiuterebbe (prima di tutto noi autori) a far chiaro su tendenze, orizzonti, possibilità, ma mi pare proprio che l’aria non sia questa, anzi tutto è più accademico che mai, o piuttosto integralmente giornalistico, nel mezzo (nel luogo cioè della ermeneutica vera, quella che fa i conti con il contemporaneo e ha nostalgia del futuro) mi pare ci sia poco, o nulla e gli studiosi più coraggiosi (Cortellessa, Giovannetti, Marrucci, La Via, Bello Minciacchi, Pianigiani, Manganelli, Zuliani, Barbieri, per fare qualche nome alla rinfusa, mescolando letteratura e musicologia) scontano spesso una solitudine e una noncuranza desolante.
Tu sei stato anche uno dei promotori dei Poetry Slam in Italia. Ho l’impressione, ma magari mi sbaglio, che la fase di gran successo della “forma Slam” sia in declino. Insomma, magari è passata la moda, il che non significa che la “forma Slam” in sé sia esaurita. Tu che bilancio fai di questa esperienza? Premetto che io non ho nessun a priori contro la “forma Slam”. L’impressione, però, che me ne sono fatto, considerando la mia limitata esperienza, soprattutto italiana, è che non sia una forma che permetta grandi sviluppi o sorprese sul piano artistico e poetico. Ma questo è ovviamente vero anche delle tradizionali e più monotone letture di poesia, che comunque si continuano a fare.
Credo anch’io che il Poetry Slam italiano sia in crisi profonda, e proprio nel momento in cui in Europa e nel mondo sta dimostrando tutta la sua capacità di stimolare e veicolare ‘forme’ poetiche nuove. Ma non tanto perché stia diminuendo la sua diffusione, anzi, si fanno sempre più Slam, a quanto vedo, o comunque imitazioni di ciò che io chiamo Slam.
No, il problema è altro: è la qualità, non solo la qualità delle poesie, ma proprio la qualità del medium, o se vuoi, del format.
Ovviamente questa è innanzi tutto un’autocritica: ho diffuso io per primo in Italia questa forma di spettacolo poetico e dunque non intendo certo tirarmi fuori dal mucchio.
Intanto non siamo stati capaci di sviluppare la ‘federatività’ dello Slam, un circuito vero e stabile che avrebbe, da sé solo, facendo da punto sinergico, da pettine a cui tutti i nodi sarebbero venuti, provocato un innalzamento dei risultati formali e poetici.
Tutto è rimasto molto disgregato, improvvisato, isolato dalle esperienze vicine. Questo ha fatto sì che lo Slam si diffondesse moltissimo, ma che non facesse ‘rete’, ciò lo ha reso spesso localistico, provinciale, invece che glocale e capace di tirar fuori il meglio che il mainstream escludeva.
Poi l’ubriacatura derivata dal suo successo ha indotto molti a svenderlo: da chi lo offriva come advertisement pubblicitario per la Mazzantini, a chi montava un ring sul palco, ad altri, molti altri, come costoro che ora vanno in giro a fare il Campionato italiano di poesia orale, che non hanno esitato ad affiancare alla giuria popolare una giuria di esperti, trasformando un’esperienza radicale come lo Slam in una sorta di ‘estemporanea di poesia’, in cui a decidere alla fine è il giudizio di questo, o quel maggiorente di parrocchiette poetiche spesso piuttosto piccole.
Si è molto puntato sulla competizione (dunque sui singoli poeti), assolutamente meno sulla comunità (dunque sul coinvolgimento attivo e responsabilizzante del ‘pubblico’), e potrei andare avanti a lungo.
Ma lo Slam italiano non è ancora morto e può dare ancora moltissimo, se ne fanno ancora di ottimi: paradossalmente gli stessi che hanno Slammato per la Mazzantini gestiscono un ottima venue di Poetry Slam a Torino, Poeti in Lizza, se ne sono fatti e se ne fanno di dignitossimi e spesso ottimi a Ancona, Trieste, Bolzano, Roma, Milano, Varese, Monza, ecc..
Certo che hai ragione quando sottolinei una crisi: forse è arrivato il momento di iniziare a riflettere tutti su modi, tempi, luoghi, prospettive dello Slam, che altrove già corre verso il futuro.
L’Europa e il mondo rischiano di lasciarci ancora una volta fuori della porta…
Come consideri, invece, l’esperienza di collaborazione con un video-artista come Giacomo Verde? Qui ti sei situato, mi sembra, su un terreno la cui ricezione, per l’Italia, è più difficile, e diciamo meno assimilabile a forme più pop d’arte. Ti sembra che esistano altri poeti che hanno lavorato in questi anni nella stessa direzione, o in ogni caso in collaborazione con artisti visivi.
È stata ed è una parte molto importante del mio tentativo di concepire la poesia come arte complessa, pluriversa, come avrebbe detto Francesco Leonetti.
Penso che il trittico di video “È meglio morire, che perdere la vita”, contenuto nel dual disc che accompagna L’esercizio della lingua, sia per me un punto di arrivo importante, anche perché ha potuto contare sui disegni (decine e decine di disegni originali) di un autore bravissimo come Robert Rebotti.
Ma anche in questo caso vanno fatti dei distinguo: io ho collaborato con Verde sin dall’inizio, chiedendogli di realizzare innanzi tutto delle video-scenografie live per le mie letture di poesie.
La prima volta in pubblico è stato a Venezia Poesia, accompagnati dalla tromba di Paolo Fresu, credo fossero i primi anni ’90.
In questo caso la funzione del video era molto particolare, sinergica, accompagnava e sottolineava il ritmo dello spoken word e i suoi contenuti più decisivi.
Al di là della mia storia personale, noto che questa è modalità che si è poi diffusa ampiamente.
Altra cosa è una video-poesia, un’opera che avendo per base una poesia, sviluppa poi forme video autonome, come nel caso del trittico che citavo prima, la cui autorialità resta, a mio parere, prima di tutto del regista, cioè di Giacomo Verde.
Altra cosa ancora sono le esperienze di ‘clip-poema’ come le definirebbe Augusto De Campos, che le pratica da decenni e decenni, in cui è il poeta stesso a scegliere, realizzare e montare le immagini.
La situazione è piuttosto complessa, come vedi, e a complicare le cose sono arrivati i cosiddetti book-trailer, prodotti di mercato, per il mercato, spesso puro advertisement. Ovviamente si possono fare ottimi book-trailer di libri di poesia, ma infine un book-trailer è una cosa ben diversa da una video poesia.
Questa confusione genera mostri come certe esperienze imbarazzanti, anche di poeti di valore, di cui non faccio nomi perché li ho già fatti altrove e sembrerebbe accanimento.
In ogni caso il fenomeno, in realtà, ha diffusione vastissima nel mondo ed ha una capacità di coinvolgimento molto ampia, anche di nicchie tendenzialmente sorde alla poesia: il numero impressionante di submissions ricevute ogni biennio dal tedesco Zebra Poetry Award, il più importante in Europa, e il vastissimo concorso di pubblico nei giorni della rassegna ne sono testimonianza. Ma ricordo anche il romano Doctor Clip che ha presentato prodotti ottimi.
Anche in questo caso ciò che latita, almeno in Italia, è la capacità ermeneutica, la voglia, da parte di critici e studiosi di percorrere strade nuove, lontane dai libri, ma non dalla poesia.
Per quanto riguarda i nomi – fatto l’omaggio dovuto a un innovatore indimenticabile come Gianni Toti – devo ripetere quello di Giovanni Fontana, in tandem con Antonio Poce, del gruppo Sparajurji, di Caterina Davinio, di Minarelli, per restare stretti a un ambito più strettamente poetico, ma se mi spostassi in ambito di autori video l’elenco sarebbe ben più lungo.
Tu sei stato animatore culturale e, sopratutto, hai diretto un festival di poesia. Che visuale hai, dopo tale esperienza, del rapporto tra artisti e istituzioni. Concretamente, che cosa è possibile fare per promuovere, con delle istituzioni pubbliche, e magari degli sponsor privati, proposte legate alle industrie culturali?
Qui è tutta la radice (politica ed economica) di molti dei mali di cui abbiamo discusso.
Da decenni ormai la politica italiana concepisce la cultura quasi esclusivamente come una macchina per produrre consensi e fare incetta di voti. Ciò fa sì che le nicchie si chiudano, che la ricerca e la qualità siano ignorate e a volte dileggiate, che le differenze siano esiliate.
La crisi economica, qui da noi più, molto più che altrove, non ha fatto che potenziare queste dinamiche distorte.
Si sta mettendo in moto un meccanismo di ‘trust’, di cartello: come in ogni crisi che si rispetti sopravvivono solo gli eventi più grandi, gli altri, cioè le diversità, spariscono.
Da questo punto di vista, penso che la modalità Occupy sia attualmente la sola praticabile, a meno di qualche miracolo, per produrre e gestire arte e cultura davvero indipendenti in Italia, utilizzando (o, meglio, recuperando, riciclando, trasformando) spazi pubblici e privati e sono per questo molto interessato ad esperienze come quella del Teatro Valle, o di Macao a Milano, ma anche a molte altre meno note, come S.A.L.E. a Venezia e tante, tante simili che stanno avvenendo in tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia.
Credo però che ancora non siamo stati capaci di ‘radicare’ realmente tutto ciò a livello politico e sociale. Credo, cioè, che dovremmo ripensare il presente con la memoria del passato più recente, quello dei CSO, nati da pulsioni prima di tutto politiche, ma che poi hanno sempre integrato le arti in maniera piuttosto efficace. L’esperienza del Nord Est è al proposito esemplare, anche se so bene che è stagione finita: le nuove da Berlino non fanno che confermarlo a livello anche europeo.
Questa è la prima volta che a partire sono gli artisti in prima persona: c’è una grande ricchezza in tutto ciò, ma anche un grande pericolo, se non sapremo rendere il nostro agire integralmente ‘politico’, cioè condividerlo con la polis.
Credo che l’arte sia non solo un ‘bene comune’, ma, oggi più che mai, un bene ‘di prima necessità’, sta a noi, però, se crediamo a questa tesi, far sì che essa sia compresa da porzioni sempre più vaste della società, altrimenti avremo perso, per l’ennesima volta, una grande occasione.
*
Su un punto da te toccato, vorrei replicare con una considerazione personale. Già un paio di anni fa, in un saggio che si può leggere su NI, ho proposto di ridefinire il campo della “poesia” con la formula “arti poetiche”, prendendo lo spunto da un amico poeta e editore francese, Michaël Batalla. Con questa proposta intendevo a mio modo difendere la concezione plurale e pluriversa della poesia, di cui anche tu parli citando Leonetti. Premetto, che la difesa di questa pluralità di dimensione e forma non è vista in un’ottica gerarchica: siccome la poesia per lettura silenziosa ha prevalso sulla poesia dell’oralità, allora invertiamo semplicemente i termini della gerarchia. Per me non ha senso dire che la poesia del XXI secolo deve essere più orale o più scritta, o deve totalizzare la forza della forma scritta e quella dell’energia orale, tanto per dire… L’idea delle arti poetiche, o semplicemente di “poesie” irriducibilmente plurali, pone secondo me tre questioni. Dal punto di vista dell’autore, di colui che fa ricerca nel campo poetico, si tratta di capire cosa più gli interessa fare e dove la sua ricerca si dimostra (innanzitutto per lui stesso) più efficace. Dal punto di vista critico, ciò che importa è valutare quali sono le realizzazioni più significative, importanti, all’interno di filoni diversi. Il problema non sta nel “preservare” la specie in estinzione poesia sonora, mettiamo…, ma nel chiedersi qual è oggi un poeta che fa apparire la poesia sonora come una forma potente, necessaria? Quanto al pubblico, è importante che esso possa avere la possibilità di incontrare la poesia sotto le fogge più diverse: nella plaquette, nell’oggetto-poetico-visivo, nella dimensione della poesia orale o cantata o ritmicamente scandita, o performativa, o multi-mediale, o installativa… Poi starà al pubblico, che è sempre eterogeneo e plurale, di reagire rispetto a questa pluralità di espressioni.
E su questo punto vorrei concludere. Tu hai fatto un’esplicita autocritica riguardo alla frammentazione dell’esperienza dello Slam poetry, che non ha permesso di creare una rete più stabile e articolata in Italia. Io sarei tentato di vedere in questa vicenda uno snodo culturale importante. Lo Slam poteva essere una proposta, capace di trainarne altre più articolate, legate a sperimentazioni e ibridazioni mediali, che andassero ben oltre la forma Slam. Così non è stato, e anzi nello Slam ha prevalso spesso l’aspetto più da intrattenimento, da cabaret televisivo. Parlo ovviamente del “format”, non della qualità o meno dei singoli partecipanti. Certo, è facile a posteriori dire che cosa si sarebbe dovuto fare. Ma a mio parere si è scelta una sorta di scorciatoia. Con quale risultato, oggi? Che siamo un po’ di nuovo al punto di partenza. E i tuoi interventi polemici a difesa della spoken poetry e della dimensione orale della poesia me lo confermano. Invece di aver “familiarizzato” il pubblico con la pluralità delle arti poetiche, siamo solo al declino dello Slam, o della sua “moda”, e dobbiamo nuovamente ricordare che la poesia non è solo quella roba scritta.
Ovviamente, non dico questo per affibbiarti qualche hegeliana responsabilità epocale. Primo, perché non è detto che una proposizione del fronte più articolato della poesia avrebbe incontrato interesse da parte di istituzioni, finanziatori, e pubblico in piazza. Secondo, perché si tratta di dinamiche culturali mai riconducibili alla volontà di un singolo, e che riposano su condivisioni ampie e collettive. Lo dico, semmai, perché ho la speranza che riprendere le fila di queste riflessioni e di queste pratiche, permetta di imparare dagli errori o dalle difficoltà incontrate in passato.
Credo che tu abbia ragione due volte.
La prima quando parli della necessità di non sostituire gerarchie nuove a quelle vecchie: il problema non è negare oggi alla poesia ‘muta’ quella legittimità che da decenni essa si ostina a negare a quella ‘oralizzata’ (e questo è dato di fatto, filologicamente inoppugnabile), il problema è precisamente quello di una complessità della forma poesia che oggi è la sua caratteristica principale e la sua principale qualità. L’ho detto chiaramente e molte volte, ultimamente nel corso di un lungo dibattito in rete con Daniele Barbieri.
Le scomuniche servono a poco, evidentemente, vale per me, ma vale anche per coloro che pensano di poter escludere certi autori dai loro ‘canoni’ proprio perché, facendo spoken word, a loro parere, sarebbero poeti ‘easy’, o ‘spettacolari’.
Per altro verso sarei più prudente nell’uso della parola ‘pubblico’, proprio perché è oggi importante iniziare a riflettere con acume e attenzione sulla poesia. La poesia ‘muta’ non ha pubblico, ha lettori. Va benissimo, ovviamente, ma non possiamo ignorarlo, se vogliamo analizzare correttamente il ‘pluriverso’ poetico odierno.
Hai poi ragione di nuovo quando ti riferisci allo Slam: abbiamo perso, o stiamo perdendo, una grande occasione, ci sono responsabilità di tutti, mie, di chi ha pensato di poter svendere lo Slam alla prima Mazzantini di passaggio, di chi monta ring sul palco, di chi si inventa giurie di esperti, ma anche di chi ha opposto un rifiuto bigotto, di chi ha giudicato sulla base di preconcetti polverosi, ecc… Ma poi credimi, certo Slam sta benissimo, di Slam se ne fanno a iosa, anche troppi e molti magari di pessima qualità.
Ciò non toglie che lo Slam è stato un momento importante nelle dinamiche poetiche ultime, esso ha riportato all’attenzione di moltissimi che esiste un aspetto ‘orale’, ‘performativo’ della poesia e che esso ha piena legittimità, innanzitutto formale.
Certo è che se non saremo capaci di rimetterci a riflettere insieme, nella diversità, ma con attenzione e curiosità per l’altro, senza farci sconti e senza farne ad altri, a nessun altro, difficilmente l’azione di un singolo, di una rivista, di un blog, potranno da soli cambiare le cose.
Ci serve fare rete. Comprometterci con l’altro, litigare, riflettere, perché la poesia nel mondo sta cambiando marcia, e mentre soffia il vento e infuria la bufera, lo sai, spesso, di colpo, gli esseri umani si accorgono di quanto, nonostante tutto, la poesia sia un bene comune di prima necessità. Un diritto che va, come avrebbe detto Pagliarani, ‘esercitato’ ed esercitato nella sua pienezza, formale, ma anche politica ed etica.